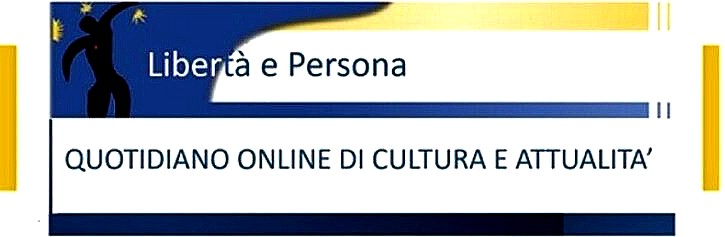Avvenire 6 Novembre 2025
Pubblichiamo parte dell’intervento che lo storico Gampaolo Romanato terrà oggi nell’ambito del convegno internazionale “A un secolo dall’Esposizione Missionaria Vaticana, spartiacque di un mondo glocale (1925-2025)”, organizzato in concomitanza del centenario della mostra missionaria da cui ebbe origine l’odierno Museo etnologico Anima Mundi, parte dei Musei vaticani. Per il giubileo del 1925 papa Pio XI volle organizzare nella Santa Sede una grande iniziativa per illustrare la diffusione delle missioni cattoliche nel mondo e far conoscere le tradizioni culturali, artistiche e spirituali di tutti i popoli evangelizzati. Il convegno è promosso dalla Pontificia Università Urbaniana e dai Musei vaticani
di Giampaolo Romanato
Importante nella politica di Pio XI fu la promozione delle missioni, la cui impostazione, in particolare in rapporto al sistema coloniale europeo, fu radicalmente ripensata dal suo predecessore con la celebre lettera apostolica Maximum illud del 1919. In piena continuità con Benedetto XV, il papa operò in una ottica di centralizzazione romana, trasferendo da Lione a Roma la direzione dell’Opera per la propagazione della fede, la potente organizzazione che raccoglieva in tutto il mondo cospicue masse di denaro veicolandole verso le missioni.
Centralizzazione significava più stretto controllo romano sul funzionamento del mondo missionario al fine di sganciarlo dalla cultura coloniale e dall’ipoteca che vi aveva sempre esercitato il governo francese, particolarmente in Oriente e in Africa. L’operazione incontrò molte e comprensibili resistenze, ma la volontà ferma del pontefice fu più forte delle opposizioni.
Seguì la grande esposizione missionaria che si svolse nei cortili vaticani nel 1925, che richiamò a Roma quasi un milione di visitatori mostrando per la prima volta, concretamente e con abbondanza di dati statistici, la diffusione planetaria del cattolicesimo. La successiva enciclica Rerum Ecclesiae (1926), che riprendeva l’analogo documento appena ricordato del predecessore, insistette molto sull’indigenizzazione del clero e dell’assoluta necessità dell’emancipazione delle missioni dalla subordinazione di interessi coloniali europei, come anche dalle gelosie dei vari ordini religiosi.
Al di sopra degli ordini missionari e delle ipoteche dei vari governi civili – affermò con forza il pontefice – agisce e sorveglia la Santa Sede attraverso la Congregazione di Propaganda Fide che fu dotata allora della nuova sede del Collegio Urbaniano sul Gianicolo. Non mi soffermo su questo tema ma non si può non far notare come in questo caso la Santa sede vide molto più lucidamente dei governi civili la direzione di marcia del mondo postbellico, che andava deciso verso la fine dell’egemonia europea e l’emancipazione dei paesi nuovi. Ricordo, e lo ricordo perché la cosa oggi può destare stupore nei più giovani, che al tempo di Pio XI la Chiesa cattolica, dal punto di vista gerarchico, era un fenomeno ancora esclusivamente europeo, L’America iniziava allora a far sentire la sua forza, mentre Asia e Africa erano ancora terre di missione, senza autonomia, gestite da clero europeo. Il loro cammino verso l’indipendenza, cioè verso l’indigenizzazione della gerarchia episcopale, iniziò con papa Ratti, che nel periodo del suo governo consacrò primi vescovi “autoctoni”, selezionati dal clero locale: cinesi, vietnamiti, indiani, giapponesi, indocinesi. In tutto saranno 37. Il tempo dei primi vescovi africani verrà nel 1939, con il suo successore. Per incredibile che oggi possa sembrare, solo cento anni fa la Chiesa extraeuropea, che oggi rappresenta più della metà del collegio cardinalizio, non aveva ancora nessuna autonomia. Il processo della sua emancipazione cominciò con Pio XI, che si dimostrò capace di tenere insieme due esigenze apparentemente divaricanti: la centralizzazione romana e la promozione di quelle che oggi chiamiamo le Chiese locali neri vecchi territori missionari.
Fu questa politica di Pio XI che rese possibile ai suoi due successori, Pio XII e Giovanni XXIII, di gestire senza lacerazioni la stagione gravida di pericoli e di incognite della decolonizzazione, della nascita di nuovi paesi che, nella geopolitica del secondo dopoguerra, si definiranno del Terzo mondo, creando le Chiese locali, cioè le unità periferiche di un organismo unitario e fortemente centralizzato, e immettendo gradatamente loro esponenti nel Sacro collegio cardinalizio. Il primo cardinale cinese fu creato nel 1946, il primo giapponese e il primo africano nel 1960.
Il difficile e controverso pontificato di Pio XI non è dunque caratterizzato soltanto dalla vexata quaestio dei suoi rapporti con i regimi totalitari, che finora ha prevalentemente attirato l’attenzione degli storici, che non ho toccato perché ci avrebbe condotti fuori dal tema di questo convegno, ma rappresenta un momento fondamentale nella ricostruzione novecentesca dell’edificio cattolico e quindi della ridefinizione della sua identità nel mondo contemporaneo.