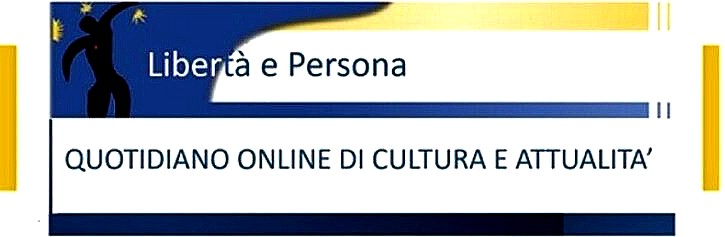Radici Cristiane n. 186 – settembre-dicembre 2024
Come affrontare il fenomeno migratorio senza ideologie? La Dottrina Sociale della Chiesa e la politica delineano criteri di accoglienza, integrazione e diritto a non emigrare. Una riflessione sulle priorità nazionali e il bene comune
di Giuseppe Brienza
È ormai chiaro ai ceti medi e popolari della maggior parte dei Paesi UE, stando all’esito delle consultazioni elettorali degli ultimi due anni che hanno premiato partiti e movimenti “sovranisti”, che gli Stati possono accogliere i migranti solo nella misura del possibile. Riguardo ai sistemi di welfare, la conseguenza più evidente di questa opzione è che la priorità per ogni comunità nazionale è quella in favore del cittadino, di origine/nascita o meno, e della sua famiglia. Solo poi vengono gli stranieri, europei o meno che siano…
I principi dell’accoglienza e della solidarietà applicati a fenomeni di massa come le migrazioni dell’ultimo mezzo secolo diventano quindi categorie politiche che, come tali, non possono che seguire i criteri della ragione politica. In definitiva, non si possono pertanto accogliere tutti né, tantomeno, si può accogliere tutto.
La solidarietà, quando diventa generalizzata (cieca, diremmo) non potrà che produrre danni. Un esempio? Le Organizzazioni Non Governative (ONG), quelle del mare in questo caso, sono diventate attori politici. Fingere quindi che siano tutte promosse e rappresentate da benefattori o che traggano i propri finanziamenti dai singoli cittadini significa disconoscere la realtà e, di conseguenza, abdicare al bene comune.
Tenere conto di questa verità – anche giudiziariamente appresa – permetterà di comprendere più e meglio che è vero che esiste e occorre riconoscere il diritto ad essere soccorsi in mare (o comunque, in generale, ad essere salvati se in pericolo di vita), ma questo principio non deve significare ammettere sempre e comunque il diritto assoluto ad immigrare.
Del resto la ragion politica non può basarsi sui sentimenti o sulle emozioni collettive, più o meno indotte. Colpiti dal bisogno di qualcuno, possiamo senz’altro accoglierlo nella nostra casa. Diventa però imprudente il volerne accogliere dieci, venti o trenta perché, in tal caso, la convivenza comune o quella della propria famiglia diventa impossibile. C’è, in conclusione, sia in capo ai singoli sia alle comunità, una responsabilità prima di tutto sui vicini (il “prossimo”) e, solo in seconda istanza, sui lontani.
Naturalmente c’è il bene comune dei migranti, ma c’è anche quello delle comunità da cui essi migrano ed anche quello delle nazioni che li accolgono. Inoltre, il bene comune è un fine che non può ammettere ogni mezzo, come per esempio la tratta di esseri umani e/o la pianificazione delle morti in mare. Il criterio dell’accoglienza indiscriminata riduce il senso del bene comune ed è di fatto una abdicazione alla ragione politica.
Il bene comune di una comunità nazionale, com’è evidente sposando una concezione non ideologica dell’immigrazione, ha delle priorità e, pertanto, un principio generalizzato e non controllato di “accoglienza” dei migranti, potrebbe portare danno alle persone e alle famiglie, in primo luogo, quelle più dipendenti dall’aiuto materiale del Paese che accoglie.
D’altro canto, se esiste un diritto (non assoluto) a emigrare esiste anche – e forse prima – anche un diritto a non dover emigrare perché spinti da miseria, persecuzioni o magari da operazioni pianificate e imposte per altri motivi.
Per molti cittadini di Paesi poveri emigrare non è una libera scelta, ma l’unica scelta. Giovanni Paolo II ha per primo proclamato in tutta la sua chiarezza il diritto a non emigrare come diritto umano fondamentale valido allo stesso livello di quello ad emigrare.
Di questo “diritto a non emigrare”, annoverabile ormai a principio della Dottrina Sociale della Chiesa (DSC) sull’immigrazione (attuale), ha parlato più volte anche Benedetto XVI sostenendo che esso consiste nel vivere personalmente e con la propria famiglia nella condizione di poter rimanere nella propria terra per scolarizzarsi, lavorare, inserirsi socialmente e, infine, trasmettere la propria esperienza alle future generazioni.
A tal proposito nell’enciclica Caritas in veritate (2009) Papa Ratzinger ha affermato (n. 62) che l’emigrazione moderna è una questione epocale, che non può che rispondere a molteplici esigenze, quelle delle famiglie emigranti così come quelle delle società che ospitano, tenendo naturalmente conto che l’emigrante non è una merce e che apporta comunque un contributo allo sviluppo del Paese ospitante.
Ricordiamo che il diritto a non emigrare è stato considerato prioritario negli scorsi decenni da molti vescovi africani che hanno cercato di dissuadere i propri fedeli ad emigrare. Ma il diritto a non emigrare imporrebbe il compito di disincentivare le partenze prima di tutto da parte degli Stati sia di partenza sia di accoglienza.
Compito non facile, certo, perché implicherebbe il voler guardare in faccia e dichiarare guerra ai veri “mandanti” dell’immigrazione di massa, ovvero poteri sotterranei e senza scrupoli espressione o comunque collegati con la delinquenza organizzata più violenta e facoltosa.
Ultimo concetto necessariamente da precisare performarsi un’opinione non ideologica sull’immigrazione è quello dell’integrazione dei migranti.
Integrazione è una parola molto usata che, se non precisata e adeguatamente contestualizzata, rischia di restare vuota e, di conseguenza, disattesa. Anzi, può diventare un pericoloso concetto ideologico se, in radice, vieta di considerare:
1) se e quanti migranti è possibile/necessario integrare;
2) se e quanti siano integrabili in relazione alla loro religione e cultura e, infine,
3) quanti degli stranieri vogliano davvero integrarsi (v. islam).
Porsi queste domande e affrontarlepoliticamente evita di imporre ai popoli l’assunto immigrazionista secondo cui tutte le società di accoglienza debbano sempre e comunque integrare, a costo persino di trasformarsi e cambiare di identità a seguito della c.d. integrazione. Senza presupposti realistici questo tipo d’integrazione (in realtà disarticolazione sociale) diventa un’utopia e, infatti, nell’Europa dell’integrazione a tutti costi spesso non prevalgono le società integrate ma una balcanizzazione di comunità chiuse e di Stati nello Stato, con leggi, economie e sistemi di solidarietà propri.
In proposito il Catechismo della Chiesa Cattolica (1992) scrive: «Le nazioni più ricche sono tenute ad accogliere, nella misura del possibile, lo straniero alla ricerca della sicurezza e delle risorse necessarie alla vita, che non gli è possibile trovare nel proprio paese di origine. I pubblici poteri avranno cura che venga rispettato il diritto naturale, che pone l’ospite sotto la protezione di coloro che lo accolgono. Le autorità politiche, in vista del bene comune, di cui sono responsabili, possono subordinare l’esercizio del diritto di immigrazione a diverse condizioni giuridiche, in particolare al rispetto dei doveri dei migranti nei confronti del paese che li accoglie. L’immigrato è tenuto a rispettare con riconoscenza il patrimonio materiale e spirituale del paese che lo ospita, ad obbedire alle sue leggi, a contribuire ai suoi oneri» (n. 2241).
Se l’immigrazione è diventata un’emergenza ingovernabile è anche perché i Governi hanno tenuto poco o nulla conto di questi insegnamenti della DSC, il cui approccio – lontano da certi luoghi comuni su solidarietà e accoglienza – fa luce con realismo cristiano sui vari aspetti di un complesso fenomeno che avrà presumibilmente le sue proiezioni per almeno un secolo.