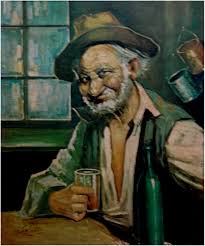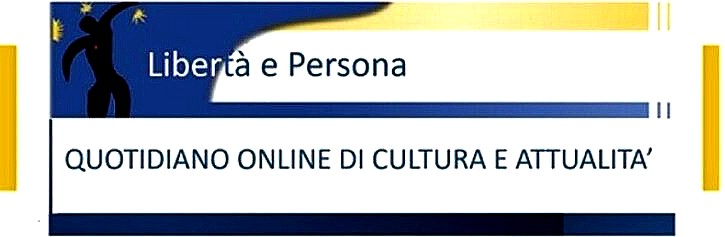Tradizione Famiglia Proprietà Newsletter 7 Agosto 2027
di Nelson Ribeiro Fragelli
Quando il pensatore cattolico brasiliano Plinio Corrêa de Oliveira rifletteva sugli eventi avvenuti a San Paolo durante la sua infanzia all’inizio del secolo scorso, le abitudini sociali di quel tempo attiravano particolarmente la mia attenzione. Parlava della gioia della vita familiare e i suoi racconti vivaci trasportavano la mia immaginazione in quei tempi passati che non ancora stati conquistati dall’adorazione delle novità degli anni successivi, come la velocità e l’industria o il comportamento stravagante di molte persone negli ultimi decenni del XX secolo, che hanno segnato uno sgradevole cambiamento culturale.
Tra le immagini presentate dal professor Corrêa de Oliveira, la cortesia a tavola secondo la tradizione era particolarmente sorprendente per la logica e la compostezza delle procedure e delle disposizioni. Le storie erano utili, poiché insegnavano con discrezione le buone maniere. Non si trattava di astenersi dalla spontaneità modaiola ma volgare trasmessa dalla modernità invasiva.
Le regole del galateo a tavola erano importanti. Tuttavia, il professor Corrêa de Oliveira ha cercato di sottolineare il substrato cattolico che allora era alla base della mentalità della gente. Aleggiava il consiglio evangelico: «Perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro» (Matteo 18,20). La filosofia del Vangelo permeava così tanto le menti che anche coloro che si dichiaravano cattolici non praticanti o atei ne seguivano naturalmente i dettami.
A quei tempi, i bambini dovevano frequentare il catechismo e i consigli evangelici venivano in aiuto delle semplici raccomandazioni casalinghe: «Non appoggiare i gomiti sul tavolo, non riempirti troppo la bocca, fai attenzione quando starnutisci, ecc.».
Il vigore dei sapori genera un vigore nella conversazione.
La Chiesa dava alla tavola un significato sacro; al di là della convivialità, una presenza religiosa permeava i sapori e le conversazioni. Questa convivialità aveva un segreto noto a tutti ma mai menzionato: l’interazione discreta e sorprendente tra gli argomenti discussi e l’elaborazione dei piatti. Sulla tavola tremolava la luce delle candele nella stanza ben addobbata. Un’altra fiamma invisibile agli occhi animava le anime: accesa in cucina nel forno e nei fornelli, chiariva il principio dinamico della conversazione perché da lì provenivano i sapori che, preparati con cura, favorivano l’affrontare di vari argomenti, stimolavano il vigore delle persone, ispiravano nuovi temi, davano entusiasmo alle osservazioni ed elevavano i commenti a considerazioni più elevate.
Infatti, i sapori hanno un linguaggio proprio, capace di commuovere gli animi e forniscono un vigore che genera quello delle conversazioni. Questo era il principio arcano, non esplicitato, commentato solo attraverso sguardi, espressioni flemmatiche monosillabiche ed esalazioni di umorismo. I grandi salotti francesi (1)1 avevano una regola fatta per essere infranta: i piatti non dovevano essere commentati. Una volta infranta quella regola, la conversazione si animava. Alcuni piatti, che tutti consideravano gustosi oltre ogni dire, richiedevano che lo chef entrasse in sala alla fine del pasto. Quando tutto era finito, le fiamme dei candelabri venivano spente mentre i sapori ancora ardenti aleggiavano nella memoria degli ospiti.
Nei circoli sociali più modesti, la natura dei pasti era la stessa, ma venivano consumati secondo le abitudini di ciascuna famiglia. Il giovane Plinio visitava spesso le case dei giardinieri, degli autisti o degli immigrati che lavoravano per la sua famiglia o i suoi parenti. Cominciò a discernere le famiglie in base al loro gusto nell’arredamento e persino all’odore all’interno di ciascuna casa.
Poiché la vita era molto meno frenetica di oggi, la televisione non esisteva e i cellulari erano ancora lontani settant’anni, l’ambiente allora tranquillo di San Paolo contribuiva a preservare la serietà dei pasti. “Benedici, o Signore, questi tuoi doni che stiamo per ricevere dalla tua generosità, per mezzo di Cristo, nostro Signore. Amen”, sentiva dire a una famiglia con interessi affini a quella sua. Era la stessa preghiera che suo padre recitava all’inizio del pranzo. Sentiva che quella supplica saliva al trono della Divina Maestà proprio mentre il profumo dello stufato sul tavolo stuzzicava il suo appetito.
Uno stile di vita cristiano forgiato nel corso di molti secoli in un’atmosfera di insegnamento cattolico ha dato origine a una filosofia che, secondo sosteneva il professor Plinio Corrêa de Oliveira, era l’espressione sociale dei principi teologici della Scolastica. Questi principi hanno plasmato le norme sociali, il galateo e i gusti della gente.
Un modo di essere che conduce al più alto e al più attraente.
Lo scopo dei sapori nella civiltà cristiana è quello di suscitare, attraverso un piatto gustoso, una piacevole sensazione di ammirazione o ispirazione nella mente. Si giudica un bel quadro dal soggetto raffigurato sulla tela, dall’adeguatezza dei colori o dal talento del pittore. Apprezziamo un buon piatto con un procedimento simile. L’arte della cucina consiste nel saper trattare un elemento commestibile secondo determinati ingredienti per ottenere un gusto piacevole. Questo trattamento richiede intelligenza ed elevazione dello spirito.
I popoli cristiani hanno raggiunto l’eccellenza culinaria. Nessuna civiltà ha raggiunto il grado di sviluppo culturale della civiltà cristiana. Fin dall’Antico Testamento, precursore della Santa Chiesa Cattolica, l’importanza data al cibo ha portato allo sviluppo di gusti secondo la giusta filosofia. Ci sono molti segni di questa importanza: il primo miracolo di Nostro Signore Gesù Cristo che trasformò l’acqua in vino; chiamò gli Apostoli il sale della terra; moltiplicò i pani per le moltitudini; lasciò la Sua Presenza Reale nella Chiesa sotto forma di pane e vino, che evocando il palato, la Chiesa canta che le specie eucaristiche contengono “tutte le delizie”.
Così, il Salvatore seguì l’esempio di Suo Padre, che determinò meticolosamente la composizione dei pasti solenni o penitenziali per gli Ebrei e li nutrì con la Manna contenente tutte le delizie gustative. Nulla diventa così intimo per una persona come il cibo che s’integra nel suo corpo.
La cucina ha un’influenza immensa sulla psicologia e sulle abitudini umane, data la frequenza quotidiana dei pasti. Ogni sapore risveglia nell’anima l’appetito per la virtù o per il vizio. Il gusto del buon vino, riteneva il professor Corrêa de Oliveira, risveglia il senso dell’onore, mentre il gusto del pane ravviva il senso dell’onestà. Il Creatore ha voluto che ogni alimento influenzasse la mente e la rendesse ricettiva all’insegnamento morale. Da qui la sacralità dei pasti così accuratamente insegnata dalla Chiesa.
L’elaborazione degli stili culinari, che variano molto, ritrae un ideale sociale in linea con quei gusti. Si parla giustamente di una “filosofia del gusto”. Parte di questa elaborazione è un modo di essere non esplicito, che sta alla base della mentalità di ogni nazione e ne orienta l’elaborazione dei piatti. La tavola rifletteva l’ascesa morale di un popolo, che creava ricette che fanno la storia del buon gusto. In tempi di rovina morale, la tavola esprime anche lo stato d’animo della popolazione. La tavola odierna mostra molti segni dell’attuale declino morale della nostra società. Tali segni sono più evidenti nelle tavole francesi, che hanno portato la qualità della preparazione dei menu al suo apice, cosa riconosciuta in tutto il mondo.
Un esempio significativo di come lo stato d’animo delle persone influenzi il gusto di ciò che mangiano si trova nel libro Gastronomia francese: storia e geografia di una passione, scritto da Jean-Robert Pitte, membro dell’Accademia Francese di Lettere. Pitte si chiede perché i sapori creati dalla gastronomia dei paesi cattolici siano superiori a quelli della cucina dei paesi protestanti.
Tra questi paesi possiamo citare la Francia e l’Italia, i cui piatti, pane, formaggi e vini sono considerati di prim’ordine. D’altra parte, ci sono l’Inghilterra e i paesi scandinavi. La ricerca scientifica e accurata di Pitte conclude che la superiorità della gastronomia cattolica deriva dal sacramento della confessione . La confessione lenisce la coscienza del peccatore e la penitenza imposta dal confessore gli dà la certezza di aver saldato il proprio debito con il Redentore. Al contrario, negare il sacramento della confessione lascia il protestante nell’incertezza di essere stato perdonato e di aver saldato il suo debito con il Redentore. Egli sopprime allora frettolosamente il legittimo piacere di una buona tavola, considera peccaminosa la qualità di ciò che mangia e rende il cibo meno appetitoso per non cedere al suo legittimo piacere. Questa è la sua “eresia” culinaria.
Perché il declino attuale è così evidente, soprattutto in Francia, la “casseruola” dei grandi sapori? È naturale che l’alto livello francese denoti il declino della qualità culinaria, poiché la natura della perfezione esige integrità. Quindi, per quanto piccole, le mutazioni dannose all’integrità della perfezione sono immediatamente evidenti. D’altra parte, i cambiamenti nuovi e dannosi non saltano immediatamente alla vista e le graduali alterazioni diventano accettabili.
La mentalità egualitaria e volgare causa il declino
La tavola ha permesso ai pittori di raffigurare scene, fissando sulle loro tele immagini di un’epoca, dei costumi, dell’abbigliamento e della cortesia. Ad esempio, le rappresentazioni pittoriche dal XIX al XX secolo mostrano la pomposa solennità dei banchetti viennesi alla corte imperiale, l’intimità dei pasti borghesi, l’onesta gustosità dei pasti contadini e persino un picnic informale sull’erba o in un bosco ombroso.
Nel suo libro La vita quotidiana nella Vienna di Mozart e Schubert, Marcel Brion descrive i banchetti nuziali di mendicanti famosi nel centro della capitale austriaca. Anche i mendicanti avevano uno stile di vita tipico dell’epoca, che fondeva la fede con le usanze sociali. Anche loro avevano un semplice fasto, di cui il buon cibo era un ingrediente indispensabile. Chi si dilettava di più: i poveri di Vienna che festeggiavano il loro matrimonio al suono dei minuetti di Mozart o i clienti dei fast food che mangiano al ritmo del rock’n’roll?
L‘imposizione dittatoriale dell’ecologia sulla culinaria
I francesi, che vedono la loro cucina come un riflesso della loro azione civilizzatrice, sono rimasti sbalorditi da una notizia apparsa sul loro principale quotidiano, Le Monde, il 16 maggio 2024. La Francia ora importa farina di grilli dal Vietnam per preparare i propri piatti. La passione dei francesi per l’evangelizzazione del Vietnam ha dato ad esso la fede cattolica e anche tracce luminose della sua cultura. Oggi, il regime comunista al potere, fedele ai suoi principi di demolizione del cristianesimo, sta diffondendo l’anticultura. I produttori di grilli essiccati vedono un mercato promettente in Francia perché il sessanta per cento di questa farina viene iniettata nel cibo umano oltre che in quello animale, per la gioia dei guru dell’ecologia neo-marxista che vedono nei grilli una forza rigeneratrice.
La Thailandia e la Cambogia hanno iniziato a utilizzare questa farina, ma solo per nutrire gli animali. Le Nazioni Unite (ONU) hanno aderito alla moda dei grilli, prevedendo che gli insetti finiranno per sostituire il manzo, il maiale e il pollo. Ancora una volta, adducono considerazioni economiche: i grilli sono molto più economici da allevare rispetto al bestiame o al pollame, non inquinano l’atmosfera e godono di simpatia ecologica. Centocinquanta tonnellate di grilli producono trenta tonnellate di farina. Tutto sta nella quantità di nutrienti contenuti nei grilli. I grilli provenienti dalla Cina, senza alcun controllo di qualità, sono utilizzati solo per l’alimentazione animale. Poi, affermano questi “saggi”, l’’introduzione dell’intelligenza artificiale migliorerà la produzione,
Il balzo in avanti delle Nazioni Unite non poteva lasciare indietro l’Unione Europea (UE), sua fervente concorrente nella corsa allo smantellamento delle caratteristiche cristiane del vecchio continente. Nel 2018, la leadership dell’UE ha incluso gli insetti tra i “nuovi alimenti” commestibili dall’uomo. La decisione ha suscitato gioia in Vietnam, che ora si affretta a lavorare i grilli che possono essere venduti “congelati, liofilizzati o in polvere”. Un vantaggio per chi è a dieta dimagrante: la farina di grilli è priva di grassi.
Con loro grande sorpresa, al momento della registrazione erano già stati approvati per il consumo umano il verme giallo, il coleottero bufalo e il grillo migratore. L’industria francese “Ynsect” è leader nel mercato degli insetti commestibili. Secondo l’istituto di ricerca sociale Mordor Intelligence, il volume totale del commercio d’insetti commestibili dovrebbe raggiungere i 9,04 miliardi di dollari entro il 2029. Secondo il quotidiano francese, i produttori vietnamiti stanno ricevendo un numero crescente di ordini di farina.
Farina nascosta
Alcuni paesi continuano a opporsi culturalmente ai tentativi di introdurre prodotti alimentari a base di insetti. Tuttavia, la propaganda su questi ultimi è tale che l’avversione sta diminuendo. In Spagna, la farina d’insetti è nascosta nella produzione di pasta, in Germania negli hamburger e negli Stati Uniti circolano già i biscotti al grillo.
I grilli hanno agenti pubblicitari aggressivi che promettono proteine e dollari. La loro farina è redditizia perché se ne approfitta di tutto: ali, interiora, zampe, antenne, pungiglioni, uova, ecc. In particolare, le sue corna. Secondo l’Organizzazione per l’alimentazione e l’Agenzia delle Nazioni Unite specializzata nella sicurezza alimentare, l’allevamento dei grilli è più agevole di quello del bestiame.
Decimare le fondamenta della civiltà
Nella sua misericordia, Dio ha creato queste specie piccole, appena percettibili alla vista. Tuttavia, le immagini ingrandite delle loro forme mostrano quanto siano orribili. Se fossero grandi come un gatto o un cane, terrorizzerebbero tutti. Certe raffigurazioni dell’inferno dipingono i demoni sotto forma d’insetti. I culti pagani li usavano come immagini dei loro dei. Infatti, secondo la FAO, gli insetti sono consumati principalmente in Asia, dove alcuni animali essenziali per un’alimentazione sana sono considerati sacri dal paganesimo e intoccabili.
Il desiderio dell’ONU – a questo essa serve – è quello di riunire tutte le nazioni orientando le loro istituzioni nazionali secondo una filosofia atea ed egualitaria opposta alla civiltà cristiana. Sulla stessa linea si capiscono certe innovazioni culinarie prive di buon senso.
La città di Lione è giustamente considerata la capitale della cucina francese. Grandi chef vi hanno offerto le loro deliziose creazioni diventando famosi. Il 25 maggio 2024, sempre su Le Monde, si parlava di un nuovo movimento tra gli chef lionesi. Questa corrente di protesta si definisce desiderosa di «entrare nella modernità» ribaltando le tradizioni culinarie e avventurandosi nell’ignoto. I gusti dei quartieri popolari ispirano i loro cambiamenti; essi esaminano attentamente i menu degli immigrati e creano “miscele audaci”. Il loro percorso è l’opposto di quello che ha cercato e ottenuto la quintessenza culinaria francese. Il gusto non francese degli immigrati non rifletterà più l’anima cristiana di questo popolo. Le “miscele audaci” risultano in sapori caotici.
Quando i clienti entrano in uno di questi ristoranti innovativi, guardano il menu e non capiscono cosa sta succedendo. Leggono e rileggono e chiedono: cosa sono questi piatti? Cosa sono questi ingredienti? Gli chef innovativi, mettendo in discussione lo splendore della cucina francese, devono spiegare ai loro clienti cosa mangeranno. Questi piatti si basano su una filosofia nuova e decadente, la filosofia di questo secolo.
L’amore per la natura o il rispetto ecologico per l’antico paganesimo non potevano mancare nella creazione dei nuovi sapori. Si tratta di pasti coreografati in fusione con la natura. Si dice “coreografati” per non dire “ecologici”, perché l’ecologia, in forte declino nell’opinione pubblica europea, ha bisogno di ogni tipo di sostegno. Una presentazione coreografata di un pasto comprende, ad esempio, sei piccoli piatti pieni di erbe selvatiche dal sapore detestabile. Alcuni clienti ignari, desiderosi di stare al passo con la modernità, li mangiano per sbaglio.
In Francia, l’innovazione dei “sapori dell’infanzia” fallisce
Clément Higgins, un talentuoso trentaseienne, ha aperto una pasticceria a Marsiglia. Sulla scia delle mode ha intrapreso anche lui la strada incerta delle invenzioni stravaganti come il “croissant ghiacciolo”. I primi clienti hanno acquistato i suoi prodotti, ma poi si sono insospettiti e non sono più tornati. L’attività non ha avuto successo. Per mettere a frutto le sue capacità, Clément è tornato alle ricette tradizionali che sono state molto apprezzate. Ha cominciato a chiedersi: perché i sapori tradizionali piacciono? Risposta: perché i sapori tradizionali offrono inconsciamente stabilità e certezza in un mondo frenetico e incerto.
Le persone gioiscono quando incontrano espressioni della cultura in cui sono cresciute, perché risvegliano in loro ricordi d’infanzia. Si rallegrano delle espressioni di un tempo, quando regnavano la logica e le sue virtù. Le nuove creazioni, pensate per sorprendere e attirare con un entusiasmo chiassoso, rimangono invendute. «I sapori semplici richiedono molto lavoro», afferma Clément, che ora possiede quattro pasticcerie a Marsiglia e una filiale ad Aubagne.
“Cucina di consolazione”
Questo è il titolo di un recente libro di Stéphanie Schwartzbrod, commentato su Le Monde del 3 giugno 2024 in un articolo di Léo Bourdin. Forse Schwartzbrod non conosce Clément Higgins, ma il suo pensiero ha le stesse basi: «La tavola non significa solo banchettare per soddisfare la fame. Significa stabilire un legame con qualcosa di più profondo e invisibile». Entrambi sostengono la filosofia cattolica che ha dato splendore alla tavola e riprendono l’idea del professor Plinio Corrêa de Oliveira presentata nella prima parte di questo articolo. Questa filosofia riflette il pensiero guida della cucina classica francese, oggi minacciata dall’accettazione degli insetti o da un folle desiderio d’innovazione controculturale.
Il giovane Clément ha stabilito il legame simbolico tra i sapori e l’infanzia. Stéphanie lo stabilisce con la nostalgia del trascendente e, finalmente, da Dio. La tavola ci ricorda lo spirito cattolico quando prega: ad caenam vitae eternae perducat nos Rex aeternæ gloriae – che il Re della gloria eterna ci conduca alla cena della vita eterna. Amen!
Note
1) I salotti, nati nella Francia dell’inizio dell’età moderna, erano incontri sociali e intellettuali di personaggi illustri che si tenevano nelle case di personalità di spicco arricchiti di saporose prelibatezze.
Fonte: Tfp.org, 4 agosto 2025.Traduzione a cura di Tradizione Famiglia Proprietà – Italia.