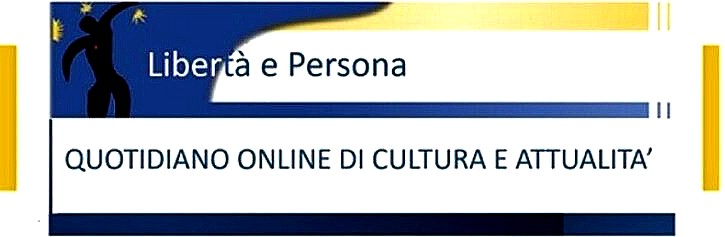Alta Terra del lavoro 9 Luglio 2025
Che differenza corre tra termini come tradizionalista, reazionario, conservatore, moderato? Sono semplici sfumature o si tratta di distanze notevoli? Per affrontare questo problema, vi presentiamo in anteprima la prefazione del volume di Francesco Leoni, Il pensiero controrivoluzionario nella storia d’Italia, di prossima uscita per i tipi di Solfanelli (Chieti). Ringraziamo l’Editore per la cortesia.
Lo studio del pensiero tradizionalista negli scorsi decenni (per non dire da un paio di secoli a questa parte) è stato vittima ed ha nel contempo alimentato una confusione terminologica, tuttora esistente, che ha portato ad utilizzare indifferentemente i vocaboli di reazionario, conservatore, controrivoluzionario, antirivoluzionario, ultramontanista, codino, papista (questi ultimi spesso usati a mo’ di insulto) (1), come se fossero sinonimi. Ma sinonimi non sono.
Le seguenti brevi considerazioni – necessariamente da estendere in altro scritto più corposo – cercheranno di intraprendere un percorso per raggiungere la massima chiarezza terminologica possibile, pur nella consapevolezza che alcuni vocaboli possono modificare il proprio significato nel tempo.
Metodologia della rivoluzione
Partiamo dal termine rivoluzione e dall’aggettivo derivato: rivoluzionario. Il Grande dizionario della lingua italiana (il “Battaglia”), come terzo ed estensivo significato di quest’ultimo, indica: Profondamente innovativo nei confronti della tradizione nell’ambito di un’attività artistica, letteraria o speculativa (un concetto, una teoria, un’opera o una sua caratteristica).
Il passaggio del concetto di rivoluzione dalla sfera politica (limitata quindi in particolar modo alla storiografia) a quella artistica e tecnologica (estesa al mondo degli oggetti di uso quotidiano) ha comportato una trasformazione in senso positivo della percezione dell’aggettivo rivoluzionario (e di conseguenza del sostantivo di riferimento), non più legato al sommovimento radicale dell’ordine tradizionale, bensì all’innovazione, sottintendendo un intrinseco miglioramento dell’oggetto in questione: novità rivoluzionaria (2), un tempo indicante il mutamento dello status quo (ovviamente in peggio), adesso indicano modifiche aprioristicamente intese come migliorative.
In realtà il concetto di rivoluzione (al di là dei fini proposti e dei risultati raggiunti) è – metodologicamente parlando – intrinsecamente legato alla volontà di fare tabula rasa e di ricominciare ex nihilo, ovvero di distruggere tutto l’esistente e ricostruire da zero, addirittura cominciando dal calendario (3), a differenza del modus operandi, ad esempio, della sana ricerca scientifica, per cui le innovazioni si innestano sulle ricerche precedenti, con una metodologia tipicamente tradizionalista (prendere il meglio del passato e cercare di migliorarlo ulteriormente) (4).
In principio era l’Ordine
E chi si batte contro la rivoluzione? Spesso si parla di “Rivoluzione e Controrivoluzione”, ponendoli sempre in tale sequenza, corretta ma incompleta. Infatti, cronologicamente (e logicamente) parlando, la Rivoluzione non è uno stadio iniziale, bensì successivo e contrapposto a uno stato preesistente di Ordine (il kosmos). A differenza di quanto suggerivano i miti greci («Nel principio era il Caos»), la nostra cultura fa iniziare la storia con un concetto opposto: «In principio era l’Ordine», il Kosmos o, evangelicamente, il Logos («ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος», recita appunto il prologo o initium Evangelii secundum Ioannem letto quotidianamente nella versione latina al termine di ogni Messa).
L’Ordine, quindi, precede sempre la Rivoluzione (ovvero il Disordine). La Controrivoluzione (cioè «il contrario della Rivoluzione e non una Rivoluzione contraria», per citare Joseph de Maistre) segue, cronologicamente (e logicamente) la Rivoluzione, ma non postula altro che un “ritorno all’Ordine”.
Quest’ultimo elemento, la Controrivoluzione, è un aspetto quasi naturale della ricerca dell’Ordine e del conseguente rifiuto del Caos. Infatti, ovunque (o quasi) la Rivoluzione abbia cercato (spesso poi riuscendovi pienamente) di distruggere l’Ordine, si è comunque avuto un tentativo di ritornare allo status iniziale: partendo dallo schema classico della “struttura restaurativa” proprio della drammaturgia per arrivare alle varie Insorgenze (antigiacobine, antinapoleoniche, antibolsceviche, etc.), di fronte alla rottura dell’iniziale situazione di (perlomeno maggiore) serenità segue spontaneamente il tentativo di ristabilire il modello primigenio.
Quindi, anziché della dicotomia “Rivoluzione-Controrivoluzione” si dovrebbe parlare di “Ordine-Rivoluzione” o, meglio, della triade “Ordine-Rivoluzione-Controrivoluzione” oppure “Ordine-Rivoluzione-Antirivoluzione” (5).
Non ci troviamo però di fronte alla triade hegeliana di tesi-antitesi-sintesi in cui un elemento genera il proprio opposto e trova alfine una conciliazione con esso: non può infatti esistere alcun compromesso (cioè alcuna sintesi) tra Ordine e Rivoluzione: la sintesi hegeliana è evolutiva, cioè tende a realizzare uno sviluppo (A-B-C), l’antirivoluzione invece è restaurativa, cioè punta a tornare alle origini (A-B-A). Per questo la cosiddetta (impropriamente) “Restaurazione” del 1815 altro non è che una sintesi conservativa della maggior parte degli effetti della rivoluzione francese e della conseguente occupazione napoleonica (6).
Va peraltro constatato che l’antirivoluzione – storicamente parlando – ha quasi sempre (se non sempre) fallito. Infatti, anziché realizzare il ritorno alla situazione originaria (A-B-A), i movimenti controrivoluzionari (dalla Vandea alla Cruzada) hanno al massimo raggiunto il risultato di moderare, limitandoli, gli effetti della rivoluzione e spesso di conservarli (cioè A-B-C, se non A-B-B♭ [bemolle o minus] o direttamente A-B-B, cioè mantenendo sempre l’effetto rivoluzionario, solo un po’ smorzato, oppure limitandosi a cristallizzarlo, impedendone uno sviluppo ulteriore, ma non “tornando indietro”).
Naturalmente, in questo caso ci si riferisce ai risultati raggiunti dalla lotta controrivoluzionaria, messa in atto in buona fede al fine di ristabilire l’Ordine e non agli obiettivi della politica realizzata in malafede dai partiti moderati e conservatori a cui si riferiva il filosofo carlista Jaime Balmes (1810-1848) nel suo celebre aforisma («Il partito conservatore conserva gli effetti della Rivoluzione, quello moderato si limita a moderarne gli impeti»).
Il risultato favorevole alla Rivoluzione è dovuto al fatto che essa agisce come un esercito altamente specializzato e addestrato, in cui l’avanguardia (i progressisti) individua gli obiettivi, il centro (i riformisti) conquista le prime posizioni e, mentre riparte verso quelle più avanzate, la retroguardia (i conservatori, appunto) le consolida, convincendo i suoi sostenitori che è meglio rimanere dove si è senza cercare di tornare indietro, perché altrimenti si creerebbe una frattura, e che al fine di preservare la pace sociale bisogna accettare il “male minore”. Dato che l’esercito della Rivoluzione procede costantemente in direzione del peggio, il male “maggiore” di oggi diverrà il male “minore” di domani.
E a proposito della teoria del male minore, particolarmente in auge durante ogni campagna elettorale, va notato che in ambienti sedicenti tradizionalisti, ma in realtà nostalgico-conservatori, ultimamente è invalso l’uso di considerare come positivo il ritorno al recente passato, che spesso è oggettivamente migliore del presente, senza rendersi però conto che quello stesso più o meno recente passato è la causa remota o addirittura diretta della situazione attuale (7). Sicuramente, in un frangente di motus in fine velocior, il periodo trascorso risulta essere preferibile al presente; ma ci si deve rendere conto che postulare il ritorno all’immediato passato non rappresenta la soluzione. Anzi, rischia di essere un grave errore di calcolo, consistente nel confondere la causa con la soluzione, cioè scambiare come possibile rimedio ciò che in realtà non è altro che la cagione della situazione presente.
Forse il concetto è meglio comprensibile ricorrendo alla seguente metafora. La Rivoluzione è una lancia: ciò che ferisce è indubbiamente la cuspide, ma la punta in metallo, in sé, non sarebbe tanto pericolosa – perché meno lunga di una daga e meno maneggevole di un semplice pugnale – se non fosse connessa all’asta lignea. E questa è il risultato della concrezione degli errori del passato, del loro successivo sedimentarsi. In altre parole: è il presente a ferire, ma è il passato che gli conferisce la forza di farlo.
Rivoluzione e reazione
Un termine usato per indicare l’antirivoluzione (in generale in maniera dispregiativa da parte dei rivoluzionari) è quello di Reazione. Il termine, etimologicamente parlando, indica però solo un movimento avverso a quello rivoluzionario, ma non necessariamente in direzione del totale ritorno alle origini (anti-rivoluzione): può esistere peraltro anche una “reazione rivoluzionaria estremista”, antimoderata, che cioè rifiuta il moderarsi della Rivoluzione (8).
In generale, però, il termine reazionario, pur non essendo sinonimo di tradizionalista, si avvicina di più al concetto di antirivoluzione di quanto non avvenga per quello di conservatore, essendo questo – inconsciamente o no – uno strumento della Rivoluzione, come abbiamo visto nella metafora dell’esercito.
Peraltro pure alcuni movimenti novecenteschi apparentemente controrivoluzionari (magari perché nati in opposizione agli eccessi della rivoluzione bolscevica) provengono in realtà dalla stessa mentalità rivoluzionaria, anche se sono più moderati (e qui va ribadito il citato monito di Balmes).
Gli stessi fascismi europei si consideravano rivoluzionari: quello italiano parlava apertamente di “rivoluzione fascista” e si definiva “secondo risorgimento” (presentandosi quindi come erede della “rivoluzione italiana”) (9). Non è solo una questione di termini: la matrice dei fascismi non è tradizionale, bensì moderna, data la provenienza di gran parte dei loro capi ed ideologi dalla sinistra movimentista, da società segrete (massoneria compresa), da una cultura laicista o da una falsa tradizione ricreata a tavolino, in primis quella neopagana – presente soprattutto nel nazismo della mitopoiesi del rito – delle suggestive fiaccolate notturne in occasioni di particolari momenti del calendario solare.
Che sia stata di fatto anticristiana (il nazionalsocialismo tedesco), indifferentista od opportunista (il fascismo italiano, le Croci frecciate ungheresi), apparentemente o dichiaratamente cattolica (il falangismo spagnolo, il rexismo belga, le Blueshirts irlandesi) o cristiana (la Guardia di Ferro rumena), l’ideologia dei movimenti fascisti novecenteschi, eredi dell’hegelismo e dell’esistenzialismo (10), si muove nell’alveo della Rivoluzione (e della Modernità), di cui accetta i princìpi, ponendo al di sopra di tutto la razza (nazismo) o lo Stato (fascismo italiano), anziché Dio (come fa invece il Carlismo, la migliore espressione della dottrina politica cattolica).
Rivoluzione e Ordine
Abbiamo già visto come la Rivoluzione – quella con la maiuscola, che (almeno per ora) va dall’Umanesimo al transumanesimo – si opponga all’Ordine. Ciò che si deve intendere per Ordine, altro non è che l’ordine naturale e cristiano, nato dalla fusione della più elevata cultura greco-romana con i princìpi del Cristianesimo.
La Rivoluzione, dunque, anticristiana di per sé anche laddove pretendesse di non esserlo, è sempre un male ed è sempre da rifiutare, perché è in costante guerra contro la Cristianità (maior, minor o minima che sia) (11) e l’Ordine naturale (o ciò che ne resta).
Quindi rappresenta necessariamente un male ed è sempre un nemico: di conseguenza non esiste – non può esistere – una rivoluzione “buona”, i cui frutti negativi siano solo involontarie conseguenze, degenerazioni non volute. Il Terrore, giacobino o stalinista che sia, non è una mera degenerazione delle rivoluzioni francese o bolscevica, che in tale distorta visione in partenza sarebbero positive (se non addirittura “necessarie”) e solo successivamente, a causa della malvagità di alcuni dei suoi esponenti (12), si sarebbero corrotte. Il Terrore è invece la naturale conseguenza della Rivoluzione, una sua fase davvero “necessaria” (13); così come i campi di concentramento o la “soluzione finale” non sono un semplice “errore di percorso” bensì la logica conclusione di una mentalità razzista ed eugenetica presente fin dai primordi in coloro che forgiarono l’ideologia da cui nacque il nazionalsocialismo (come la Società Thule, a sua volta “debitrice” della Società Teosofica).
Il Terrore giacobino e stalinista o le varie “soluzioni finali” sono soltanto alcuni esempi delle conseguenze “necessarie” (14) dei princìpi rivoluzionari: i casi sono (purtroppo) tantissimi e (sempre purtroppo) non appartenenti solamente al passato.
Per rispondere ai “giustificazionisti” ripetiamo quanto sosteneva in tali frangenti un altro pensatore carlista, Juan Vázquez de Mella (1861-1928): «Non si possono incoronare le cause e poi impiccare le conseguenze».
Gianandrea de Antonellis
[1] Così avvenne anche con la locuzione “Santa Fede” in uso nel Regno di Napoli all’inizio dell’Ottocento; un’altra locuzione – non necessariamente caratterizzata da intenti offensivi, ma decisamente fuori luogo – è stata quella “di destra”, con riferimento alla politica della seconda metà del Novecento e non alla Destra storica ottocentesca.
[2] Anche il solo termine novità (sottintendendo politiche) e il derivato novatori erano considerati sinonimi di cambiamenti indesiderati e peggiorativi dell’Ordine.
[3] In questo senso, è inconciliabile con il concetto di insurrezione, solitamente finalizzata al ritorno allo status quo antea. È il caso della rivolta di Masaniello (1648), scoppiata in nome del Re e quindi tutt’altro che rivoluzionaria, bensì finalizzata al rispetto del diritto tradizionale, che escludeva l’introduzione indiscriminata di nuove gabelle.
[4] La vera Tradizione implica un continuo miglioramento, quindi un sano e reale progresso, a differenza del conservativismo, caratterizzato dall’immobilismo, che vorrebbe cristallizzare la situazione esistente.
[5] Chi propone il termine Antirivoluzione indica con Controrivoluzione non una posizione assoluta, ma solo un’azione – e un pensiero – che si esprime unicamente in seguito alla Rivoluzione stessa e magari per la sola durata di essa. Il concetto di Antirivoluzione verrebbe invece a coincidere con l’idea stessa di Ordine. Va detto che talvolta i due vocaboli si trovano invertiti: cfr. Giovanni Turco, Introduzione a Diego Benedetto Panetta, Il pensiero controrivoluzionario. Onore, fedeltà e bellezza al servizio di Dio, Historica, Cesena 2020, p. 10-11.
[6] A cominciare dal diritto, con il mantenimento del Codice Napoleone, emblema del concetto stesso di rivoluzione (fare tabula rasa e ricominciare da zero), e della eversione dei feudi. Scrivo rivoluzione francese con la minuscola, in quanto mero episodio della più ampia e pressoché costante Rivoluzione contro il mondo tradizionale, la Cristianità, che va (per i nostri tempi) dall’Umanesimo al transumanesimo. La si potrebbe dunque considerare quasi un sinonimo di Modernità (in senso assiologico e non cronologico).
[7] Ad esempio i cosiddetti conservatori apparentemente incapaci di rendersi conto che i mali della Chiesa non sono iniziati nel 2013 con le dimissioni di Ratzinger, ma che affondano le proprie radici in tempi ben più remoti…
[8] È il caso dei cosiddetti rivoluzionari-contro che, come il Marchese di Sade, spingevano il popolo a «compiere ancora uno sforzo» per raggiungere la piena distruzione dell’ordine sociale esistente – nella fattispecie, abolendo del tutto la religione. Cfr. G. Turco, op. cit., p. 11.
[9] Ed istituendo, alla moda giacobina, un calendario dell’Era Fascista, ancorché limitato al solo anno ed affiancato a quello gregoriano.
[10] Sulle radici esistenzialiste dei fascismi, cfr. Rafael Gambra, Quello che chiamano Stato, Solfanelli, Chieti 2024.
[11] Il riferimento è al pensiero di Francisco Elías de Tejada (1917-1978) e della sua scuola: la Christianitas maior era la Cristianità medioevale; la Christianitas minor era costituita da ciò che ne rimaneva dopo le varie “fratture” religiose e culturali che portarono all’età moderna, cioè la Monarchia missionaria ispanica dei Re Cattolici; la Christianitas minima è rappresentata dall’ultima, attuale resistenza del mondo politico tradizionale: il Carlismo.
[12] O dei loro errori: i cosiddetti “compagni che sbagliano”.
[13] In questo caso, intesa non nel senso corrente, bensì in quello filosofico: «che non può essere diversamente da come è».
[14] Vedi nota precedente.