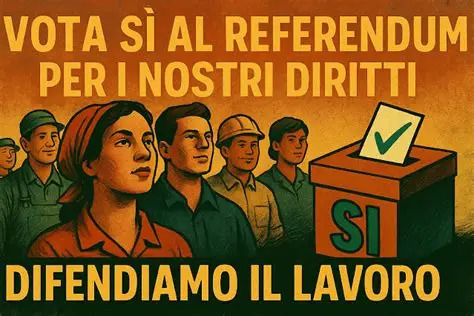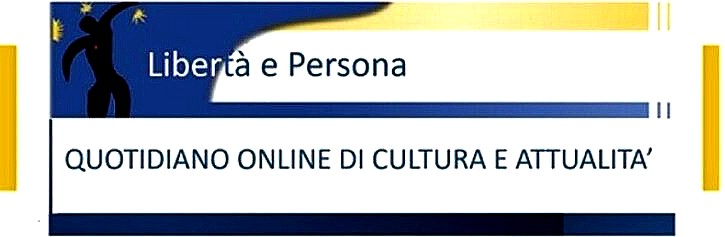Tempi 26 Ottobre 2025
Un libro di Sciacca smonta la “formula magica” dirittista dei nostri tempi egualitari. Un’idea che favorisce un pasticcio culturale lontano dal pluralismo
di Carlo Marsonet
«Vi è poi l’idea, ormai più o meno prevalente, ed espressa con crescente enfasi, che ogni forma di disagio sociale possa essere eliminata e che qualcuno debba assolvere a tale compito»; «oggi si presume che non debbano esistere sofferenze, e che quelli esistenti siano senza dubbio ascrivibili a una qualche responsabilità della società»: sono due affermazioni che potrebbero essere fatte benissimo oggi da un osservatore attento, realista e disincantato circa la realtà sociale attuale, e invece risalgono alla fine dell’Ottocento.
L’autore, per chi non lo avesse già riconosciuto, è Herbert Spencer, e il testo è L’uomo contro lo Stato (1884, curato nell’edizione italiana da Alberto Mingardi per l’editore Liberilibri). Ebbene, il pensatore inglese aveva già visto in maniera lucida cosa iniziava ad accadere ai suoi tempi, e cioè un allargamento del “potere sociale” a scapito della libertà individuale. Più si presume di avere diritto a tutto, più la libertà è a rischio e il diritto, quello vero, è in pericolo.
Il mito dei diritti
Ne parla in un volume dalla inebriante nota controcorrente Fabrizio Sciacca, Il mito dei diritti (Liberilibri). Professore ordinario di Filosofia politica all’Università di Catania, l’autore mira a smontare la “formula magica” dirittista dei nostri tempi egualitari. Per Sciacca, la libertà ha sempre avuto nel corso dei secoli un certo prezzo, e cioè delle regole che la tutelassero e la inquadrassero entro certi limiti: questo è il diritto, nella sua essenza più pura. Solo che, a lungo andare, si è fatta largo una visione differente, per certi (molti) aspetti antitetica. E cioè che il diritto è appannaggio dei forti, mentre i più deboli sono esclusi dal suo ombrello difensivo. Un tempo erano i proletari, ora è il turno della galassia dei nuovi gruppi – in costante aumento – che si sentono discriminati.
E qui risiede un primo punto cruciale: alla base della proliferazione dei diritti risiede la vaga, elastica e potenzialmente senza confini etichetta dell’oppressione. Più si ampliano le maglie dell’oppressione – presunta, qui sta il bello: l’oppressione è anche, e forse soprattutto, una questione di percezione! – maggiore sarà la richiesta di nuovi “sussidi” giuridico-tutelari volti alla protezione degli oppressi. Ma tutto ciò ha un costo, in termini di libertà e indipendenza della società, cioè degli individui che la compongono.
Perché la politica concede sempre nuovi diritti
Il potere politico sarà così ben disposto a concedere sempre nuovi diritti, proprio perché in cambio di ciò aumenta la propria presa sulla società medesima: tradotto, dal momento che lo Stato è un dispositivo nelle mani dei potenti di turno, la società diventa succube della politica. E da ciò deriva pure la diminuzione della libertà: ogni diritto in più, è stato efficacemente rilevato, è una libertà in meno. Amen.
È altrettanto chiaro che questa prassi invalsa esacerbi in maniera crescente la conflittualità sociale: ciascuno desidera sempre più diritti, cioè rendite di posizione, da opporre agli altri. Una sorta di guerra civile condotta con altri mezzi: a differenza di una guerra vera e proprio, però, i risultati si vedono sul lungo periodo e, invece di fare morti, sfibrano il tessuto sociale. L’esito può essere meno sanguinario, ma il prezzo è comunque alto: una buona società vive attraverso la libertà e la responsabilità individuale, mediante la cooperazione e un profondo rispetto per l’altro.
L’ideologia dei diritti nuoce a tutto questo. Sciacca lo scrive senza mezzi termini: «Lungi dall’essere una soluzione universale, l’idea dei diritti conduce a risultati inattesi, favorendo un pasticcio culturale lontano dal pluralismo: i diritti non appaiono più come scudi per l’individuo, ma come armi che invocano interventi statali e restrizioni alla libertà». Ogni nuova generazione, diceva Spencer, cresce così più caratterialmente fiacca, volontariamente remissiva e mentalmente dipendente: si rafforza in loro «l’idea che tutto debba essere fatto per loro, e nulla da loro».