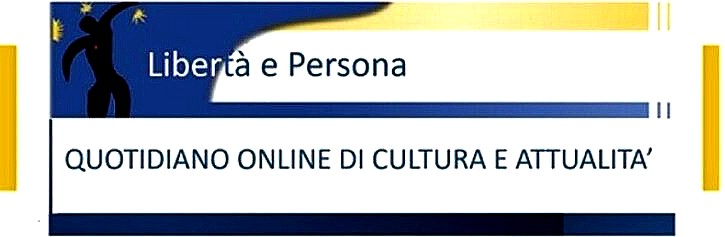Lo Scoglio 4 Novembre 2025
Andrea Bartelloni
Nacque in Apulia (regione che si estendeva dalla Puglia odierna fino a Basilicata e Molise) e, probabilmente, imparò a scolpire nei cantieri avviati da Federico II. Lo “stupor mundi”, con buona probabilità, dalla sua bottega lo portò a Pisa: da qui il termine «Pisano» che si associa al nome Nicola.
Nicola Pisano, vissuto durante il XIII secolo (1210 e 1220 circa – 1278 e 1287 circa) è conosciuto soprattutto come scultore per aver scolpito il pergamo del Battistero di Pisa e per quello del duomo di Siena. In Toscana fece anche altro: ad esmpio a Lucca scolpì la lunetta raffigurante la Deposizione che si trova nel portale sinistro del Duomo; mentre in Umbria, in particolare a Perugia, realizzò la Fontana Maggiore.
Ma Nicola Pisano fu anche architetto e con queste competenze lavorò al Battistero di Pisa e al Duomo di Siena, quasi sempre col figlio Giovanni autore del pergamo della cattedrale pisana. Il pulpito, che fino ad allora nelle grandi chiese era addossato ad una parete della chiesa, con Nicola Pisano trovò una collocazione diversa, al lato della navata centrale. Illustrato da bassorilievi e sculture, divenne una vera e propria «biblia pauperum» in pietra, (di solito marmo, prevalentemente bianco di Carrara).
Le immagini e le storie del pulpito senese, in particolare, sono illustrate nei dettagli nel volume I misteri del pulpito senese di Nicola Pisano (Sillabe, 2025 con la collaborazione di Opera Metropolitana di Siena e Opera Laboratori, pagine 64, euro 18) scritto dalla prof.ssa Alessandra Gianni, docente di Storia dell’arte medievale, di Iconografia e iconologia all’Università di Siena.
Nel volume l’autrice non si limita alla descrizione del pulpito del duomo di Siena, ma lo mette a confronto, stilistico e iconografico, con quello del Battistero di Pisa e della cattedrale pisana: dal confronto emerge lo stile innovativo di Nicola che si evidenzia nella «pianta centrale isolata nello spazio, quando lo schema più diffuso in Toscana (…) era quello della pianta quadrangolare addossata ad un tramezzo, a una colonna o a un pontile».
Ma l’innovazione, che iniziò a Pisa col pergamo del Battistero datato 1260 – e significativamente riprodotto in una immagine a colori nel volume a pag. 10, sta soprattutto nel «linguaggio figurativo attraverso il superamento delle stilizzazioni e delle schematizzazioni che avevano caratterizzato la scultura in Italia fino ad allora».
Il nuovo linguaggio stilistico di Nicola fu sicuramente influenzato dall’ambiente artistico della corte dell’imperatore Federico II, ma anche dal «recupero della tradizione classica di cui Nicola aveva una profonda conoscenza anche grazie allo studio dei sarcofagi romani e delle opere greche presenti a Pisa».
Nel 1265 Nicola Pisano ricevette la commissione da «frà Melano, converso cistercense, dell’abbazia di san Galgano e Operaio del Duomo di Siena». Contratto che viene stipulato a Pisa dove frà Melano ebbe sicuramente la possibilità di ammirare il pergamo del Battistero appena ultimato. Il pulpito senese, al quale lavorarono il figlio Giovanni, Arnolfo di Cambio, Lapo e Donato, venne concluso a fine 1268.
La somiglianza con il pulpito di Pisa si manifesta specialmente nei primi due ordini: l’inferiore con i leoni e il mediano, quello degli archi. Lo stile si sviluppò, invece, in modo innovativo nella parte superiore, quella del parapetto: nel pulpito senese, infatti, troviamo «gruppi scultorei angolari che integrano e arricchiscono la narrazione dei pannelli», in quello del battistero pisano, troviamo delle semplici colonne. Il tutto offre un effetto di continuità narrativa che viene descritta dalla Gianni analizzando le scene della vita di Cristo che poggiano sulle figure dei profeti e degli evangelisti oltre che sulle personificazioni delle Virtù.
Questi, a loro volta sono sorretti «da leoni, leonesse stilofori e dal basamento della colonna centrale reggente il ballatoio, con la personificazione delle Arti liberali e della Filosofia». Un percorso pedagogico che conduce a Cristo, alla sua storia, dall’Annunciazione alla Natività fino alla Crocifissione e alla gloria del Cristo Giudice al centro dei due pannelli con gli Eletti e i Dannati.
«Il racconto vivace e appassionato delle vicende di Cristo spinge Nicola, (…), a creare innovative soluzioni iconografiche, ma è l’intero complesso scultoreo e architettonico del pulpito che, come afferma Friedrich Ohly, con il suo percorso di lettura dal basso verso l’alto, scandisce la storia della salvezza». Il volume è presentato dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Pienza e presidente della Conferenza episcopale toscana, che descrive l’opera come «un passaggio importante nello sviluppo dell’arte italiana, (…) ma soprattutto una sintesi della grande cultura del tempo, che leggeva la presenza del Cristo e l’annuncio della sua bellezza salvifica, non solo nella rivelazione delle Scritture, ma anche nella ragione umana e nella sua tensione intellettuale verso le realtà più alte: un messaggio di ampio respiro e di grande apertura del mondo medievale che, ben lungi dall’oscurantismo col quale tante volte viene presentato, si manifesta attraverso queste vestigia, come un’era di grande spinta e comprensione di quella nobiltà della ragione umana, indispensabile anche all’atto di fede, un “umanesimo cristiano” che la Chiesa ha sempre accolto nel suo insegnamento fin dagli inizi della sua storia».
(Pubblicato su Toscana Oggi, Settimanale regionale di informazione, 26 ottobre 2025)