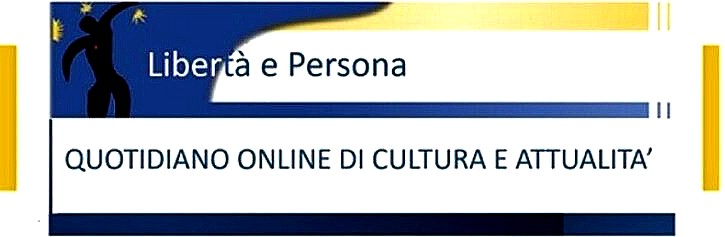Podcast di Roberto de Mattei 8 Ottobre 2025
di Roberto de Mattei
Tra le tante accuse che vengono rivolte contro lo Stato di Israele, c’è anche quella di aver “creato”, negli anni Ottanta del Novecento, il movimento di Hamas. Ciò dovrebbe spingere a dissociarsi dalla guerra che Israele conduce contro Hamas, perché non c’è molta differenza tra il terrorismo e chi ne ha favorito la nascita.
Ci troviamo di fronte ad una semplificazione storica che contiene, come tutti gli errori, una parte di verità ed è da questa verità, di ordine dottrinale, che bisogna partire.
Il principio questo: non si può mai fare il male, nemmeno per ottenere il bene e quella che san Tommaso d’Aquino chiama la «perfidia in bello» (Summa Theologiae, II-IIae, q.40, a.3) deve essere esclusa da chi vuole rispettare, se non la legge cristiana, almeno quella naturale.
Il male, infatti, non porta mai al bene, ma anzi, per il principio dell’eterogenesi dei fini, conduce a risultati esattamente opposti a quelli che vuole ottenere.
Il Novecento, secolo di grandi guerre e di grandi inganni, offre numerosi esempi di questa eterogenesi dei fini o, se si preferisce, di “boomerang” politici: decisioni concepite come geniali mosse tattiche che hanno finito per colpire chi le aveva lanciate.
Il caso più celebre è quello del treno piombato che riportò Lenin dalla Svizzera a Pietrogrado nell’aprile 1917. Per destabilizzare la Russia e costringerla a uscire dalla Prima guerra mondiale, i vertici dello Stato Maggiore tedesco organizzarono il ritorno dell’esule bolscevico e dei suoi compagni. Il calcolo, in un primo momento, riuscì: grazie alla Rivoluzione leninista di Ottobre, con il Trattato di Brest-Litovsk del 1918, la Germania ottenne la fine della guerra a Est, con la possibilità di spostare cinquanta divisioni sul fronte occidentale. Ma come ammise lo stesso generale Eric Ludendorff, era stato spedito in Russia un “bacillo” contagioso: la Rivoluzione bolscevica non rimase confinata oltreconfine. I generali tedeschi scrive lo storico Sean McMeekin, «pensavano di usare Lenin come un’arma biologica contro la Russia, ma non capirono che la malattia che stavano diffondendo avrebbe finito per contagiare anche loro» (The Russian Revolution: A New History, Basic Books, 2017, p. 130). L’Impero tedesco crollò e l’ordine dell’Europa centro-orientale, che Berlino sperava di controllare, si dissolse, mentre il comunismo da Mosca divampò nel mondo. L’arma che la Germania aveva “esportato” per vincere la guerra divenne un nemico ideologico globale.
Subito dopo la guerra, le potenze vincitrici provarono a blindare la sicurezza europea col Trattato di Versailles (1919) che impose condizioni durissime alla Germania. Le clausole punitive furono concepite per impedire alla Germania di risorgere. Ma l’effetto fu opposto: l’umiliazione e la crisi economica, la spinsero verso il revanscismo, il riarmo e la ascesa del nazismo. Un boomerang diplomatico che gettò le basi della Seconda guerra mondiale.
Un altro boomerang clamoroso fu la scelta degli Stati Uniti di armare e finanziare i mujahidin afghani contro l’invasione sovietica (1979-1989). Fu la più grande operazione segreta della CIA, e raggiunse il suo scopo: Steve Coll ha documentato come i flussi di denaro e di armi degli anni Ottanta abbiano contribuito alla sconfitta sovietica in Afghanistan (Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, Penguin, 2004), ma nello stesso bacino nacquero al-Qaeda e i talebani, protagonisti della stagione jihadista culminata con gli attentati dell’11 settembre 2001.
Un altro caso emblematico è l’Operazione Ajax del 1953: la CIA e il M16 britannico rovesciarono il premier iraniano Mossadeq per mantenere il petrolio sotto controllo anglo-americano e conservare l’Iran nell’orbita occidentale. Stephen Kinzer definisce quell’intervento «la madre di tutti i boomerang»: l’imposizione di un regime autoritario che portò, dopo 25 anni, alla caduta dello Shah, alla rivoluzione islamica del 1979 e a quarant’anni di ostilità con Washington (All the Shah’s Men: An American Coup and the Roots of Middle East Terror, John Wiley & Sons, 2003).
Negli anni Ottanta, gli Stati Uniti e diversi paesi europei sostennero Saddam Hussein nella guerra contro l’Iran di Khomeini. Dilip Hiro, ricorda che Baghdad ricevette tecnologia e intelligence occidentali (The Longest War: The Iran–Iraq Conflict, Routledge, 1991). Dieci anni dopo, quello stesso Saddam, che era stato aiutato dall’Occidente, invase il Kuwait, trascinando gli Stati Uniti nella Guerra del Golfo (1991) e aprendo la lunga vicenda irachena culminata nell’invasione americana del 2003. Il risultato fu l’instabilità dell’intera regione, la radicalizzazione islamica e la nascita dell’ISIS. Gli Stati Uniti ottennero la caduta del dittatore, ma persero credibilità e influenza, lasciando spazio all’Iran e al jihadismo. Ancora una volta, successo tattico, disastro strategico.
E arriviamo alla nascita di Hamas. Negli anni ’70 e ’80, operava nella striscia di Gaza Mujama al-Islamiya, una rete islamica legata alla Fratellanza Musulmana. Il movimento fu favorito da Israele, nella convinzione che sarebbe stato una spina nel fianco dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) di Yasser Arafat. All’epoca della prima Intifada (1987-1988), da questo movimento nacque Hamas (Harakat al-Muqawama al-Islamiyya), il Movimento di Resistenza Islamica, che fin dal suo atto fondativo (1988) si proponeva la distruzione di Israele. Nel quadro strategico israeliano degli anni Ottanta, la presenza di un islamismo organizzato offriva il vantaggio immediato di creare una spaccatura nel fronte palestinese. Ma l’illusione fu di breve durata. Dopo che Hamas iniziò a compiere atti violenti contro Israele, Tel Aviv rispose con arresti su larga scala e la dichiarazione ufficiale di Hamas come organizzazione terroristica (1989). Come avrebbe ammesso in seguito un funzionario dell’amministrazione militare israeliana, Avner Cohen, l’appoggio ad Hamas «fu un errore enorme, una stupidaggine storica: abbiamo permesso che crescesse un movimento che poi ci si è rivoltato contro» (Andrew Higgins, How Israel Helped to Spawn Hamas”, “The Wall Street Journal”, 24 gennaio 2009).
Israele non ha “creato” Hamas ma, alle sue origini, lo ha certamente incoraggiato. Una logica che, come osserva lo storico Jean-Pierre Filiu, si è poi rivelata «un boomerang perfetto». Nel tentativo di indebolire Arafat, Israele ha favorito l’emergere di un attore più radicale, capace di contestare sia lo Stato Palestinese che quello ebraico con una forza popolare e religiosa molto più profonda (The Origins of Hamas: Militant Legacy or Israeli Tool?, “Journal of Palestine Studies”, 41 (3), 2012, pp. 54-70).
Se c’è un insegnamento che emerge dal Novecento è che la Realpolitik ha sempre un costo pesante. Che si tratti del treno piombato di Lenin, della pace punitiva di Versailles, dei mujahidin afghani, dell’Iraq o della striscia di Gaza, senza dimenticare la cosiddetta “Primavera araba”, il meccanismo è sempre lo stesso: l’obiettivo tattico conduce ad un successo apparente, ma sul medio termine produce la nascita di un nuovo nemico o di una maggiore destabilizzazione. Le grandi potenze hanno spesso creduto di manovrare la storia come un gioco di scacchi. Ma le dinamiche del bene e del male, della lealtà e dell’inganno, hanno nella storia esiti diversi. Il bene tende a realizzare sé stesso, mentre il male tende a distruggere anche i propri scopi. La coerenza dei risultati appartiene al bene che costruisce, non al male che distrugge.
Condannare il cinismo politico di alcune scelte o i mezzi illeciti con cui si conduce una guerra, non ne pregiudica però la causa. Chi giustamente condanna l’uso della bomba atomica a Hiroshima e Nagasaki, non può da questo dedurre che la guerra degli Alleati contro le forze dell’Asse fosse sbagliata, così come il macroscopico errore commesso da Israele, favorendo lo sviluppo di Hamas, non sposta la bilancia della giustizia a favore dei nemici di Israele, che sono quelli dell’Occidente.