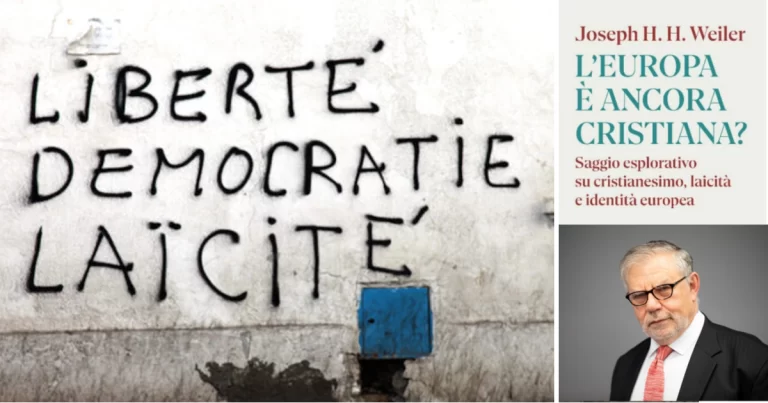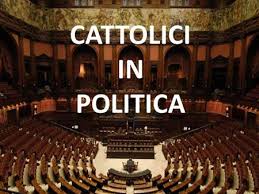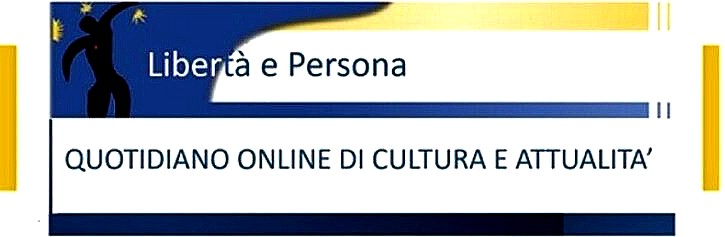Unione Cristiani Cattolici Razionalisti (UCCR) 29 Luglio 2025
La giurista Marta Cartabia presenta il volume del collega Joseph Weiler, colui che ha messo in crisi il paradigma della presunta neutralità dello Stato secolare, scardinando l’equivalenza laicità-neutralità.
di Mara Cartabia (ex presidente della Corte Costituzionale)
da “La Stampa”, 25 luglio 2025
La prima edizione del libro “L’Europa è ancora cristiana?“ di Joseph Weiler è stata scritta e pubblicata nel 2003 all’apice di un cambiamento epocale.
Era l’inizio del nuovo secolo e in Europa stavano emergendo in modo incontrovertibile gli effetti della secolarizzazione che, gradualmente, era già penetrata nel tessuto sociale, lungo il corso di tutta l’età moderna. A questi effetti si univano i primi segnali della assai più recente trasformazione in senso multiculturale della società europea.
I valori della cristianità erano messi in discussione e talora contrastati apertamente. La tradizione cristiana era quasi motivo di imbarazzo nei dibattiti pubblici e politici, come dimostra la discussione sulle radici cristiane dell’Europa. La cultura cristiana, che aveva dominato per secoli il vecchio continente, appariva una eredità da relegare nel passato.
Nel mezzo di quel dibattito, la voce profonda e coraggiosa di Joseph Weiler si è fatta sentire e ha segnato un punto di svolta nel corso della cultura giuridica e, oserei dire, della storia europea. È a lui che si devono almeno due contributi di pensiero con cui oggi ci si deve misurare e che, a mio avviso, sono difficilmente confutabili.
Lo Stato secolare non rappresenta la neutralità
Il primo è la dimostrazione che in Europa non esiste un unico modello di rapporto tra Stato e fenomeno religioso a cui occorra uniformarsi: si riscontra, al contrario, una varietà di soluzioni istituzionali, tuttora vigenti, che vanno dalla religione di Stato, allo schema pattizio o concordatario, alla più rigida separazione.
Il secondo, decisivo, contributo sta nell’aver mostrato che l’asserita “neutralità” dello Stato secolare nei confronti della religione non è affatto neutra, né può esserlo.
Mi spiego. All’inizio del nuovo secolo, ripudiati i vecchi paradigmi basati su ciò che restava del principio “cuius regio eius religio”, si era avviata la ricerca di nuove modalità di regolazione del fattore religioso, specie in ambito pubblico. Tutto portava a far emergere come paradigma dominante quello della “laïcité à la française”, vale a dire un’equivalenza tra laicità e neutralità, che induceva a rimuovere dall’ambito pubblico ogni riferimento religioso.
La legge francese del 2004 sul divieto dei simboli religiosi “ostensibili” è l’emblema di quella concezione, incentrata sull’idea della “neutralità” dello spazio pubblico, che sospinge ogni manifestazione religiosa fuori dai confini della piazza pubblica. In poche parole, si tendeva a pensare che l’unica alternativa ai vecchi schemi, ormai inservibili, fosse l’affrancamento da ogni presenza ed espressione religiosa.
Cos’altro poteva fare lo Stato per rispettare a un tempo le posizioni secolarizzate dei più e la varietà di appartenenza religiosa delle residue minoranze di credenti? La “neutralità” sembrava la strada razionalmente obbligata.
A fronte della secolarizzazione diffusa e del pluralismo religioso crescente, lo Stato proponeva uno spazio vuoto, equidistante da ogni posizione. E in questa direzione si stavano muovendo non solo l’esperienza francese e quella di altri paesi limitrofi, ma anche le Corti europee, di Strasburgo e del Lussemburgo.
Proprio in relazione a due decisioni delle Corti europee riguardanti i simboli religiosi, Joseph Weiler è intervenuto mettendo profondamente in crisi la nascente idea della laicità-neutralità.
In questi due interventi Joseph Weiler ha svelato una ambiguità di cui pochi si erano accorti, o forse nessuno: nonostante l’apparenza, il secolarismo non è affatto neutrale rispetto alla religione. Piuttosto, la laicità è una delle componenti, probabilmente quella maggioritaria, del pluralismo religioso che contraddistingue il contesto attuale e la visione secolare del mondo.
Pertanto, lo Stato che si fa secolare con l’intenzione di non interferire nella libertà religiosa di credenti e non credenti, in realtà manca lo scopo: lo Stato secolare non è affatto terzo rispetto alle opzioni in campo. Di fatto, abbraccia una delle visioni possibili, quella “senza dio” appunto, e se ne fa portavoce.
L’ebreo Weiler difese il crocifisso alla Corte europea
Il muro bianco nelle aule scolastiche o il dress code uniforme sui luoghi di lavoro, che impedisce alle donne musulmane di portare il velo sul luogo di lavoro, non esprimono affatto una opzione “neutra”, ma l’opzione per uno spazio pubblico senza religione.
Può essere interessante notare che l’autorevolezza di questi interventi era corroborata – oltre che dalle inarrivabili qualità intellettuali e umane di uno dei più grandi giuristi della nostra epoca – altresì dal fatto che Joseph Weiler non parlava “pro domo sua”. Il caso Lautsi del 2011 riguardava il crocefisso nelle scuole italiane e il caso Achbita del 2017 il velo islamico di una lavoratrice in Belgio.
E, lo sappiamo bene, Joseph Weiler non è né cattolico né musulmano.
La libertà di religione tutela anche i non credenti
Altrettanto forte e chiaro è stato il suo richiamo, rivolto alla comunità cristiana, a non ridurre il cristianesimo a una serie di precetti morali. L’etica non è monopolio delle persone di fede – ha ripetuto all’infinito – e la religione non può essere ridotta a etica: in questo libro si incontrano pagine importanti, da rileggere e rimeditare a questo proposito.
La voce di Joseph Weiler ha sempre incoraggiato la comunità dei credenti a partecipare a testa alta alla vita pubblica, così come a ogni espressione della umana esperienza, e di farlo partendo sempre dal rispetto della libertà della persona. Per questo, non si è mai stancato di sottolineare che la libertà di religione porta con sé anche la libertà dalla religione, quella di chi non professa alcun credo.
Mi hanno sempre impressionato la sua conoscenza e la sua profonda comprensione degli insegnamenti del Concilio Vaticano II sulla libertà di religione; ma non meno impressionante è la sua infaticabile pazienza a spiegare a tutti in ogni occasione che la libertà di ciascuna persona deve essere presa sul serio e profondamente rispettata anzitutto per una ragione teologica: Dio ci ha creati liberi, liberi anche di non riconoscerlo.
Partire dalla libertà di ciascuno non è un cedimento al modernismo e alla cultura liberale, ma è fedeltà al messaggio del Dio di Abramo. Credo che questa scommessa sulla libertà di coscienza di ciascuno, a partire dalla propria, sia un messaggio centrale, da subito ribadito anche da Papa Leone XIV in uno dei suoi primi interventi.
A proposito della posizione del cristiano di fronte ai problemi della società contemporanea, il pontefice ha parlato di sacra libertà della coscienza, anche se erronea: «L’indottrinamento è immorale, impedisce il giudizio critico, attenta alla sacra libertà della propria coscienza – anche se erronea – e si chiude a nuove riflessioni perché rifiuta il movimento, il cambiamento o l’evoluzione delle idee di fronte a nuovi problemi».