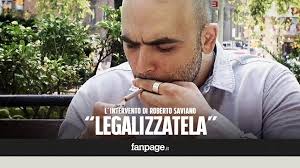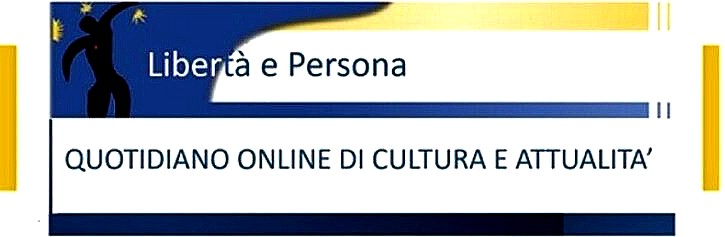Centro studi Rosario Livatino 22 Agosto 2025
Mentre in Italia le politiche antidroga riducono i morti da overdose, la situazione francese sembra fuori controllo.
Mauro Ronco
1. Leggo su Le Monde del 3 agosto 2025 la notizia circa l’esistenza di un rapporto confidenziale del Ministro dell’Interno francese, che dà conto dell’enorme traffico di droga in Francia, che le autorità definiscono “lo tsunami bianco”, “una minaccia esistenziale per il nostro Paese”. I dati riferiti sono effettivamente allarmanti: sarebbero attivi nell’attività di distribuzione al dettaglio delle droghe oltre 200.000 persone; alla guida dei trafficanti sarebbero oltre 5.000 capibanda e sovrintenderebbero agli affari almeno un centinaio di importatori del Sud America (1).
Assai significativa sarebbe la nascita di una “controcultura dei trafficanti”, che avrebbe acquisito nell’ottobre 2024 uno spazio nelle reti di informazione per prendere le distanze dalla barbara uccisione di due persone, tra cui un ragazzo di 15 anni, con lo scopo di dare a intendere che, in definitiva, i trafficanti di droga non sono degli uomini ‘cattivi’, ma sono operatori economici dediti a un servizio utile per una quota notevole della popolazione. Secondo il rapporto redatto dall’Ufficio antidroga (Ofast) del Ministero dell’Interno, la Francia sarebbe attualmente bersaglio di una mirata offensiva dei trafficanti. Ciò a cagione, anzitutto, di una domanda imponente di droga, che favorisce lo smaltimento diretto e immediato e, in secondo luogo, per la posizione geografica del Paese e per le sue reti di comunicazione, che costituiscono una piattaforma privilegiata di smistamento.
Il ruolo apicale della Francia, in sinergia con i produttori di cocaina della Colombia, del Perù, del Messico, del Brasile e di altri paesi del Sud America nel mercato della droga è confermato dalla crescita esponenziale dei consumatori, dalla organizzazione di laboratori per l’estrazione e la raffinazione delle droghe e dallo stabilimento nel paese degli stati maggiori di varie associazioni criminali di diversa estrazione, olandesi, turche, marocchine, bosniache, nonché della ‘ndrangheta calabrese, impegnate, in concorrenza brutale fra loro, nella conquista di lucri sempre maggiori. Il dato obiettivo più preoccupante è costituito dal calo dei prezzi al consumo della cocaina, da 70 Euro al grammo nel 2011 a 58 Euro nel 2024, segno di una accorta politica di mercato dei sodalizi criminali, volta ad estendere il numero dei consumatori.
2. Si potrebbe trattare di una soltanto tra le innumerevoli notizie di cronaca che riguardano il dilagare delle più diverse attività criminali nei territori già civilissimi dell’Occidente. Ma nella narrazione ricorrono alcuni elementi che meritano di essere segnalati al fine di ricavare istruzioni utili per il futuro del contrasto sociale e istituzionale alle droghe.
Un primo elemento concerne il persistente e crescente ricorso all’uso delle droghe nel mondo occidentale, con la dedizione a esse che spesso crea una vera e propria addiction schiavizzante. Contro le effimere ideologie minimaliste, si è progressivamente rivelata in tutta la sua crudezza la tragica realtà della schiavitù della tossicodipendenza. Aveva scritto Ferrando Mantovani, in epoca ormai risalente, che il vero volto della droga è di morte e di emarginazione. Il fenomeno, privo di ogni valore simbolico di rinnovamento, costituisce grave espressione “di autoaggressività e di autodistruzione, che appare inquadrarsi in quel più profondo senso di morte, di prevalenza del Thanatos sull’Eros, che sembra talora pervadere la nostra attuale civiltà” (2).
Queste parole furono pronunciate dall’insigne maestro addirittura nel 1986. Ora se ne può apprezzare il valore profetico; ora che i danni fisici e psicologici dei consumatori e il potere immenso della criminalità trafficante sono davanti agli occhi di tutti. Non possono più oscurarsi le conseguenze barbariche dell’ideologia della droga, che molti accreditati maîtres à penser dei decenni passati, letterati, sociologi e giuristi, ritenevano una res négligeable, il cui consumo poteva essere tollerato o addirittura favorito in ossequio alla libertà individuale!
Un secondo elemento di meditazione concerne la correlazione stretta tra l’impoverimento morale di un popolo e la sua sottomissione alla violenza di organizzazioni criminali che si annidano in ambienti etnici e culturali diversi rispetto a quelli del traffico.
La diffusione della droga associa al processo di autodistruzione per debolezza interna il processo di sopraffazione per conquista esterna. La droga è un’arma di distruzione di massa, perché è in grado di produrre, in un arco non molto lungo di anni, la sostituzione degli assetti politici, culturali ed economici di un paese. Anche chi non avesse a cuore l’identità culturale della propria nazione, e, quindi, fosse disinteressato all’impoverimento spirituale della sua terra d’origine, dovrebbe rendersi conto che il problema non è soltanto culturale, ma, ancor più radicalmente, politico ed economico, poiché il traffico degli stupefacenti provoca l’ingente trasferimento di ricchezza ingiusta dai poveri ai protagonisti delle attività criminali.
Un terzo elemento meritevole di considerazione concerne l’adattamento rapidissimo delle organizzazioni criminali alle logiche del mercato. Tra gli argini alla dilatazione delle imprese drogastiche vi sono le leggi degli Stati, più o meno permissive; il volume e la specializzazione dell’opera investigativa della polizia; l’effettività della risposta giudiziaria e l’efficacia della pena repressiva.
Ora, non appena tali argini cedono, le organizzazioni criminali ne approfittano per spostare i loro affari nei paesi giuridicamente più fragili, ove gli stessi guadagni possono essere ottenuti con minori rischi. L’ovvia conseguenza di tale circostanza è la grave fallacia di qualsiasi proposta antiproibizionista, che vorrebbe abbassare la soglia giuridica di contrasto complessivo delle autorità degli Stati al traffico illecito, in qualsiasi tipologia di sostanza esso si presenti.
Un quarto elemento concerne la sottovalutazione del pericolo costituito dalla circolazione e dall’uso delle droghe. Vanno considerati i gravissimi danni alla salute psicofisica della persona, soprattutto quando l’assunzione delle droghe abbia inizio in età giovanile. I danni alla salute dei singoli importano un complessivo impoverimento della società, anzitutto per la perdita o la minor efficienza sociale delle risorse umane necessarie per l’esistenza e il progresso della società e, in secondo luogo, per i costi sociali necessari alla cura e alla remissione delle tossicodipendenze.
Un quinto elemento, che sorprende l’osservatore imparziale, è l’incomprensione del ruolo del diritto come mezzo di protezione e promozione del bene comune. Quando si perde questa convinzione si relativizza il ruolo del diritto, lo Stato viene eroso nell’adempimento dei suoi fondamentali doveri verso la società. Se le droghe costituiscono un problema grave per migliaia di persone – in primis, per tutti i tossicodipendenti – che vengono minati nella salute, perdono spesso la capacità lavorativa, sprecano le risorse intellettuali migliori, divengono dipendenti per la sopravvivenza o dalle contribuzioni dei familiari o, peggio e più frequentemente, dal ruolo di venditori a loro volta delle droghe, allargandone il consumo; se tutti ciò è vero, come è possibile a uno scienziato del diritto sostenere, come non raramente è accaduto, che le droghe sarebbero innocue e la loro pericolosità dipenderebbe dal fatto che la loro circolazione è vietata?
Un sesto e decisivo elemento da considerare è l’offuscamento sociale della prospettiva solidaristica e di responsabilità etica nei confronti delle persone fragili, più facilmente esposte al pericolo della dipendenza dalle droghe. L’abbandono delle istanze etiche e l’indifferenza verso le esigenze di ordine e sicurezza della collettività hanno condotto a trascurare il rapporto tra l’uso e la circolazione degli stupefacenti e il crimine, nonché a dimenticare la portata criminogenetica dell’uso delle doghe, in sé e per sé considerate, se è vero che gli effetti da esse provocati tendono a estraniare il soggetto dal patto sociale significativo e a indurlo a rifiutare la vigenza dei codici di riferimento fondanti la vita in società (3).
3. A fronte del quadro francese, che non sono in grado di valutare con completezza, essendomi limitato a riferire i dati riportati da un quotidiano, sia pure tratti da documenti ufficiali del Ministero degli Interni di quel Paese, non è inopportuno esprimere delle valutazioni cautamente positive in ordine alla situazione italiana.
L’Italia era nei decenni ‘50, ‘60, ‘70 e ‘80 del secolo scorso
la piattaforma mondiale della droga.
Michele Pantaleone, nel libro Mafia e Droga del 1962 dimostrò che la via della droga (in particolare dell’eroina) dall’Estremo Oriente agli Stati Uniti e agli altri paesi occidentali aveva il suo centro di raffinazione e di smistamento nell’area mediterranea, gestita in via quasi esclusiva delle cosche mafiose della provincia di Trapani (4).
L’enorme potenza della mafia siciliana, che giunse a sfidare lo Stato, uccidendo con stragi efferate i suoi migliori investigatori, i suoi più coraggiosi pubblici ministeri e i suoi più competenti magistrati, fu causata in larga misura dal fatto che quella associazione criminale era riuscita a gestire in posizioni apicali il traffico mondiale degli stupefacenti.
Allo stato attuale le cose non stanno più così. E ciò non per l’agitarsi casuale nell’aria di una qualche bacchetta magica, bensì per l’impegno di innumerevoli persone a favore di una cultura libera dalle tossicodipendenze. Le istituzioni italiane hanno risposto in maniera non priva di determinazione alla sfida delle associazioni criminali. Il Parlamento ha approvato delle leggi che sono ancora oggi all’avanguardia nel mondo in funzione del contrasto repressivo alla criminalità mafiosa e drogastica. I corpi di Polizia, nelle loro varie articolazioni, e la magistratura inquirente hanno messo in campo strumenti di investigazione e di accertamento che, per efficacia e raffinatezza, non hanno eguali negli altri paesi europei. La magistratura giudicante ha svolto una costante e faticosa opera di tutela della legalità. Il Governo, in particolare per tramite del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, ha dato un impulso straordinario alla lotta contro le droghe, coordinando gli sforzi di tutte le istituzioni del terzo settore e investendo risorse umane ed economiche significative in una battaglia di civiltà che non trova riscontro negli altri paesi occidentali.
Pino Arlacchi, già direttore dal 1977 al 2012 dell’UNDCCP (Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo delle droghe e la prevenzione del crimine) ha rilevato qualche anno addietro “che l’organica e seria attività di prevenzione e di repressione della droga e di persecuzione delle organizzazioni criminali che la trafficano ha fornito negli ultimi trent’anni “risultati di assoluto rilievo, superiori a quelli di ogni altro Paese occidentale”. Si è verificata una riduzione dei morti per overdose dell’80% dalla metà degli anni 1990 al 2020, da 1.600 a 308, e un dimezzamento di quasi tutti gli altri indicatori connessi al traffico, al trattamento, alla pericolosità e ai prezzi degli stupefacenti, soprattutto di quelli più dannosi. In parallelo anche la criminalità violenta ha subito durissime sconfitte, tanto che il numero di omicidi dovrebbe essere sceso nel 2021 sotto le trecento vittime da quasi duemila all’inizio degli anni 1990, segnando il tasso più basso del mondo occidentale (5).
4. Infine, forse soltanto in Italia, si è sviluppata una rete di volontariato sistematico i cui componenti, in modo assiduo e competente, dedicano parte o la completa loro esistenza alla prevenzione, alla cura e al recupero delle dipendenze, in particolare dagli stupefacenti. Si tratta di una realtà sommersa che rivela la generosità di una gran parte del nostro popolo, capace di spendersi contro i fenomeni degenerativi e disgregativi della società per il bene dei più poveri e fragili.
Dal 1981 ogni anno il 26 giugno le Nazioni Unite celebrano la Giornata internazionale per la lotta contro la droga. Quest’anno la giornata si è celebrata a Roma, nella cornice del Giubileo della Speranza.
Il mondo del volontariato ha incontrato il Santo Padre Leone XIV.
Le parole pronunciate nell’occasione da Alfredo Mantovano, che ha la responsabilità politica del Dipartimento delle politiche contro la droga, in quanto Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, meritano di essere ricordate, poiché esse smentiscono gli asserti più tenaci dell’ideologia drogastica, quando cercano di convincere che la libertà significherebbe fare tutto quello che si vuole, e, quindi, anche assumere la droga o darsi la morte.
Con ciò una voce di speranza è stata autorevolmente diffusa nell’occasione più propizia: la celebrazione, appunto, del Giubileo della Speranza, nell’auspicio che la logica della solidarietà vinca la logica della chiusura egoistica in se stessi.
Presentando al Papa il mondo di coloro che dedicano la propria esistenza alla prevenzione, alla cura e al recupero delle dipendenze, Mantovano ha detto: “È un mondo che per troppo tempo ha operato nell’indifferenza generale, ma che oggi vede finalmente le istituzioni al proprio fianco, vorrei dire al proprio interno. Dall’avvio del nostro mandato, alla fine del 2022, abbiamo scelto di lavorare insieme: comunità, enti del Terzo settore, società scientifiche, medici, operatori sanitari, servizi pubblici per le dipendenze, regioni, enti territoriali, governo nazionale. Ciascuno per la sua parte, tutti animati dalla consapevolezza che la tossicodipendenza non è una questione meramente sanitaria: è una sfida culturale e umana, il cui presupposto, non soltanto teorico, è capire bene che cosa vuol dire essere liberi.”
E ancora: “Comporta fatica spiegare che la droga fa male, che distrugge la vita, che rende schiavi e succubi, che promette qualcosa che non può dare e in cambio si appropria della felicità reale: ogni droga, senza distinzioni fra “leggere” o “pesanti”. Comporta fatica per un giovane affrontare un percorso di recupero, perché deve combattere anzitutto contro sé stesso. Comporta fatica per un genitore non voltare lo sguardo, prendersi il carico quotidiano di mortificazioni e di umiliazioni, scoprirsi debole e chiedere aiuto. Comporta fatica per l’operatore del servizio pubblico e della comunità stare dietro, passo dopo passo, a chi è caduto nella dipendenza, condividerne la lotta, le oscurità, le resistenze.
Ma è una bella fatica, carica di amore e di speranza: il contrario della rassegnazione! Non ci rassegniamo al narcotraffico che minaccia intere Nazioni: da tempo le forze di polizia e la magistratura italiane lavorano attivamente per contrastarlo, collaborando con i loro omologhi anche nella Sua amata America Latina. Non ci rassegniamo alle scene di abbandono e di morte che sconvolgono le strade delle città, dove si spacciano e si consumano gli oppioidi sintetici, in primis il Fentanyl. Non ci rassegniamo ad applicare a chi ha una dipendenza l’etichetta dell’indifferenza, riflesso di quella “cultura dello scarto” costantemente denunciata dall’altro Suo amato predecessore, Papa Francesco”.
(1) Le Monde, 3 agosto 2025.
(2) F. Mantovani, Ideologie della droga e politica antidroga, Relazione al I Convegno su Tossicodipendenza, processo penale e riabilitazione, organizzato dall’Associazione famiglie del Centro di solidarietà di Firenze, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, 369-380, ora in Umanità e razionalità del diritto penale, Padova, 2008, 990.
(3) Così M. Ronco, Profili criminologici della diffusione della droga, in Aa.Vv., Droga. Le ragioni del no, A. Mantovano (a cura di), Siena, 2022, 133-169.
(4) M. Pantaleone, Mafia e Droga, Torino, 1962, 71 ss.
(5) P. Arlacchi, Perché dico no alla cannabis legale, in Corriere della Sera, 5 dicembre 2021.