 Abstract: la cultura “antitotalitaria” nell’Italia della prima Repubblica. Intervista a Roberto Pertici, che insegna Storia contemporanea all’Università di Bergamo. In apertura dell’ultimo suo libro È inutile avere ragione. La cultura “antitotalitaria” nell’Italia della prima Repubblica edito da Viella nel novembre 2021 dopo un primo capitolo dove l’autore fa delle osservazioni introduttive che, sole, meritano l’acquisto del volume, ripropone sei saggi pubblicati tra il 2003 e il 2017 in cui ragiona sull’oblio culturale del fenomeno “comunismo” in Italia
Abstract: la cultura “antitotalitaria” nell’Italia della prima Repubblica. Intervista a Roberto Pertici, che insegna Storia contemporanea all’Università di Bergamo. In apertura dell’ultimo suo libro È inutile avere ragione. La cultura “antitotalitaria” nell’Italia della prima Repubblica edito da Viella nel novembre 2021 dopo un primo capitolo dove l’autore fa delle osservazioni introduttive che, sole, meritano l’acquisto del volume, ripropone sei saggi pubblicati tra il 2003 e il 2017 in cui ragiona sull’oblio culturale del fenomeno “comunismo” in Italia
Il Corriere del Sud 10 Febbraio 2022
Intervista a Roberto Pertici: La cultura “antitotaliaria”
nell’Italia della prima Repubblica
di Andrea Bartelloni
“Arcipelago Gulag di Aleksandr Solgenitsin, I racconti della Kolyma di Varlam Salamov, Gulag di Anne Applebaum, Koba il terribile di Martin Amis, Il Grande Terrore di Robert Conquest, Il secolo delle idee assassine di Robert Conquest, Le origini del totalitarismo di Hannah Arendt,
 La società aperta e i suoi nemici di Karl Raimund Popper, Prigioniera di Stalin e Hitler di Margarete Buber-Neumann, Il corsivo è mio di Nina Berberova, Ritorno dall’Urss di André Gide, Tutto scorre di Vasilij Grossman, Il passato di un’illusione di François Furet, L’epoca e i lupi di Nadezda Mandel’stam, tutte le opere di Osip Mandel’stam, tutte le opere di Marina Cvetaeva, tutte le opere di Anna Achmatova, tutte le opere di George Orwell,
La società aperta e i suoi nemici di Karl Raimund Popper, Prigioniera di Stalin e Hitler di Margarete Buber-Neumann, Il corsivo è mio di Nina Berberova, Ritorno dall’Urss di André Gide, Tutto scorre di Vasilij Grossman, Il passato di un’illusione di François Furet, L’epoca e i lupi di Nadezda Mandel’stam, tutte le opere di Osip Mandel’stam, tutte le opere di Marina Cvetaeva, tutte le opere di Anna Achmatova, tutte le opere di George Orwell,
L’uomo in rivolta di Albert Camus, La mente prigioniera di Czeslaw Milosz, Un mondo a parte di Gustaw Herling, Il dottor Zivago di Boris Pasternak, Commissariato degli archivi di Alain Jaubert, Buio a mezzogiorno di Arthur Koestler, Il dio che è fallito di Koestler, Silone, Wright, Gide, Spender, Fisher, Novecento il secolo del male di Alain Besançon, I fantasmi di Mosca di Enzo Bettiza, Il regime bolscevico di Richard Pipes,
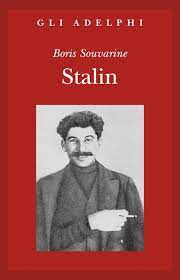 Togliatti 1937 di Renato Mieli, Memorie di un rivoluzionario di Victor Serge, Autobiografia 1945-1963 di Emmanuel Le Roy Ladurie, Nemici del popolo di Nicolas Werth, L’utopia al potere di Mihail Geller e Aleksandr Nekric, Stalin di Boris Souvarine, La scheggia di Vladimir Zazubrin, Viaggio nella vertigine di Evgenia Semionovna Ginzburg, Lettere a Olga di Vaclav Havel, Cime abissali di Aleksandr Zinoviev, tutte le opere di Milan Kundera,
Togliatti 1937 di Renato Mieli, Memorie di un rivoluzionario di Victor Serge, Autobiografia 1945-1963 di Emmanuel Le Roy Ladurie, Nemici del popolo di Nicolas Werth, L’utopia al potere di Mihail Geller e Aleksandr Nekric, Stalin di Boris Souvarine, La scheggia di Vladimir Zazubrin, Viaggio nella vertigine di Evgenia Semionovna Ginzburg, Lettere a Olga di Vaclav Havel, Cime abissali di Aleksandr Zinoviev, tutte le opere di Milan Kundera,
Il tempo della malafede di Nicola Chiaromonte, la collezione completa della rivista «Tempo Presente», Intervista politico-filosofica a Lucio Colletti, Atlante ideologico di Alberto Ronchey, Storia delle democrazie popolari di François Feijto, La nuova classe di Milovan Gilas, Due anni di alleanza germano-sovietica di Angelo Tasca. Tutte le opere di Filippo Turati”.
alleanza germano-sovietica di Angelo Tasca. Tutte le opere di Filippo Turati”.
Questo elenco, preparato da Pierluigi Battista e pubblicato sul Corriere della Sera del 24 gennaio 2021, viene riproposto da Roberto Pertici, che insegna Storia contemporanea all’Università di Bergamo, in apertura dell’ultimo suo libro È inutile avere ragione. La cultura “antitotalitaria” nell’Italia della prima Repubblica edito da Viella nel novembre 2021 e che, dopo un primo capitolo dove l’autore fa delle osservazioni introduttive che, sole, meritano l’acquisto del volume, ripropone sei saggi pubblicati tra il 2003 e il 2017.
 L’elenco di Battista rappresenta quello che è stato in Italia l’oblio culturale del fenomeno “comunismo” e a riprova, entrate in una libreria e provate a cercare due/tre titoli tra quelli citati qui sopra! Sarà molto difficile. Perché? Perché «queste opere (…), non hanno mai ottenuto una vera cittadinanza in Italia (…) non sono divenute parte integrante di quel “senso comune storiografico” con cui ragiona da noi il cosiddetto “pubblico colto” (ammesso che esista)». Giudizio senza appello, questo di Pertici?
L’elenco di Battista rappresenta quello che è stato in Italia l’oblio culturale del fenomeno “comunismo” e a riprova, entrate in una libreria e provate a cercare due/tre titoli tra quelli citati qui sopra! Sarà molto difficile. Perché? Perché «queste opere (…), non hanno mai ottenuto una vera cittadinanza in Italia (…) non sono divenute parte integrante di quel “senso comune storiografico” con cui ragiona da noi il cosiddetto “pubblico colto” (ammesso che esista)». Giudizio senza appello, questo di Pertici?
Ma come è potuto succedere tutto questo?
 Ho cercato di spiegarlo nel libro. La presenza nell’Italia di un forte e abile Partito comunista, che aveva svolto un ruolo importante nella Resistenza e nell’elaborazione della Costituzione, ma che al tempo stesso non ha mai interrotto il suo rapporto organico con l’URSS e col comunismo internazionale (almeno fino al 1981, cioè alla vigilia del crollo di quel mondo) ha impedito che l’anticomunismo democratico entrasse nella coscienza del paese.
Ho cercato di spiegarlo nel libro. La presenza nell’Italia di un forte e abile Partito comunista, che aveva svolto un ruolo importante nella Resistenza e nell’elaborazione della Costituzione, ma che al tempo stesso non ha mai interrotto il suo rapporto organico con l’URSS e col comunismo internazionale (almeno fino al 1981, cioè alla vigilia del crollo di quel mondo) ha impedito che l’anticomunismo democratico entrasse nella coscienza del paese.
La cultura comunista (assecondata, si deve dire, da quella post-azionista e anche da quella dossettiana) ha presentato l’anticomunismo come l’anticamera del fascismo: ogni posizione anticomunista rischia oggettivamente (ecco l’aggettivo magico) di aprire la strada alla destra, questo il suo motivo ricorrente. E siccome, per quella cultura, destra e fascismo sono la stessa cosa (non esiste, cioè, una destra democratica), il cerchio si chiudeva e si chiude.
Si può affermare che l’Italia è una repubblica fondata sull’antifascismo?
 Certo che si può affermare, ma si dovrebbe aggiungere dell’antifascismo democratico, perché all’interno del fronte antifascista era presente anche il comunismo staliniano: la società che gli stalinisti avevano in mente era, per molti aspetti, anche peggiore di quella fascista. Era inevitabile che la nuova Repubblica democratica si costruisse un pedigree: alcune forze (liberali, socialisti riformisti, repubblicani, ma anche De Gasperi e gli uomini della generazione popolare) proponevano di risalire anche alle tradizioni liberali e democratiche del Risorgimento, con ragione, aggiungo io.
Certo che si può affermare, ma si dovrebbe aggiungere dell’antifascismo democratico, perché all’interno del fronte antifascista era presente anche il comunismo staliniano: la società che gli stalinisti avevano in mente era, per molti aspetti, anche peggiore di quella fascista. Era inevitabile che la nuova Repubblica democratica si costruisse un pedigree: alcune forze (liberali, socialisti riformisti, repubblicani, ma anche De Gasperi e gli uomini della generazione popolare) proponevano di risalire anche alle tradizioni liberali e democratiche del Risorgimento, con ragione, aggiungo io.
Ma hanno vinto coloro che volevano allontanare e negare il retroterra risorgimentale, sottolineando lo sbocco fascista dello Stato post-risorgimentale: comunisti, azionisti e dossettiani.
Anche a trent’anni dalla fine dell’Unione Sovietica questo (antifascismo) è ancora necessario?
 È necessario come una componente fra le altre di una cultura democratica, che dovrebbe circolare nelle scuole e nell’opinione pubblica italiana: ma questa cultura è molto più vasta e molto più antica dell’antifascismo.
È necessario come una componente fra le altre di una cultura democratica, che dovrebbe circolare nelle scuole e nell’opinione pubblica italiana: ma questa cultura è molto più vasta e molto più antica dell’antifascismo.
Va dall’umanesimo cristiano di Erasmo al costituzionalismo sei-settecentesco di Locke e Montesquieu, al liberalismo ottocentesco di Tocqueville e di Cavour, al socialismo umanitario e riformista fra Otto e Novecento. E all’anticomunismo democratico di De Gasperi (in Italia), di Orwell, Camus, Aron a metà Novecento, fino alla cultura del dissenso dei paesi dell’est, da Solženicyn a molti degli autori citati da Battista.
 Ma i comunisti sono stati sempre estranei a tutta questa cultura: ammettere che essa avesse ragione, significava negare 70 anni di comunismo in Italia e nel mondo.
Ma i comunisti sono stati sempre estranei a tutta questa cultura: ammettere che essa avesse ragione, significava negare 70 anni di comunismo in Italia e nel mondo.
E questo non se lo potevano permettere, non potevano permettersi di dire: scusate! Abbiamo sbagliato tutto fin dall’inizio. Ecco allora la centralità dell’antifascismo nella loro visione: l’unica stagione in cui potevano dire di “avere avuto ragione”.
Ed ecco allora l’assolutizzazione del fascismo e la sua riproposizione come spettro immanente della politica italiana, contro cui mobilitarsi e rinnovare l’union sacrée dell’antifascismo militante.
Cosa intende per cultura “antitotalitaria”?
 L’ho scritto nel libro: “Antitotalitaria” è stata (in Italia e non) quella cultura che ha sempre coniugato un radicato antifascismo con un altrettanto radicato anticomunismo.
L’ho scritto nel libro: “Antitotalitaria” è stata (in Italia e non) quella cultura che ha sempre coniugato un radicato antifascismo con un altrettanto radicato anticomunismo.
Al suo interno era convinzione diffusa che l’esperienza fascista fosse morta per sempre e che il vero problema delle democrazie del dopoguerra consistesse nella lotta culturale e politica contro il mondo comunista, non solo là dove ormai era già “sistema”, ma anche nelle sue propaggini occidentali: bisognava, quindi, mutare spalla al proprio fucile.
In questo modo la pensavano più o meno i cattolici della generazione degasperiana, i socialisti democratici e riformisti, i cold war liberals di diverse origini e vari orientamenti. Detto altrimenti: cattolici non integralisti, liberali non laicisti e socialisti non massimalisti. Il problema fondamentale di ogni cultura democratica novecentesca è stato quello di mantenere il giusto equilibrio fra il momento antifascista e quello anticomunista.
 Così la più consapevole cultura “antitotalitaria” del primo ventennio dopo la guerra cercò di evitare un anticomunismo che spingesse alla creazione di un fronte unico con l’estrema destra monarchica e post-fascista o con le forze sociali più conservatrici: di differenziarsi quindi da un «anticomunismo negativo – come lo avrebbe definito Augusto Del Noce – che pensa come ideale alla costituzione di un blocco generale delle forze anticomuniste, che inevitabilmente sarebbe un blocco di interessi anziché di idee» e che spesso riduceva il comunismo «a un fenomeno fronteggiabile con provvedimenti di polizia».
Così la più consapevole cultura “antitotalitaria” del primo ventennio dopo la guerra cercò di evitare un anticomunismo che spingesse alla creazione di un fronte unico con l’estrema destra monarchica e post-fascista o con le forze sociali più conservatrici: di differenziarsi quindi da un «anticomunismo negativo – come lo avrebbe definito Augusto Del Noce – che pensa come ideale alla costituzione di un blocco generale delle forze anticomuniste, che inevitabilmente sarebbe un blocco di interessi anziché di idee» e che spesso riduceva il comunismo «a un fenomeno fronteggiabile con provvedimenti di polizia».
 Mentre per Del Noce e per quelli che la pensavano come lui, il comunismo costituiva una sfida di alto profilo, anche perché convogliava alcune delle tendenze di fondo della cultura contemporanea, e quindi esigeva una risposta adeguata.
Mentre per Del Noce e per quelli che la pensavano come lui, il comunismo costituiva una sfida di alto profilo, anche perché convogliava alcune delle tendenze di fondo della cultura contemporanea, e quindi esigeva una risposta adeguata.
La cultura di cui parlo in questo libro operava, in modo più o meno esplicito, una distinzione di grande rilievo e, a parer mio, degna di essere mantenuta: fra l’antifascismo “storico” (pre-1945) e quello “ideologico” (post-1945).
 Si richiamava costantemente al primo, pur non prendendolo in blocco, essendo presenti al suo interno anche tradizioni non compatibili con la democrazia. Ma era estranea al secondo, che concepiva il fascismo come un pericolo eterno della politica italiana, contro il quale era quindi necessaria una mobilitazione permanente: concezione presente in varie forze (comunisti, socialisti, post-azionisti, cattolici dossettiani) fin dall’immediato dopoguerra.
Si richiamava costantemente al primo, pur non prendendolo in blocco, essendo presenti al suo interno anche tradizioni non compatibili con la democrazia. Ma era estranea al secondo, che concepiva il fascismo come un pericolo eterno della politica italiana, contro il quale era quindi necessaria una mobilitazione permanente: concezione presente in varie forze (comunisti, socialisti, post-azionisti, cattolici dossettiani) fin dall’immediato dopoguerra.
L’antifascismo come ideologia altro non era che una «formula» (così la pensavano gli “antitotalitari”) funzionale a determinati disegni politici, anche se non sempre convergenti: la legittimazione del partito comunista come cardine della democrazia italiana, la condanna di ogni anticomunismo, l’illegittimità politico-culturale di una qualsiasi formazione alla destra della DC, come anche delle correnti anticomuniste all’interno di quel partito, e talora – nelle frange della “nuova sinistra” – la critica radicale della repubblica nata da una Resistenza abortita e tradita.
È veramente “inutile avere ragione” o è sempre meglio che essere vissuti nella menzogna?
 È una bella domanda: è chiaro che è meglio essere dalla parte della ragione, pur senza riuscire a farla vincere, questa ragione, piuttosto che vivere nella menzogna.
È una bella domanda: è chiaro che è meglio essere dalla parte della ragione, pur senza riuscire a farla vincere, questa ragione, piuttosto che vivere nella menzogna.
Ma la testimonianza personale non basta e gli eredi della cultura antitotalitaria si dovrebbero interrogare anche autocriticamente sulle ragioni della propria emarginazione: insomma le lamentele, le polemiche retrospettive e le recriminazioni non sono sufficienti.
 La logica del we few, we happy few è fallace, sia sul piano politico che su quello culturale.
La logica del we few, we happy few è fallace, sia sul piano politico che su quello culturale.
Quando si perde, la prima cosa da fare è riflettere sui propri errori, non incolpare i complotti degli altri, o magari il destino cinico e baro.
Lo insegnava ai suoi un grande maestro di politica come Togliatti: proprio questo suo realismo, questa sua consapevole opera di pedagogia politica e di formazione di un gruppo dirigente che imparasse a ragionare come lui, sono stati una delle chiavi del successo comunista nella società e nella cultura dell’Italia della prima Repubblica.
________________________________________________
Leggi anche:
Dopo la Storia: su due libri di Roberto Pertici
L’Italia dei vinti nell’analisi di Roberto Pertici
«L’Italia ha perso il passato Ormai siamo diventati consumatori del presente»





