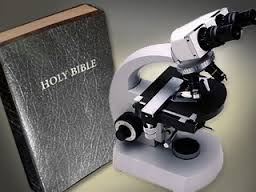 Questi appunti sono la rielaborazione riassuntiva delle quattro lezioni tenute dal dott. Luciano Benassi alla Scuola di Educazione Civile sul tema Storia della Scienza il 7 marzo, l’11 aprile, il 16 maggio e il 6 giugno 1996.
Questi appunti sono la rielaborazione riassuntiva delle quattro lezioni tenute dal dott. Luciano Benassi alla Scuola di Educazione Civile sul tema Storia della Scienza il 7 marzo, l’11 aprile, il 16 maggio e il 6 giugno 1996.(dott. Luciano Benassi)
L’apparente contraddizione è dovuta al un luogo comune fortemente radicato nell’opinione corrente secondo cui mondo della scienza e mondo della religione sono fra loro irriducibili e, per quanto riguarda il cristianesimo, anche nemici. Gli studi più seri sulle nuove religiosità hanno tuttavia contribuito in modo rilevante a svelare questo carattere profondamente ambiguo della modernità.
In particolare hanno mostrato come modernità scientifico-positivista e credenze mitiche non siano affatto, come comunemente si crede, due mondi contrapposti, ma piuttosto due facce della stessa medaglia, fra le quali si dipana una fitta rete di rapporti storici, sociologici e psicologici.
La “medaglia” è, chiaramente, l’esigenza profonda che alberga in ogni uomo di dare un senso alla propria esistenza, mentre le due facce sono i modi fondamentali di interrogare il reale per raggiungere lo scopo. La scienza ha come oggetto il creato naturale, la cui intelligibilità e razionalità sono il presupposto per la formulazione delle leggi scientifiche; la religione nasce dalla naturale propensione della ragione a ritenere che la totalità di ciò che esiste debba avere un Creatore, e che tale Creatore sia degno di fede e meriti un culto.
Scienza e religione non hanno, dunque, lo stesso obiettivo, ma si fondano sul medesimo ordine che l’indagine razionale del mondo svela e offre ad ogni mente libera e onestamente disposta ad accogliere il vero: “È un ordine – diceva papa Pio XII l’8 febbraio 1948, in un discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze – che il vostro intelletto e la vostra mano rinvengono derivante immediatamente dalle intime tendenze insite nelle cose naturali; ordine che nessuna cosa può crearsi o darsi da sé, come non può darsi l’essere; ordine che dice Ragione Ordinatrice in uno Spirito, che ha creato l’universo, e da cui ‘dipende il cielo e tutta la natura’ (Par., XXVIII, 42); ordine che hanno ricevuto con l’essere quelle tendenze ed energie, e con cui le une e le altre collaborano a un mondo ben ordinato. Questa meravigliosa compagine delle leggi naturali, che lo spirito umano con instancabile osservazione e accurato studio ha scoperte e che voi sempre più andate investigando, aggiungendo vittorie a vittorie sulle occulte resistenze delle forze della natura, che è mai se non un’immagine, pur pallida e imperfetta, della grande idea e del gran disegno divino, che nella mente di Dio creatore è concepito quale legge di questo universo fin dai giorni della sua eternità?“.
Lo scopo di queste lezioni è quello di dimostrare che “la strada della scienza e le vie verso Dio” – per usare il titolo di un’ opera di dom Stanley L. Jaki, accademico pontificio e fra le massime autorità mondiali nel campo della storiografia scientifica – “costituiscono un unico percorso intellettuale: una scienza fattibile è nata e si è sviluppata solo all’interno di una matrice culturale permeata dalla ferma convinzione che la mente umana fosse capace di individuare nel regno delle cose e delle persone un segno del loro creatore. Tutti i grandi progressi creativi della scienza sono stati compiuti nel quadro di un’epistemologia strettamente imparentata con questa convinzione. Di più: ogni volta che questa epistemologia ha incontrato un’opposizione abbastanza forte e coerente l’attività scientifica è rimasta evidentemente priva di solide basi“.
In altri termini, si può affermare che l’impresa scientifica, cioè la scienza come approccio razionale alla natura, è possibile soltanto all’interno di una concezione realistica dell’essere. Al di fuori di questa concezione, l’osservazione del mondo naturale ha prodotto esclusivamente modelli bizzarri e congetture inverosimili, mortificando la propria capacità di contribuire alla conoscenza. Fra i tanti modi per affrontare e chiarire il rapporto fra scienza e fede, il punto di vista che ho appena descritto, si può riassumere nelle due domande cruciali: perché la scienza? perché la scienza solo in Occidente?
Esistono certamente altri accostamenti al tema, tutti meritevoli della massima attenzione e tutti, per così dire, di frontiera, cioè ai confini fra scienza, filosofia e teologia. Basti pensare
– al caso Galileo, con le sue implicazioni di carattere storico e teologico;
– al problema dell’origine e dello sviluppo della vita sulla terra e alla conseguente polemica evoluzionismo-creazionismo;
– alle teorie e alle scoperte della fisica del nostro secolo, come la meccanica quantistica e la cosmologia del big-bang;
– alle questioni sollevate dalle neuroscienze sul rapporto mente-corpo, con implicazioni sul problema della coscienza e dell’anima;
– ai miracoli, sulla loro definizione e sulla loro identificazione.
Tuttavia, le animate discussioni fra credenti e laici che accompagnano i dibattiti su questi e altri temi, finiscono quasi sempre in un rilancio di impossibili “argomenti decisivi” che, di volta in volta, dovrebbero mettere in difficoltà l’avversario, ma che la scienza non può fornire.
In questo gioco di rimbalzi i credenti, se non sono abbastanza accorti, cioè se in loro non è ben chiara la distinzione fra fiducia di conoscere le cose, atto di fede e conoscenza scientifica hanno di solito la peggio, perché rischiano di essere attirati sullo stesso terreno dello scientismo dominante, che banalizza e schernisce ogni argomentazione che non sia “scientifica”, laddove invece il discorso dovrebbe essere esteso oltre i limiti del sapere scientifico.
Il mondo cattolico, per esempio, come in preda ad una forma di autocensura, è quasi scomparso di fronte al dilagare della pubblicistica scientifico-divulgativa che ha invaso le librerie negli ultimi trent’anni. E dove era presente, ha per lo più giocato di rimessa, come spiazzato dal susseguirsi delle scoperte scientifiche e, soprattutto, dal susseguirsi delle interpretazioni – sempre in senso laicista – di quelle scoperte.
Ne è risultato un atteggiamento ambiguo, caratterizzato da slanci e aperture, da complessi di colpa per colpe mai commesse, da diffidenza e da reverenziali timori verso il mondo della scienza, sentito come un dato problematico per il sistema cattolico.
È quanto mai urgente, dunque, recuperare il rapporto originale fra scienza e fede, non solo affrontando singole questioni, come quelle che ho appena ricordato, ma delineando anche una visione di insieme nella quale la scienza appaia come una dilatazione naturale di una cultura fortemente radicata nella nozione di Dio creatore.
Le nascite abortite della scienza
Il già citato dom Stanley L. Jaki, ha fatto rilevare come la storiografia scientifica dominante ignori un dato essenziale e del tutto evidente quando si voglia analizzare la nascita e lo sviluppo della scienza: le grandi civiltà del passato non hanno conosciuto le scienze della natura, almeno come noi le intendiamo da quattro secoli a questa parte.
Il fatto che questo dato macroscopico sia taciuto, minimizzato o semplicemente spiegato con il ricorso ad argomentazioni parziali, è altamente indicativo della mentalità darwinista adottata dai maggiori storici della scienza negli anni 1950. Il darwinismo, che già all’inizio del secolo aveva costituito la base scientifica all’ideologia del Progresso, offriva ora agli studiosi una visione della scienza “come una lotta essenzialmente cieca di idee in competizione tra loro, ciascuna con la sua propria capacità di sopravvivenza“.
Nasceva il cosiddetto paradigmismo, la dottrina storiografica di Thomas Kuhn, secondo cui i grandi progressi scientifici avvengono attraverso “rivoluzioni” che servono per formare il consenso intorno a un nuovo complesso di nozioni, il paradigma appunto, il cui destino è quello di essere soppiantato in modo traumatico da un nuovo paradigma.
In questa visione delle cose, nella quale si sono formate almeno due generazioni di storici e di uomini di scienza, non c’è posto per nessuna preoccupazione di tipo causale: l’impresa scientifica “appare”, semplicemente, in analogia con la comparsa degli eventi biologici nella teoria evoluzionista e, se si adatta alle condizioni del momento, viene selezionata.
In questo schema artificioso, tuttavia, una certa coerenza esiste: come il darwinismo fatica a spiegare l’esistenza dei “rami secchi” ai lati del grande tronco evolutivo, anche il paradigmismo non spiega i “rami secchi” dell’evoluzione scientifica. In culture antiche come quella egiziana, indiana e cinese, per esempio, si osserva come impressionanti scoperte scientifiche e stupefacenti conquiste tecnologiche confluiscano invariabilmente verso un punto morto finale. Vediamo un po’ più da vicino questo fenomeno.
L’antico Egitto
Le testimonianze dell’abilità tecnologica degli antichi egiziani sono innumerevoli: dalle piramidi alle tecniche idrauliche per il controllo delle inondazioni. Basta visitare una piramide o un museo di arte egizia per rendersi conto del loro elevato tasso di abilità tecnologica.
Tuttavia la matematica, cioè la razionalizzazione di quantità, misure e calcoli, rimase un’arte pratica che non raggiunse mai lo stadio di generalizzazione necessario per spiegare classi di fenomeni.
Erodoto racconta di un viaggio per mare compiuto da marinai egiziani al tempo del regno di Nekao (610-595 a.C.), durato tre anni e iniziato lungo le coste orientali dell’Africa, in direzione sud. Al loro ritorno, dalla parte della Libia, i marinai raccontarono che per un po’ di tempo, mentre doppiavano quello che sarebbe stato chiamato il Capo di Buona Speranza, essi videro il sole brillare alla loro destra. Gli egiziani, molto prima che i Greci incominciassero a discutere della questione, avevano in mano la prova della sfericità della terra, ma la ignorarono.
Gli esempi potrebbero continuare, ma ci fermiamo qui. A questo punto i sostenitori del paradigma direbbero che gli antichi egiziani non riuscirono a sviluppare maggiormente la scienza perché non ne sentirono la necessità.
La spiegazione pecca di presunzione. “Per quale ragione – si interroga dom Stanley L. Jaki – dovremmo supporre che […] fossero così insensibili al loro stesso benessere da accontentarsi semplicemente di un’arte medica che somministrava di gran lunga più veleno che cure? […] Per quale ragione le loro menti migliori avrebbero dovuto considerarsi soddisfatte dopo la conquista di successi quali il controllo delle inondazioni del Nilo? Dopo tutto, essi non erano lenti ad adottare dai paesi vicini armi sempre migliori – per esempio le bighe da guerra – ogni volta che se ne presentasse l’occasione“.
Tuttavia non si spinsero mai oltre un ambito strettamente applicativo. Il loro atteggiamento nei confronti della natura appare caratterizzato da una enorme erudizione incapace, però, di produrre curiosità. Un egittologo ha affermato che “l’impressione lasciata in una mente moderna è quella di un popolo che cerca nel buio la chiave della verità, ed avendone trovata non una, ma molte, che si adattano al profilo della serratura, le tiene tutte per paura di potere scartare quella giusta“.
La causa della sterilità scientifica degli antichi egiziani va cercata, dunque, in una sorta di impasse che bloccava la loro mente di fronte al cosmo: da un lato le straordinarie nozioni acquisite dovevano suggerire loro l’esistenza di una natura ordinata, ma dall’altro essi manifestavano una sfiducia di fondo nella razionalità complessiva dell’universo.
La loro concezione del cosmo era animista, come testimoniano le grottesche combinazioni di uomo e animale simboleggianti le divinità che presiedevano alle forze della natura. In un cosmo siffatto non poteva trovare posto l’indagine scientifica e le sincere aspirazioni ad un’esistenza migliore – testimoniate dalla loro poesia – rimasero lettera morta.
L’antica India
Presso gli antichi Indù, la visione animistica della totalità dell’esistenza era ancora più marcata e produsse immagini mitologiche di straordinario vigore espressivo. Essi vedevano se stessi come parte di una natura e di un universo interamente impregnati di una vitalità biologica e personale. L’universo è visto, di volta in volta, come un enorme uovo collocato nel ventre di una divinità bisessuale, oppure come il prodotto della traspirazione del corpo di Visnu rappresentato da acque senza fondo: da ogni follicolo usciva un universo in forma di bolla che poco dopo scoppiava.
La caratteristica delle cosmogonie induiste è quella di presentare un ineluttabile ciclo di nascita-morte-rinascita, senza inizio né fine e sostanzialmente privo di senso. La ritualità religiosa induista e la letteratura etica e mitologica – come quella dei Purana, composti intorno al 500 d.C. – testimoniano di un drammatico bisogno di sfuggire al carattere sinistro e soffocante del grande “mulino cosmico” che ciclicamente ritorna su se stesso.
La costruzione degli edifici, per esempio, era accompagnata da una serie di gesti simbolici che rivelano il desiderio di esorcizzare il dominio del tempo (l’astrologo indicava il luogo su cui posare la pietra angolare, luogo che doveva collegare l’edificio al centro del mondo; il muratore, a sua volta, infilava un piolo nel terreno per immobilizzare la testa del serpente, simbolo del caos. Con questa azione egli ripeteva il gesto di Indra, che vinse il serpente con il fulmine e assicurò stabilità e atemporalità a ciò che era stato creato da caos).
Tra gli effetti di questa concezione del cosmo ci fu la rassegnazione all’era di Kaliyuga, il tempo lunghissimo dell’ignoranza, della povertà e delle malattie che, secondo il calendario, doveva durare circa 400 mila anni. L’impatto di una simile credenza sulla vita civile e culturale delle popolazioni indù fu un clima di generale rassegnazione e fatalismo.
Le parole del re Brihadrata nelle Svetasvatara Upanishad – “Nel ciclo dell’esistenza sono come una rana in un pozzo senz’acqua” – sono l’ammissione dell’impossibilità di uscire dai cicli eterni della ruota cosmica. Dal punto di vista del pensiero scientifico, un universo ciclico e oscuramente vitalistico come quello indù è l’esatto contrario di ciò che può essere interrogato scientificamente.
“Non che mancasse il talento” spiega dom Stanley L. Jaki. “L’antica India è il luogo della nascita del calcolo decimale – compreso il valore posizionale per i multipli di dieci e per lo zero, forse la più grande scoperta scientifica mai fatta. Ci si aspetterebbe che il continuo uso dello zero matematico avrebbe dovuto sensibilizzare sulla differenza tra essere e non-essere. E lo fece, ma solo per rafforzare la convinzione che ciò che è, deve essere da sempre e non potrebbe mai mancare di esistere“.
L’ ombra della cosmogonia induista si è estesa nella storia fino all’India moderna, con la sua incapacità di produrre progresso materiale in modo organico e in collegamento con una mentalità scientifica. Lo stesso Gandhi, considerato il padre dell’India moderna, idealizzava il pensiero indù tradizionale al punto da ritenere preferibile la sua civiltà senza macchine e senza tecnologia, dove “usiamo lo stesso tipo di aratro che esisteva migliaia di anni fa“, ai “sistemi di competizione che consumano la vita“.
In un servizio del New York Times del 10 maggio 1987 si può leggere che in India il rapporto tra vacche sacre e popolazione umana è di 1 a 2, mentre solo 1/3 dei 500 mila piccoli villaggi è collegato alle città da strade, peraltro percorribili solo con carri trainati da buoi o con jeep sofisticate.
Il mito della Cina “moderna”
Chiudo questa rassegna sulle nascite abortite della scienza in Estremo Oriente parlando brevemente della Cina, un altro caso clamoroso di occasioni mancate per lo sviluppo scientifico. Artisti e letterati videro nella Cina un’alternativa alla delusione verso la scienza maturata sulla scia della prima guerra mondiale. Il motivo dominante di quella curiosità verso il gigante asiatico era l’opinione – attribuita ai saggi cinesi tradizionali – secondo cui non c’era bisogno di alcuna scoperta scientifica per illuminare la mente dell’uomo poiché bastavano la filosofia e la religione.
L’uomo cinese “sentiva la continuità dell’universo: riconosceva il legame tra la sua vita e quella di animali, uccelli, alberi e piante. E pertanto si accostava alla vita con rispetto, attribuendo ad ogni esistenza il suo giusto valore“. Questa osservazione, fatta negli anni 1950 da uno studioso di cose orientali, è ancora molto attuale in tempi di ecologismo profondo e di new age.
Tuttavia essa presenta una contraddizione evidente: se la cultura cinese non ha mai prodotto la scienza, quale merito può avere nel non esserne mai stata delusa? Quale merito si può riconoscere ad una civiltà per il fatto di non essere mai stata delusa dalla pittura e dalla musica, se essa non ha mai prodotto pittori o musicisti?
Contraddizioni di questo tipo erano ugualmente presenti anche in affermazioni di intellettuali occidentali di formazione scientifica. Bertrand Russell fu uno di questi. Molto prima dell’avvento del comunismo in Cina e molto prima della rivoluzione culturale di Mao Tse Tung – che alla fine degli anni 1960 suscitò tanti entusiasmi fra i gauchiste nostrani -, Bertrand Russell tentò di conciliare l’evidente arretratezza delle conoscenze scientifiche in Cina con il fatto che la millenaria cultura cinese, in apparenza, non avesse niente di ostile contro di esse, e anzi ne pronosticò il sicuro diffondersi senza “nessuno di quegli ostacoli che la Chiesa pose al loro avanzare in Europa“.
Al di là di queste affermazioni, la contraddizione rimaneva. Mille anni prima i Cinesi conoscevano i magneti, la polvere pirica e la tecnologia della stampa a blocchi, precorritrice della stampa a caratteri mobili: come era possibile che Confucio e la sua dottrina etica non avessero trasmesso nessuna forma di entusiasmo e di curiosità verso quelle novità straordinarie?
Secondo il cliché empirista e baconiano, in virtù del quale la scienza progredisce per piccoli passi, lo stato della scienza in Cina agli inizi del secolo avrebbe dovuto trovarsi in condizioni assai diverse da quello in cui versava poiché la cultura cinese traboccava di conoscenze empiriche. Eppure la curiosità scientifica, che nasce da un atteggiamento di stupore di fronte ad un creato, non prese mai il largo.
Uno dei maggiori studiosi contemporanei di storia della scienza in Cina, John Needham, di formazione marxista, riconosce che le ragioni del fallimento scientifico della civiltà cinese sono di ordine “teologico”. Egli afferma, in particolare, che l’avvento della cultura confuciana ha allontanato i cinesi dalla fede in un solo Dio – creatore e legislatore -. La conseguenza fu l’identificazione quasi panteistica di uomo, società e natura e, quindi, l’impossibilità da parte della mente umana, di comprendere una natura non più soggetta a una signoria trascendente, non più governata da leggi.
Culture non isolate: l’area mesopotamico-mediterranea
Poche considerazioni per rispondere ad un’obiezione naturale che può sorgere di fronte alla tesi sviluppata fino a questo punto. Il tratto comune alle tre antiche civiltà – egiziana, indù e cinese – è che la scienza vi è nata già morta, nonostante la disponibilità, in ciascuna di esse, di talenti, organizzazione sociale e lunghi periodi di pace.
La storiografia scientifica moderna, che normalmente considera questi fattori sociologici determinanti per lo sviluppo scientifico, non spiega questi grandiosi fallimenti. L’obiezione, o spiegazione alternativa a quella “teologica” che abbiamo preso in considerazione, riguarda il fatto che quelle civiltà erano “isolate” le une dalle altre, nello spazio e nel tempo: pertanto – si dice – l’accumulo di conoscenze, per quanto notevole, non fu mai tale da innescare un vero interesse per la natura, cioè un interesse di tipo scientifico.
Come controprova di questa tesi, si può portare il caso del fallimento scientifico nell’area mesopotamico-mediterranea che, quanto a presenza di civiltà e a contatti fra civiltà, non è seconda a nessuno. In questa area geografica, così vicina a noi non solo geograficamente, Sumeri, Babilonesi, Assiri, Persiani, Greci e Arabi costituiscono un caso interessante di successione di civiltà in cui vi è un enorme passaggio di conoscenze, ma senza che in nessuna di esse si verifichi la nascita di qualcosa che assomigli alla scienza.
L’analisi del caso babilonese in particolare dimostra, ancora una volta, che è la concezione del cosmo e della sua origine la causa del fallimento scientifico.
Le scoperte archeologiche relative alla civiltà babilonese rivelano elevatissime conoscenze in campo matematico, astronomico e chimico. Le celebri tavolette di creta ritrovate a partire dal secolo scorso mostrano che i babilonesi conoscevano strutture algebriche riconducibili alle equazioni di secondo grado, elenchi di centinaia di piante e composti chimici accompagnati da descrizioni delle loro proprietà, ed elenchi lunghissimi di posizioni planetarie.
Queste ultime rivelano che Ipparco si basò sui dati astronomici babilonesi per scoprire la precessione degli equinozi, una delle più grandi scoperte scientifiche di tutti i tempi. La stessa scrittura, non geroglifica, è indice di una straordinaria capacità di astrazione. In altri termini, già presso i Babilonesi, sono presenti molte delle condizioni che possono portare alla nascita della scienza.
Tuttavia altre tavolette di creta rivelano che, accanto a questi fatti, convivono credenze mitico-religiose elementari e violente. In un arco di duemila anni, le culture mesopotamiche dimostrano un attaccamento costante a credenze irrazionali circa l’origine del mondo e il suo governo, tutte riconducibili alla concezione del cosmo come un’enorme animale la cui pericolosa irrazionalità può essere placata solo con gesti altrettanto irrazionali.
Le feste di Akitu, una settimana di orge per festeggiare l’inizio del nuovo anno, sono la prova di questo cuore oscuro che pulsa sotto l’apparente “modernità” del mondo mesopotamico. D’altra parte, la stessa narrazione della cosmogonia babilonese, l’Enuma elish, è il racconto di forze della natura personificate, ingaggiate in sanguinose battaglie. E le parti del mondo – cioè il cielo, la terra, le acque e l’aria che altrove diventeranno anche l’oggetto della ricerca scientifica – risultano dallo smembramento della dea madre Tiamat.
È il caso di ricordare qui come sia ancora diffusa la convinzione, presso gli studiosi e presso il pubblico, che la cosmogonia babilonese costituisca il modello seguito dall’autore del primo capitolo della Genesi. “Al massimo – osserva Stanley L. Jaki – quel modello fornisce alcune espressioni verbali, ma certamente non il messaggio di Genesi 1 che, a paragone della Enuma elish, appare come l’incarnazione della stessa razionalità“.
A conclusione di questa parte, il fallimento dell’impresa scientifica nelle culture antiche si può spiegare estendendo ad esse il giudizio che il già citato John Needham formulò riguardo alla Cina: quelle culture persero il coraggio intellettuale di investigare fenomeni di piccola scala dopo avere perduto fiducia nella loro razionalità sulla scala più grande possibile (cioè il cosmo).
Le origini della scienza e la scienza delle origini
Dopo avere identificato gli indizi che avvalorano la tesi di un legame causale fra concezione animistico-panteistica del cosmo e impossibilità per la scienza di vedere la luce, rimane da stabilire la prova “in positivo”, ovvero: quale era la concezione del cosmo e della sua origine dove e quando la scienza ha fatto la sua comparsa?
Se sul luogo in cui la scienza è nata non vi sono dubbi – trattandosi dell’Europa -, sull’epoca in cui questa straordinaria avventura intellettuale è cominciata, i pareri non sono concordi. Non si tratta, però, di una disputa intorno a una data o a un periodo, ma di uno scontro fra due modi di concepire l’impresa scientifica, nel quale i termini ideologici sono dominanti rispetto a quelli fattuali.
L’eco della “leggenda nera” del Medioevo, epoca di oscurantismo e di ignoranza, grava a tal punto sulle ricerche e sui giudizi, che sembra impresa sovrumana ascoltare la voce della verità storica a proposito della “datazione” della scienza. È ormai un dogma, per esempio, che il Padre Fondatore della scienza moderna sia Galileo Galilei (1564-1642); qualcuno, più colto, si spinge fino a Copernico (1473-1543), forse attratto da quello slogan – rivoluzione copernicana – evocatore di ribellione, di trasgressione e di anticonformismo.
Quando poi si pensa alla scienza come alla versione consolidata delle leggi della meccanica, allora il pensiero corre a Isaac Newton (1642-1727) e al “secolo del genio” (il XVII) – come lo battezzò A.N. Whithead -. Quel che è certo, è che l’avvento della scienza viene reputato un fatto della “modernità”, un avvenimento irriducibile al mondo oscuro della cristianità medievale.
In realtà, ciò che il grande pubblico fatica a trovare nelle pagine di una pur abbondantissima divulgazione scientifica e storico-scientifica, agli studiosi è perfettamente noto. Le grandi figure della scienza come Copernico, Galileo e Newton non erano solitarie nei loro studi, ma, al contrario, erano inserite in veri e propri filoni di ricerca cui partecipavano molti loro contemporanei, né più né meno come accade oggi.
Non solo: molte delle idee da loro straordinariamente sviluppate, avevano visto la luce ed erano state dibattute in tempi precedenti, come testimonia un’abbondante aneddotica sulla priorità delle scoperte e delle invenzioni. Qualche esempio per tutti:
– Newton e Leibniz sono in polemica per la priorità della scoperta del calcolo infinitesimale sono in polemica per la priorità della scoperta del calcolo infinitesimale
– Newton e Hook si contendono il primato per la scoperta della legge dell’inverso del quadrato del raggio per l’intensità della gravitazione si contendono il primato per la scoperta della legge dell’inverso del quadrato del raggio per l’intensità della gravitazione
– Newton, nel suo trattato di ottica elimina ogni riferimento a Descartes, che a sua volta aveva studiato presso i Gesuiti di La Fleche, nel suo trattato di ottica elimina ogni riferimento a Descartes, che a sua volta aveva studiato presso i Gesuiti di La Fleche
– Galileo rivendica a sé l’invenzione del cannocchiale e omette di citare le fonti dei suoi studi di meccanica non aristotelica, cioè i Gesuiti del Collegio Romano e i Domenicani di Salamanca. rivendica a sé l’invenzione del cannocchiale e omette di citare le fonti dei suoi studi di meccanica non aristotelica, cioè i Gesuiti del Collegio Romano e i Domenicani di Salamanca.
Situazioni analoghe si riscontrano andando a ritroso nel tempo. Lo stesso Copernico rilancia idee già note da quasi due secoli, formulate dai meccanici medievali, in particolare l’affermazione di Nicola Oresme (m. 1382) che la terra in rotazione imprime lo stesso movimento anche ai corpi solidali con essa. Questa dottrina del moto terrestre era, a sua volta, un’applicazione dell’insegnamento del predecessore di Oresme alla Sorbona, Giovanni Buridano (1290 – 1358).
Questi due autori e la scuola filosofica parigina alla quale appartenevano, ci introducono al punto cruciale. Sentiamo ancora Stanley L. Jaki: “La ragione per discutere esplicitamente di Buridano è molto di più che una meticolosità accademica […] Una tale discussione chiarirà la ragione per cui fu così facile a Copernico, Descartes, Keplero, Galileo e molte altre figure minori accettare che tutti i corpi sulla terra ne condividano il movimento, sia rotazionale che orbitale. Spiegherà anche perché Buridano stesso non manifestò alcuna difficoltà intellettuale nell’esprimere quello che può essere considerato a buon diritto come l’atto di nascita della scienza newtoniana e moderna. La spiegazione è che tutti i personaggi in questione credevano in una Nascita salvifica avvenuta un tempo in una mangiatoia“.
La fisica aristotelica
La dinamica dei doctores parisienses, o dinamica dell’impetus, è lo sviluppo di una concezione della dinamica che si fa strada nella prima metà del ‘300, principalmente alla Sorbona. Si tratta di una dottrina del moto locale, cioè di una teoria del movimento dei corpi nello spazio e delle cause di tale movimento.
Non deve stupire che fossero dei filosofi a trattare questo argomento: il moto nello spazio è, in effetti, un caso particolare di mutamento, e lo studio in generale del mutamento degli enti è di pertinenza della filosofia. La dinamica dell’impetus si pone in antagonismo con la dottrina del movimento allora dominante, quella aristotelica.
L’essenziale della dinamica aristotelica è che un corpo, per continuare a muoversi dopo che il “motore” gli ha impresso il primo movimento, ha bisogno di restare in contatto con ulteriori motori per continuare a muoversi.
Aristotele, nel IV e nell’VIII libro della Fisica, enuncia due teorie per spiegare il moto locale: un proietto continua a muoversi, dopo che è cessato il contatto con ciò che lo ha mosso, a causa di motori intermedi (costituiti di materia atta a produrre movimento, come aria o acqua) che si sostituiscono, al progredire del moto del proietto, e rimangono contigui ad esso fino alla conclusione naturale del movimento. teoria dell’antiperistasis: l’aria assicura la continuità del moto sostituendosi dietro al proietto, operando come un motore.
Nel ‘300 la critica alle teorie aristoteliche viene a maturazione. Buridano osserva che esistono fenomeni nei quali il movimento persiste anche in assenza delle condizioni richieste dallo Stagirita:
– la rotazione di una trottola o di una mola fabri si verifica senza che il corpo che ruota abbandoni il luogo che occupa e, quindi, senza il “risucchio” di aria necessario per continuare il moto;
– aguzzando l’estremità posteriore di una lancia, così da annullare il “risucchio” di aria o la superficie su cui l’aria può premere, la lancia continua a muoversi;
– quando gli uomini che trainano un’imbarcazione stando sulla riva del fiume interrompono il loro sforzo, un marinaio che si trovi in coperta non sente l’aria che spinge da dietro la nave, ma solo quella che resiste al suo moto. Similmente, fuscelli di paglia che si trovassero a poppa non verrebbero incurvati dall’aria spirante da dietro.
Queste difficoltà si accentuano quando la stessa teoria aristotelica è applicata al movimento dei corpi celesti. Qui, in virtù della distinzione di natura fra corpi terrestri e corpi celesti, Aristotele si appella all’eternità dell’universo, che per lui è una verità evidente. Da tale eternità consegue la divinità dell’universo e la contraddittorietà di tutte le dottrine che cercano di assegnare un’origine al cosmo.
In quest’ottica, il movimento ininterrotto della volta celeste è un corollario immediato, che non necessita di nessuna spiegazione. Ritroviamo ancora, in ragione di un’erronea concezione del cosmo, un impedimento alla possibile indagine razionale della natura. La scienza greca, in effetti, fu dettata soltanto dalla preoccupazione di salvare i fenomeni, ma restò incapace di curiosità verso le cause del moto. Fu una geometria della natura, una cinematica che non divenne mai una dinamica.
La fisica dell’impetus
Come ho detto, a fronte di queste contraddizioni, si sviluppano nel ‘300 diverse correnti di pensiero, tutte accomunate dall’intenzione di risolvere il problema del moto dei proietti senza ricorrere a “motori” in contatto con essi. La linea concettualmente più vicina alla formulazione di un principio inerziale è quella espressa da Giovanni Buridano.
“Giovanni era nato con ogni probabilità a Béthune, nella diocesi di Arras, forse attorno al 1300. Egli è menzionato per la prima volta in un documento universitario del febbraio 1328, come rettore dell’università. L’anno successivo egli compare in un altro documento, in cui viene indicato come celeber philosophus. Nel 1340 fu ancora rettore dell’università, e nel 1342 è menzionato come assegnatario di un beneficio ad Arras, ‘al tempo delle sue lezioni a Parigi sui libri di filosofia naturale, metafisica e morale.’ Dopo questa data abbiamo menzioni continue del suo nome fino a un documento del 1358 in cui egli appare come firmatario insieme al suo altrettanto celebre successore Alberto di Sassonia.[…] Un tardo accenno a Buridano nel 1366 […] è senza dubbio erroneo. È stato suggerito che Buridano sia morto di peste nel 1358, ma non c’è alcun documento a sostegno di questa tesi” [M. Clagett, La scienza della meccanica nel Medioevo, Feltrinelli, Milano 1972, pp. 548-549].
Le opere principali di Buridano, per quanto riguarda la meccanica, sono le Questiones sul De caelo di Aristotele e tre diversi scritti sulla Fisica. Ma quali sono i punti principali della teoria dell’impetus? Anzitutto egli ne definisce l’origine e il luogo di applicazione, recuperando la nozione di cinetice dunamis di Giovanni Filopono nel VI secolo d.C.:
– Il motore, muovendo un mobile, gli imprime un impeto o una certa virtù motrice di quel mobile […] nella direzione nella quale il motore lo muoveva […].
-L’impetus è, dunque, una sorta di motore intrinseco impresso dal motore a ciò che è mosso. Ma l’originalità della discussione di Buridano si trova nella misura che egli assegna all’impetus:
– Quanto più velocemente il motore muove quel mobile, tanto più forte impeto gli imprimerà.
Allo studioso di oggi, ma anche allo studente, non può non sfuggire la somiglianza straordinaria fra l’impetus e la moderna (e newtoniana) quantità di moto Q = mv. Buridano definisce anche un’altra caratteristica dell’impetus, ovvero il fatto di essere permanente, quindi non soggetto a corrompersi. La sua diminuzione o la sua distruzione dipendono dalla resistenza del mezzo in cui il mobile si muove, dal peso del mobile o da una contraria inclinazione del corpo. Questa convinzione è affermata apertamente:
L’impeto durerebbe all’infinito se non fosse diminuito e corrotto da una resistenza contraria o dalla inclinazione a un moto contrario.
Con questa affermazione Buridano getta le basi del principio di inerzia, che troverà in Isaac Newton la sua formulazione definitiva. Ma l’idea in nuce è già qui, nella dottrina dell’impetus, formulata da un “meccanico parigino” del XIV secolo. E le radici di questa idea, essenziale per tutta la fisica, sono ben radicate, come vedremo tra poco, in una solida concezione del mondo.
I vantaggi della nuova dinamica appaiono peraltro fin da subito, cioè non appena il principio dell’impetus viene applicato al moto del cielo, laddove Aristotele doveva ricorrere al postulato della divinità dei corpi celesti. Per Buridano l’eternità dei moti degli astri si spiega con l’imposizione divina di un impetus iniziale, al tempo della creazione del mondo, che si conserva integro in assenza di qualsiasi tipo di resistenza nelle regioni celesti: non c’è più bisogno di scomodare il Creatore obbligandolo a realizzare continuamente il moto locale dei corpi mediante potenze angeliche, né di divinizzare il cosmo.
Se l’epistemologia “[…] è lo studio dei criteri generali che permettono di distinguere i giudizi di tipo scientifico da quelli di tipo metafisico e religioso“, allora qui ci troviamo di fronte all’atteggiamento che prepara l’unica versione possibile di epistemologia, con buona pace dei tanti che oggi hanno smarrito quei criteri.
Merita che si legga il passo, scritto nella prima metà del ‘300, con cui Buridano descrive la sua “cosmologia dell’impetus“: “[…] non apparendo dalla Bibbia che ci siano intelligenze deputate a muovere i corpi celesti, si potrebbe dire che non si vede la necessità di porre tali intelligenze, poiché si potrebbe sostenere che Dio, quando creò il mondo, mosse ciascun orbe celeste come gli piacque, e muovendoli impresse in essi degli impeti che continuassero il moto senza bisogno di un suo ulteriore intervento se non nel senso di un’influenza generale, com’egli concorre come coagente in tutte le cose che vengono compiute. Così infatti il settimo giorno si riposò da ogni opera che aveva compiuta, affidando ad altri le azioni e le passioni vicendevolmente. E quegl’impeti impressi nei corpi celesti non si indebolivano né si corrompevano, non essendo nei corpi celesti inclinazione ad altri moti, né essendo in essi una resistenza corruttiva o repressiva di quell’impeto. Ma ciò non dico assertivamente, bensì [in via ipotetica], chiedendo ai signori teologi che mi insegnino in che modo queste cose possano avvenire …” [M. Clagett, cit., p. 566].
Il programma scientifico di Buridano nasce all’insegna di grandi idee guida: egli ha già una visione del mondo come creato e per questo gli è naturale cercare gli stessi comportamenti su scale diverse, cioè nel piccolo come nel grande, sulla terra e fuori della terra. Qui verifichiamo la tesi di John Needham che ho citato prima: se manca la fiducia nella razionalità complessiva dell’universo, viene meno anche la spinta per investigare i fenomeni di piccola scala dai quali parte l’attività scientifica. Le culture antiche caddero in questo “errore”.
Qui cade anche un altro luogo comune della mitologia scientifica, secondo cui la scienza progredisce “per piccoli passi” e “un po’ alla cieca”, raccogliendo e catalogando dati senza che le siano necessarie idee generali sulla razionalità del cosmo.
Questo empirismo, di origine baconiana, è negato dall’evidenza. Come un imprenditore che vuole avere successo deve “pensare in grande” – e semmai muoversi “per piccoli passi” -, anche lo scienziato deve avere il coraggio intellettuale di pensare che l’universo è qualcosa di grande, ricco di meraviglie e suscettibile di essere capito. E poi affrontare la ricerca con tutta l’umiltà richiesta di fronte a un dono gratuito.
Cosmo e culto: il debito della scienza con una tradizione cosmica
Buridano e i Doctores parisienses non appaiono improvvisamente. Sullo sfondo, ma soprattutto in loro, pulsa una cultura vitale, che ha una piena familiarità con la teologia, con la Scrittura – in particolare con il racconto della Genesi e con i Salmi – e con la metafisica, cioè con la scienza delle cose in quanto sono. Quella cultura è il frutto di una tradizione cosmica cristiana che si è trasmessa con continuità dall’Antico Testamento fino ai Padri e dai Padri fino alla Scolastica. Essa si può riassumere in due affermazioni:
– Dio ha creato il mondo ex nihilo, dal nulla
e
– Dio conserva gli esseri già creati.
La creazione dal nulla è una nozione affermata nell’Antico Testamento e diventa parte integrante della teologia cristiana fin dal tempo dei Padri. La fede nell’atto creativo implica che tutti i corpi dell’universo si trovino allo stesso livello e fa decadere ogni distinzione fra materia celeste e materia terrestre, distinzione assurta a dogma nel pensiero antico greco.
Altrettanto fondamentale per la nascita della scienza è l’idea di conservazione degli esseri creati. Essa garantisce che Dio è la causa prima rispetto a tutte le altre cause della catena causale. La scienza, che è cognizione certa ed evidente del fenomeno attraverso le sue cause prossime, trova in questo contesto la sua giusta collocazione: può operare nel proprio ambito senza curarsi della causa prima (allo scienziato non serve ricondursi alle cause di ordine metafisico) – ma è consapevole di non costituire un sistema chiuso di conoscenza poiché, fermandosi alle cause prossime, non esaurisce le ragioni profonde dei fenomeni, prima fra tutte il loro esserci.
Questa corretta cognizione di Dio ha salvaguardato, in un modo troppo poco apprezzato, la nascita della scienza da due tipi di errore: da un lato il ricorso a potenze soprannaturali come intelletti o angeli per giustificare lo svolgimento dei fenomeni, dall’altro la prospettiva deistica, resa popolare da Voltaire, dell’ordine naturale come meccanismo fine a se stesso, messo in moto e poi abbandonato da un Dio orologiaio che non interviene mai.
Lo sviluppo della scienza nei secoli successivi ha inevitabilmente seguito l’itinerario di apostasia imboccato dall’Occidente e, quindi, dal mondo. L’errore deistico si è realizzato storicamente nel XVIII secolo e oggi assistiamo ad una sua riedizione aggiornata: eliminato Dio dal pensiero dell’uomo, è scomparso anche il ricordo della “prima mossa” da parte di Dio e ciò che rimane nell’impresa scientifica è il senso di autonomia assoluta delle leggi fisiche, che dovrebbero essere in grado di spiegare tutto, veramente tutto, anche l’apparizione dello stesso universo.
Ma, come dicevo all’inizio, proprio mentre la scienza si produce nello sforzo prometeico di dare un senso alla totalità dell’esistenza, ecco il proliferare dei “nuovi movimenti religiosi”, dell’interesse per il soprannaturale, per la magia, per l’esoterismo. È il segnale che gli uomini vogliono trovare il senso della loro esistenza e del loro destino oltre la scienza, e che sono disposti a farlo nonostante la scienza, se non contro la scienza.
Questa lacerazione è solo un aspetto del nostro “mondo in frantumi” – la definizione è di papa Giovanni Paolo II -: in frantumi perché la ragione umana, rinunciando al dialogo con la sapienza eterna di Dio e assumendo il primato sulla verità, non è più in grado di trovare l’unità del reale.
La cultura dell’assurdo, il nichilismo strisciante, l’insoddisfazione per l’esistente e l’esistenza che caratterizzano il nostro tempo, sono insieme l’indice di un malessere e il richiamo alla necessità di una conversione di cui la “nuova evangelizzazione” è il modo di attuazione che il regnante pontefice indica ai cristiani per il millennio che viene.
E a fondamento di questa conversione non a caso Giovanni Paolo II, nel secondo capitolo dell’enciclica Evagelium vitae (1995), pone la constatazione che la vita umana è un bene: “Lo afferma il libro della Genesi nel primo racconto delle origini, ponendo l’uomo al vertice dell’attività creatrice di Dio, come suo coronamento, al termine di un processo che dall’indistinto caos porta alla creatura più perfetta. Tutto nel creato è ordinato all’uomo e tutto è a lui sottomesso […]” [E.V., 34].
Anche la scienza, in quanto frutto dell’intelletto umano, deve convertirsi. E dovrà farlo piegandosi sul creato naturale nello spirito di conversione che sant’Agostino riporta nel decimo libro delle Confessioni: “[…] ho chiesto del mio Dio a tutta la massa dell’universo, e mi ha risposto: ‘Io non sono Dio. Dio è colui che mi ha fatto’“.





