 Italia Oggi martedì 15 dicembre 2015
Italia Oggi martedì 15 dicembre 2015
Giulio Meotti: è un pericoloso sentimento che nasce nelle èlite, nei media, nelle università
In Europa del Nord e in Francia un ebreo si sente a rischio
di Goffredo Pistelli

Gen 07
Gen 07
 La Civiltà Cattolica n.3968 24 ottobre 2015
La Civiltà Cattolica n.3968 24 ottobre 2015
Francesco Occhetta S I.
Tatuarsi è una moda ormai diffusa nelle società occidentali: in Italia i tatuati sono 7 milioni (13 italiani su 100). Soprattutto nei mesi estivi, vedere persone di ogni età che hanno scelto di inscrivere sulla schiena, sui tricipiti e sulle gambe cuori, draghi, putti, nomi o segni tribali ci induce a riflettere sulla volontà di modificarsi e su quale idea di corpo attraversi la cultura contemporanea. Sembra un paradosso, ma è proprio nel tempo della fragilità dei comportamenti e della liquidità degli ideali, in cui ogni scelta sembra assunta «a tempo», che il tatuaggio si impone come la traccia di una «identità dilatata» e il simbolo del «per sempre».
Gen 07
Figlio di un mujaheddin, con un passato immerso nell’odio. Di fronte agli attentati, racconta che cosa ha trasformato la sua vita.
di Alessandro Stoppa
Gen 07
Osservatorio Internazionale Cardinale Van Thuân – Newsletter n.649 del 22 dicembre 2015
(Editoriale del bollettino n.4-2015)
S.E. Mons.Giampaolo Crepaldi
Presidente dell’Osservatorio
Gen 07
 Corriere.it/scuola 19 dicembre 2015
Corriere.it/scuola 19 dicembre 2015
Fatou Gaye, studentessa 19enne originaria del Senegal, innamorata di Justin Bieber e dell’informatica, scelta per interpretare Maria nel presepe vivente di Pescara : «Ho chiesto l’autorizzazione a papà e lui mi ha detto sì: l’amore appartiene a tutti»
di Nicola Catenaro
Gen 07
Il Timone n.147 Novembre 2015
Un solo concetto, tante interpretazioni e applicazioni storiche. Da Locke ai giorni nostri l’aspirazione alla massimizzazione della libertà porta a rivendicazioni anche contraddittorie. Come sui cosiddetti diritti civili.
di Giacomo Samek Lodovici
Gen 07
Dibattito adesso finalmente utile e rivelatore
di Alfredo Mantovano
(Vicepresidente del Centro studi Livatino)
e Massimo Introvigne
(Presidente di Si alla famiglia)
Gen 07
17 dicembre 2015
di Massimo Introvigne
Con la morte, all’età di novantasei anni, di Licio Gelli si chiudono insieme diverse vicende storiche. Si chiude, anzitutto, la storia terrena di Licio Gelli, figura di punta della massoneria italiana per molti decenni. Non ho mai conosciuto personalmente Gelli. Persone che lo hanno frequentato negli ultimi anni mi dicono che si fosse riavvicinato alla Chiesa cattolica, per cui aveva sempre mantenuto almeno una curiosità, come mostra la sua corrispondenza con la beata Madre Teresa di Calcutta, di cui fanno stato le biografie. Non saprei dire dove questo percorso di avvicinamento alla fede e alla Chiesa avesse portato Gelli. Mi auguro, per lui, molto vicino al Signore. È morto nell’Anno Santo della Misericordia, da molti anni non si occupava più direttamente di vicende massoniche, e certamente la Chiesa non serba rancore.
Gen 01
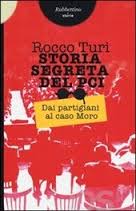 Il Corriere del Sud n. 9 – anno XXIII, 31 dicembre 2015
Il Corriere del Sud n. 9 – anno XXIII, 31 dicembre 2015
Appunti per una storia. Seconda parte
di Gianluca Agostini
Il primo studio organico sull’argomento della “Gladio rossa”, struttura paramilitare di natura clandestina organizzata dal Pci nel 1945 e sciolta nel 1974, è quello di Gian Paolo Pellizzaro che, nella sua pubblicazione Gladio Rossa (ed. Settimo Sigillo, Roma 1997), ha riportato il cd. “Dossier SIFAR”, dall’acronimo dell’allora servizio segreto militare, datato 28 febbraio 1950.
Dic 17