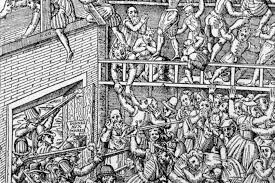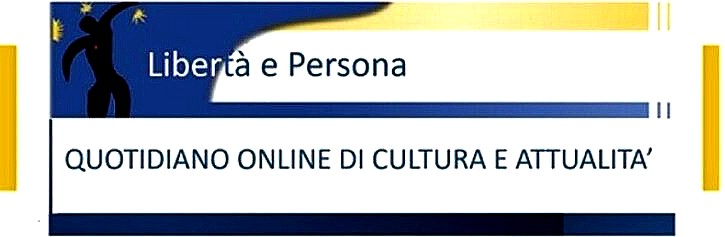Unione Cristiani Cattolici Razionalisti (UCCR) 23 Agosto 2025
L’analista geopolitico Dario Fabbri parla al Festival del Medioevo 2025 e fa un bel riassunto: nelle guerre di religione, la religione non fu la causa. Si trattò di conflitti di natura geopolitica.
Dario Fabbri ha parlato delle “guerre di religione” al Festival del Medioevo 2025.
Noto analista geopolitico, Fabbri è direttore della rivista Domino che ha fondato assieme a Enrico Mentana.
Nella prima parte del suo intervento si è occupato di spiegare il concetto di geopolitica umana e le sue varie applicazioni per poi arrivare alle guerre di religione. Cioè i conflitti tra cattolici e protestanti che hanno insanguinato l’Europa tra il XVI e il XVII secolo a seguito della Riforma.
Un discorso molto ironico, quello di Fabbri, che ha percorso secoli di storia criticando l’estrema banalizzazione con cui ci viene insegnata a scuola perché, dice, «noi siamo frutto della società dei Lumi, che è il peggio del peggio, ma è raccontata come altissima e che ha essenzialmente distrutto il nostro apparato culturale».
Il riassunto sulle Guerre di religione: la religione era estranea
Venendo però al cuore del suo discorso, Fabbri spiega che le cosiddette “guerre di religione” non sono stati conflitti religiosi nel senso stretto del termine, ma piuttosto episodi di lotta per il potere, mascherati da motivazioni religiose.
Questa idea della religione come causa bellica ha un pedigree che inizia già da Spinoza, poi da Hobbes e Locke ed espressa polemicamente da Gibbon e Voltaire.
Ma è un mito e gli esempi sono moltissimi, tra cui l’elenco dei vari interessi politici e territoriali delle fazioni coinvolte nelle guerre di religione in Francia, dove le stesse alleanze erano flessibili e pragmatiche, per nulla basate su convinzioni religiose.
Pensiamo alla Francia cattolica alleata dei principi protestanti tedeschi contro il cattolico Carlo V nel 1552, senza che i principi tedeschi cattolici si dessero da fare. Prima ancora, nel 1525, sempre la Francia si alleò con i turchi musulmani contro il Sacro Romano Impero, assistendo ad un sovrano cattolico combattere un altro cattolico con l’assistenza islamica.
Qualcosa di molto simile, secondo Fabbri, alla divisione odierna tra sunniti e sciiti, fondata prettamente su una divisione politica e culturale tra diverse fazioni arabe. Anche in questo caso la religione è utilizzata come strumento per giustificare conflitti di potere e identità.
L’analista geopolitico ricorda giustamente lo scisma anglicano, che oggi si studia come evento religioso ma che fu in realtà una questione esclusivamente politica.
«Enrico VIII voleva risposarsi, ma Roma non glielo concedeva», spiega Fabbri. «Creò quindi una nuova chiesa con lui al vertice. Dal punto di vista teologico, l’anglicanesimo era praticamente identico al cattolicesimo. La differenza era minima e la motivazione era geopolitica: l’Inghilterra rifiutava di essere subordinata a Roma e decise di gestire autonomamente i propri affari religiosi».
Cattolici contro ugonotti? Alleanze sorprendenti
E che dire degli ugonotti? Anche in questo caso, «questa dinamica si ripete, gli ugonotti non combattevano contro i cattolici per motivi religiosi ma per sopravvivere in un contesto geopolitico ostile».
Ed è falsa l’idea di un conflitto tra la maggioranza cattolica e la minoranza ugonotta per differenze religiose: i nobili cambiarono continuamente schieramento a seconda delle sorti della guerra, che vide la cooperazione di cattolici e protestanti per il mantenimento dei diritti della nobiltà a fronte dell’accentramento di potere da parte della monarchia.
Ad Agen, nel 1562, ad esempio, i contadini cattolici si unirono ai loro compatrioti ugonotti nella ribellione contro il barone cattolico François de Fumel, così come plebei cattolici e protestanti fecero causa comune a Pont-en-Roians (1578), Roissas (1579), Vivarais (1580) e in molte altre zone.
La Guerra dei trent’anni, la religione non fu la causa
Parliamo della Guerra dei Trent’anni e dell’immagine stereotipata di una denominazione cristiana contro l’altra in nome delle differenze dottrinali.
Eppure l’esercito imperiale nominalmente cattolico comprendeva diversi generali e soldati protestanti e la guerra fu sostenuta da compagnie mercenarie la cui fedeltà era al miglior offerente, indipendentemente dalla confessione.
Pensiamo a Ernst von Mansfeld, che prima servì i cattolici spagnoli e poi passò al luterano Federico V, oppure a Gustavo II Adolfo di Svezia che passò alla storia come paladino dei protestanti ma fu ritenuto, da loro, un invasore e massacrò i contadini luterani che cercarono di scacciare gli svedesi nel novembre del 1632.
Il card. Richelieu, primo ministro di Luigi XIII di Francia, si alleò proprio con il protestante Gustavo II nel 1631 e tutta la seconda parte della guerra fu di fatto una lotta tra la Francia e l’Impero tedesco, entrambi cattolici.
Il cambio di schieramento, le mutevoli alleanze e i molteplici esempi di eserciti di diversa estrazione confessionale che si uniscono contro un nemico comune e, ancora, regni guidati dalla stessa fede che si rivoltano l’uno contro l’altro, mostrano che le guerre del XVI e XVII secolo furono guidate da fattori sociali, politici, territoriali ed economici.
Erano Stati nazionali che lottavano tra loro per la supremazia, consolidando la loro autorità e la loro forza economica. Riassunto: le “Guerre di Religione” non erano guerre di religione.
Tornando al discorso di Dario Fabbri, lui stesso ricorda che «la crociata albigese, la nascita dell’anglicanesimo e le rivolte americane dimostrano che, dietro l’apparente lotta religiosa, si celano motivazioni di potere, territorio e identità nazionale. Studiare la storia come lotta puramente teologica rischia di offuscare la comprensione dei veri fattori alla base dei conflitti».
La religione fu spesso il linguaggio del conflitto, ma non la causa scatenante.
Il 7% delle guerre ha avuto origine confessionale
E’ un tema che abbiamo trattato su UCCR tempo fa, smentendo il mito che la religione sia stata la causa della maggior parte delle guerre.
Nella poderosa “Encyclopedia of Wars” di Charles Phillips e Alan Axelrod, si documenta che tra tutte le 1763 guerre che l’umanità ha combattuto, meno del 7% hanno avuto una causa religiosa, e queste hanno provocato meno del 2% di tutte le persone uccise in guerra.
La religione è chiaramente esclusa come causa anche in tutte le guerre più o meno moderne, quella napoleonica, la Rivoluzione Americana, le guerre mondiali (dove furono i gruppi religiosi a essere massacrati dai vari ateismi di Stato), i conflitti in Corea e in Vietnam e naturalmente gli attuali conflitti tra Russia e Ucraina e Israele e Palestina.
Sono le varie ideologie laiche inventate dall’uomo, come il nazionalismo, il patriottismo, il capitalismo, il marxismo e il liberalismo le vere cause belliche. Questo smentisce anche l’illusione che lo Stato nazionale laico e moderno sia la soluzione alle guerre, non la loro causa.
Parlare di guerre di religione come conflitti teologici è una semplificazione miope, che non tiene conto delle complesse dinamiche politiche e sociali che le hanno caratterizzate.
Esistono guerre di potere e di geopolitica che spesso si travestono da dispute religiose. Riconoscerlo è fondamentale per comprendere la storia senza cadere nei miti.