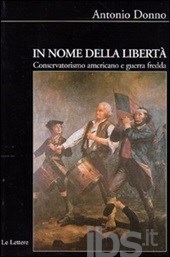 Tratto dal sito de Il Domenicale www.ildomenicale.it/
Tratto dal sito de Il Domenicale www.ildomenicale.it/di Antonio Donno
Antonio Donno, dell’Università di Lecce, pubblica per i tipi della fiorentina Le lettere il primo studio italiano sulle origini della Destra nordamericana contemporanea, In nome della libertà. Conservatorismo e guerra fredda. Ne anticipiamo alcuni punti focali, che illustrano la realtà fusionista di un movimento vasto e profondo, capace di condizionare la vita politica di un Paese. La storia esemplare di National Review e il pensiero di Felix Morley
Scriveva Regnery: «Ora sarebbe difficile concepire il movimento conservatore senza Buckley», riconoscendo al giornalista e scrittore americano una coerenza intellettuale che aveva rappresentato per molti decenni una guida per il movimento conservatore. In realtà, benché Buckley sia stato uno scrittore di prodigiosa prolificità, il libro che lo rese famoso perché scosse l’establishment liberal americano fu proprio God and Man at Yale del 1951.
Quando parlava della morte dell’individuo a Yale, Buckley intendeva che il libero pensiero era stato soppresso; dietro il paravento di quella formula magica che era la “libertà accademica”, in realtà si celava il monopolio della cultura e dell’insegnamento da parte dell’ortodossia liberal di ascendenza newdealista.
Per usare un termine odierno, era il trionfo della politicalcorrectness. […] Così, Yale, da bastione delle tradizioni politiche americane fondate sul “governo limitato” e dei principi dell’individualismo e del Cristianesimo, s’era trasformata, dietro la cortina fumogena della “libertà accademica”, nella punta di diamante della filosofia collettivistica.[…]
Il caso dell’Università di Yale rivelava, secondo l’analisi di Buckley, la resa del liberalismo americano nei confronti del comunismo. […]
Tale retroterra era la causa di un confronto debole e contraddittorio verso il totalitarismo comunista. Per risvegliare le coscienze americane, nel novembre del 1955, Buckley fondò «The National Review», che divenne subito il centro del dibattito conservatore per molti anni. L’opposizione al comunismo interno ed internazionale, le politiche della guerra fredda e l’uso politico dell’anticomunismo furono i temi più importanti nei primi anni di vita della rivista.
Non tutti i collaboratori avevano le stesse idee di Buckley, il quale sosteneva l’impoliticità del nuclear first strike e del rifiuto di qualsiasi negoziato con Mosca che invece Frank Meyer […] e L. Brent Bozell caldeggiavano. Dal canto suo, Whittaker Chambers, l’autore del famoso Witness (1952), affermava che l’uso della forza contro l’Unione Sovietica era inappropriato e considerava «[…] la lotta tra l’Est e l’Ovest fondamentalmente spirituale», tanto che la superiorità del comunismo egli la ravvisava, appunto, sul piano spirituale ed ideologico piuttosto che su quello strettamente militare.
Come si vede da questi brevi esempi, se l’anticomunismo era senz’altro un forte terreno comune d’analisi del ruolo internazionale degli Stati Uniti, le opinioni divergevano su quale dovesse essere la migliore politica di contrasto dell’espansionismo comunista. Da questo punto di vista, «The National Review» fu un prezioso strumento di confronto tra i conservatori tradizionalisti e i liberali classici, gli esponenti del Old Right e i libertarians.
[Russell] Kirk, [Richard M. Weaver] e altri esponenti della tradizione conservatrice dettero il loro contributo fin dall’inizio; accanto a loro, John Chamberlain, [Frank] Chodorov, [Wilhelm] Röpke, Max Eastman e Frank Meyer. Un nutrito gruppo di ex comunisti ed ex trotskisti partecipò molto attivamente alla battaglia della rivista: lo stesso Meyer, James Burnham, Willmoore Kendall, William Schlamm, ed altri. In sostanza, la rivista rappresentò quel momento di incontro e di confronto tra le varie anime del conservatorismo americano che il clima politico e culturale del decennio di Eisenhower favoriva. […]
Sulle riviste del conservatorismo americano del tempo, in particolare «Faith and Freedom» e «The Freedom», la polemica era molto vivace. Sia [Murray N.] Rothbard che Chodorov, da posizioni libertarian e isolazioniste, insistevano che Mosca non rappresentava un pericolo, che la sua espansione nell’Europa orientale era un segno di debolezza e che la politica di contrasto e di riarmo di Washington mascherava la volontà di ingigantire i poteri dello Stato: «Il reale nemico, essi dichiaravano strenuamente, era lo Stato, di cui il comunismo era soltanto una variante». Da parte loro, interventisti come Schlamm e William Henry Chamberlin sostenevano che «il comunismo era inerentemente espansionista, totalitario, inaffidabile e “incurabilmente aggressivo”: il fine sovietico era la conquista del mondo».
Contro il perfettismo
[…] Secondo Buckley, questi erano i caratteri distintivi della filosofia dei liberals: «Sono uomini e donne che tendono a credere che l’essere umano sia perfettibile e che si possa prevedere il progresso sociale, e che lo strumento per raggiungere ambedue gli obiettivi sia la ragione; che le verità siano transitorie e determinate empiricamente; che l’eguaglianza sia desiderabile ed ottenibile per mezzo dell’azione dello Stato; che le differenze sociali ed individuali, se non sono razionali, sono reprensibili e dovrebbero essere eliminate scientificamente; che tutti i popoli e le società dovrebbero impegnarsi ad organizzarsi sulla base di paradigmi razionali e scientifici».
Il messaggio liberal aveva una carica pedagogica tipica dell’indottrinamento, sosteneva Buckley […]. L’atteggiamento liberal verso il conservatorismo era un atteggiamento di negazione dell’esistenza stessa o della consistenza intellettuale del conservatorismo, o, in alternativa, di valutazione del conservatorismo stesso come di una patologia o di una forza politica oscurantista. Buckley riproponeva i principi basilari del pensiero conservatore: «Libertà, individualismo, senso della comunità, santità della famiglia, supremazia della coscienza, visione spirituale della vita».
Felix Morley e i valori USA
Giornalista e saggista, Felix Morley dedicò la sua attività al problema del federalismo come decentramento di poteri e, conseguentemente, come migliore difesa delle libertà individuali. Da questo punto di vista, egli appuntò la sua riflessione sul processo di concentrazione dei poteri durante gli anni del New Deal, intesa come sostanziale violazione dei principi della tradizione politica liberale americana e delle sue radici nella filosofia giudaico-cristiana.
In bilico tra l’individualismo liberale e il comunitarismo conservatore, Morley ha lasciato una serie di pregevoli contributi su queste tematiche fondamentali, intrecciandole spesso con i problemi contingenti della politica estera americana, della lotta al comunismo e della guerra fredda, e del futuro del federalismo americano in un’epoca di statalismo, nella forma del totalitarismo comunista come in quella delle cosiddette economie “miste” dell’Europa occidentale.
Come molti degli scrittori della tradizione liberale e conservatrice americana, anche Morley si impegnò a ricostruire e riattualizzare le “radici dell’ordine americano”, per usare il titolo del famoso libro di Kirk, eredità della Dichiarazione d’Indipendenza e del processo formativo della Costituzione americana.
I primi anni della guerra fredda, in cui lo statalismo del New Deal rappresentava il pericolo del radicamento di una filosofia pubblica contraria alla tradizione individualistica americana, videro la pubblicazione di numerose opere che tendevano a riportare in primo piano i valori del liberalismo individualistico americano come indicazione della possibile, auspicabile ripresa di un cammino interrotto. Così, nel 1949, Morley pubblicò un ampio studio sulla storia della Repubblica americana come repubblica liberale fondata sui diritti naturali dell’individuo e, nello stesso tempo, sui principi religiosi giudaico-cristiani.
La libertà economica, cioè lo sviluppo del capitalismo, fu il cardine, nell’analisi di Morley, della libertà americana; ma il New Deal rappresentò una svolta drammatica nella storia della libertà americana: «Immediatamente, durante la sua prima amministrazione, Roosevelt mostrò tacitamente la sua intenzione di distruggere la libertà economica negli Stati Uniti, sostenendo allo stesso modo di Karl Marx, sebbene più obliquamente, che questa condizione era più un male che un bene».
Nella tradizione liberale americana, aggiungeva Morley, la vita dell’individuo è affidata per la gran parte alla sua discrezione, «relativamente poco è verboten, […] con il risultato che l’individuo in America ha la libertà di sviluppare la propria filosofia della vita in un modo che appare addirittura temerario a coloro che sono educati nella tradizione statalistica, cioè, in sostanza, agli europei.
Morley è chiaro al proposito: «La lezione fondamentale delle rivoluzioni necessita d’essere appresa nuovamente. È la concentrazione del potere politico, che ha per scopo di liberare gli uomini dall’oppressione, che quasi invariabilmente finisce in un’oppressione grande quanto quella che è stata eliminata, o persino più grande». […]
La sua originalità, rispetto all’impianto tradizionale delle idee della Old Right, consiste nell’aver coniugato con una certa efficacia la centralità della tradizione individualistica americana con la conduzione della politica estera lungo tutto l’arco della storia degli Stati Uniti; e, di conseguenza, nell’aver evidenziato il riflesso negativo che le politiche statalistiche del New Deal avevano avuto sull’atteggiamento americano durante la guerra e nel dopoguerra.
The Foreign Policy of the United States, del 1951, poneva in risalto queste contraddizioni e legava le considerazioni sulla politica estera americana ai principi costituzionali ed alla tradizione politica americani. La prima, importante notazione di Morley riguardava la conduzione bipartisan della politica estera americana, giudicata «[…] fallace, dannosa per l’economia e l’efficienza produttiva, contraria ad ogni principio di base della forma americana di governo, e direttamente responsabile di tutti i più gravi errori commessi nel campo della politica estera». […]
Non solo. Morley condannava senza mezzi termini l’entrata in guerra degli Stati Uniti ed ogni impegno internazionale americano nel dopoguerra. La ratifica del Patto Atlantico da parte del Senato, il 21 luglio 1949, aveva segnato, per Morley, «il completo rovesciamento della politica estera tradizionale americana», che s’era sempre fondata «[sul] non-intervento e [sull’] automatico riconoscimento di ogni governo stabile».
Questa politica s’era poi definita nel tempo come una politica di neutralità. Ora, il ribaltamento di questa consolidata politica estera aveva condotto a delle gravi conseguenze che Morley riassumeva in sette punti:
1) la caduta di qualsiasi precauzione contro i disegni espansivi del Cremlino;
2) l’insistenza sulla resa incondizionata della Germania, che aveva creato un vuoto politico al centro dell’Europa a vantaggio dei sovietici;
3) l’accondiscendenza verso l’espansione dell’Unione Sovietica nel centro dell’Europa più ricca e produttiva;
4) la decisione di isolare Berlino e Vienna da ogni contatto con le zone controllate dagli occidentali;
5) il varo del Piano Morgenthau che intendeva ridurre la Germania ad uno Stato agricolo;
6) la frammentazione dell’economia giapponese, al fine di ridurne la capacità di ripresa produttiva;
7) il “permesso” concesso a Mosca di occupare e comunistizzare la Corea al di sotto del 38° parallelo.
A ciò si doveva aggiungere la stolta politica di condanna di alcuni regimi decisamente anti-comunisti, come quello di Franco in Spagna, sbrigativamente definiti fascisti prima da Marshall, poi da Acheson. […]
Con la critica al concetto di “volontà generale” di Rousseau Morley giungeva al cuore del problema: «La minaccia fondamentale, dal punto di vista individualistico, è la teoria della volontà generale».
Per Morley, come per altri scrittori di quegli anni, la promozione del benessere individuale era la base del benessere generale, «ma la teoria della volontà generale era completamente rigettata e ripudiata, non solo con l’istituzione di un governo con i poteri esecutivo, legislativo e giudiziario ben bilanciati tra di loro, come sosteneva Montesquieu, ma anche con l’attribuzione di poteri ben delimitati ed elencati da affidare al governo centrale in quanto tale».
È questo il tema centrale dell’opera più importante di Morley, Freedom and Federalism (1959), in cui l’autore parte dalla considerazione delle radici cristiane della nazione americana per poi esaminare i principi-cardine dell’ordine americano, tutti fondati su una struttura politica bilanciata, «[…] volta a proteggere le minoranze contro la maggioranza, fino all’estrema minoranza, quella costituita da un solo uomo, l’individuo».
L’insieme degli individui in quanto tali dà vita al governo, locale e nazionale, attribuendo ad esso ben precisi e delimitati compiti: «Gli uomini che scrissero la Costituzione erano pienamente consapevoli che in questo tentativo di conciliare Ordine e Libertà essi stavano manovrando tra Scilla e Cariddi».
Morley si muoveva tra il pensiero di Kirk e l’individualismo libertarian, ma comunque contro il trionfo dello “Stato onnipotente” fondato sulla cosiddetta volontà generale, il concetto roussoviano che trovò la sua massima realizzazione teorica in Marx; ecco perché Morley sosteneva che gli Stati Uniti non fossero una democrazia politica nel senso statalista inteso dalla nozione di “volontà generale” di Rousseau: «L’essenza della Costituzione è, naturalmente, il sistema federale che vi è incardinato. Ogni provvedimento di legge è basato sul concetto di questi Stati Uniti. Essi non possono fondersi in un singolo Stato finché vige la Costituzione. E così, per tutti coloro che rispettano la Costituzione, i Diritti degli Stati sono un dato fondamentale, mentre la democrazia politica non lo è affatto».
Promesse per il futuro
Con la vittoria di Ronald Reagan nelle elezioni presidenziali del 1980 il movimento conservatore americano giungeva al suo primo grande successo politico dopo più di trent’anni di impegno e di lotta.
In Reagan gli elettori conservatori videro finalmente l’incarnazione delle loro aspirazioni e dei loro programmi, anche se è difficile dire se «essi sapessero o meno che le idee politiche di Reagan avevano le loro radici nell’ideologia degli anni ’40 e ’50 […]»1. Che essi ne fossero o meno consapevoli, è una questione di non grande rilevanza: il trionfo di Reagan riportava il conservatorismo americano sugli scudi, dopo anni di dure battaglie per emergere sulla scena politica, vincere l’apatia degli elettori e sconfiggere l’arroganza liberal. […]
Al di là delle divisioni filosofiche che sono state messe in rilievo in questo lavoro, è indiscutibile che il collante che unì nei decenni del dopoguerra le varie anime del conservatorismo americano fu l’anti-statalismo. […] Per quanto il Partito Repubblicano, ai tempi di Eisenhower, non rappresentasse compiutamente le idee conservatrici (anzi Eisenhower proseguì in buona parte le politiche del Welfare State), i conservatori americani non avevano che nel Grand Old Party il loro punto di riferimento politico-elettorale.
Il turning point fu la candidatura di Barry Goldwater alle elezioni presidenziali del 1964. Nonostante la secca sconfitta, si verificò un caso abbastanza raro nella storia dei partiti politici dell’Occidente: innervato da una forte militanza conservatrice, il Partito Repubblicano iniziò una formidabile rimonta che portò prima all’elezione di Nixon e poi, soprattutto, a quella di Reagan nel 1980. E, se Nixon non rappresentò le istanze conservatrici se non in minima misura, Reagan, al contrario, fu l’uomo vincente dei conservatori. […]
Quando il Cremlino mostrò il suo vero volto, il “progressismo” comunista apparve ai liberals ed all’opinione pubblica americana come un inganno. E lo statalismo comunista si palesò per ciò che era sempre stato, lo “Stato onnipotente”, totalitario, esattamente ciò che i conservatori avevano sempre sostenuto. Così, lo statalismo liberal non fu più una coperta ideologica sufficiente per giustificare lo statalismo “progressista” sovietico.
Fu questo il punto di partenza della rimonta conservatrice. La vittoria schiacciante di Eisenhower e il declino del Partito Democratico ebbero un effetto tonificante per il movimento conservatore: la ripresa fu lenta e, in taluni momenti, contraddittoria, ma efficace nel lungo periodo.
L’elezione di George W. Bush conferma, per ora, questa tendenza.




