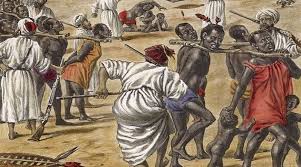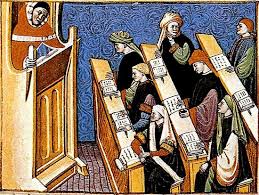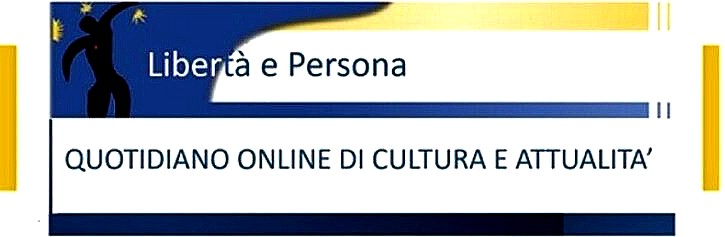Unione Cristiani Cattolici Razionalisti 5 Ottobre 2025
Sintesi dell’intervento dell’eminente storico Jaume Aurell Cardona (Università di Navarra) sui motivi per cui il Medioevo ha plasmato l’Occidente e influenza la nostra vita oggi.
la Redazione
La presunta oscurità del Medioevo illuminata da una celebre lezione di Jaume Aurell Cardona.
Si tratta di un eminente storico spagnolo, docente di Storia medievale all’Università di Navarra che è recentemente intervenuto in un panel intitolato “Perché nel Medioevo si trova ciò che è veramente specifico dell’Occidente?”.
Sintetizziamo qui i punti salienti del suo lungo discorso in cui espone dettagliatamente quanto l’Occidente moderno dipenda dal Medioevo, a partire dalle prime forme di governo rappresentativo alle università, passando per la fine della schiavitù, l’origine della scienza e del capitalismo, fino alla sintesi culturale tra religione e civiltà precedenti.
Il pensiero del prof. Cardona è esposto nel suo best-seller “Genealogía de Occidente“ (Pensódromo 21 2019), in cui analizza le tappe fondamentali attraverso le quali si è forgiato l’Occidente.
Il termine “medievale” in senso dispregiativo
Il primo punto toccato dal medievalista spagnolo è sull’uso dell’aggettivo “medievale”, spiegando che gli storici sono sempre più concordi nel percepire «barbaro che altre epoche abbiano definito “barbaro” il Medioevo».
Se potesse non sa se andrebbe a vivere nel Medioevo perché «la doccia calda del mattino fa comodo quasi a tutti». Ma, ironia a parte, prosegue Cardona, «se proprio mi incalzate, l’unica epoca in cui non avrei voluto nascere è tra il 1920 e il 1950, con Stalin, Hitler o Pol Pot. Personaggi inverosimili da incontrare nel Medioevo».
Anche il Medioevo ebbe uomini brutali, come Federico II o Giovanni Senza Terra ma, aggiunge, «persino loro erano redimibili, frequentavano la Chiesa per chiedere perdono dei peccati. C’era un contesto che aiutava a non scadere in una barbarie totale come quella che abbiamo conosciuto in molti casi nell’età moderna».
Il primo passo per rivalutare popolarmente il Medioevo, spiega, «è cominciare col non usare più l’aggettivo “medievale” in senso dispregiativo». Una deformazione nata con gli illuministi, i quali «per costruire la propria identità come “secolo dei Lumi”, scelsero i medievali come nemici, “l’età oscura”. Gran parte della cattiva fama del Medioevo nasce lì».
Dopo questa introduzione, Jaume Aurell Cardona entra nel vivo del suo intervento analizzando i punti chiave per cui il Medioevo è la culla dell’Occidente.
Il Medioevo e il superamento della schiavitù
Nel Medioevo avviene il superamento della schiavitù, quello che lo storico definisce «il grande sistema socioeconomico dell’antichità».
Nei secoli medievali si inventò infatti il concetto di feudalesimo, che non è certo un modello virtuoso per noi contemporanei ma «a partire dal X, XI, XII secolo sostituì lo schiavismo e la gente ringraziava Dio per questo».
Il motivo, spiega lo storico spagnolo, «è che per la prima volta il rapporto “tra inferiore e superiore” comportava diritti e doveri da entrambe le parti. Lo schiavo, rispetto al padrone, non aveva alcun diritto: solo il signore aveva diritti su di lui. Invece, tra vassallo e signore esisteva un vincolo giuridico complesso, in cui anche il signore aveva doveri nei confronti del vassallo».
A chi volesse approfondire suggeriamo il nostro dossier storico sulla fine della schiavitù nel Medioevo cristiano.
Come il Medioevo inventa lo Stato moderno
Il secondo punto toccato da Aurell Cardona Cardona è la costruzione dello Stato.
Il Medioevo infatti realizzò qualcosa di assolutamente unico: una sintesi tra il cristianesimo e le tre grandi culture precedenti: Gerusalemme, Atene e Roma. Più una quarta, spesso dimenticata, ma fondamentale: il mondo germanico.
E’ proprio da quest’ultimo che fu adottata la monarchia, non da Roma. Anzi, afferma lo storico, «la monarchia romana non ha nulla a che vedere con la monarchia che abbiamo ereditato in Europa dal mondo germanico. Lì si trattava più di città-Stato che di una monarchia nel senso proprio».
Ancora una volta: la monarchia era dispotica e autoritaria? Certamente non è un modello per l’oggi. Ma rispetto al signore feudale, il “capo” era lontano e i popoli medievali videro «il re come una liberazione». Inoltre, nelle città che si andarono formando, si sviluppò l’autonomia fiscale.
Così «quello che conosciamo come Stato moderno», spiega Aurell Cardona, «del quale pensatori come Hobbes e Locke sapranno riflettere in età moderna, comincia in realtà a formarsi tra l’XI e il XV secolo».
Il primo parlamento del mondo nacque d’altra parte nel regno asturleonese nel 1188, in pieno Medioevo, ovvero «la prima volta che i cittadini entrarono in un parlamento, la prima volta che vennero proclamati diritti tanto embrionali quanto presenti oggi nelle nostre costituzioni, come l’inviolabilità del domicilio, la presunzione di innocenza, ecc.».
La nascita del capitalismo
Un terzo argomento dello storico spagnolo è il capitalismo.
Anch’esso nacque nel Medioevo, nel bene o nel male. Gli aspetti positivi, almeno in quell’epoca, erano l’inizio della generazione della ricchezza «tra persone che prima non avevano quasi nulla e dipendevano solo dalle rendite agricole».
Invece nelle città del XI-XIV secolo, soprattutto in Italia ma anche nel Nord Europa, il capitalismo iniziò a generare «condizioni molto migliori rispetto a quelle precedenti».
Il Medioevo tra scienza e università
Al quarto punto c’è l’origine della scienza moderna.
Un tema legato alla Scolastica e alla nascita delle università, invenzioni esclusive dei francescani e dei domenicani dell’XI secolo.
«E’ impressionante che il modello disegnato da quei geni resta sostanzialmente lo stesso ancora oggi», spiega il medievalista spagnolo. «Tutti i professori universitari lo riconoscono: quando entriamo in un ateneo, che sia a Rio de Janeiro, Johannesburg, Seul, Tokyo o Pechino, ci muoviamo nello stesso schema istituzionale nato nel Medioevo».
Anche su questo tema invitiamo a consultare il nostro dossier storico sull’origine della scienza nel Medioevo.
Separazione tra politica e religione
L’ultimo punto toccato da Jaume Aurell Cardona è la laicità.
Un tema “scippato” dall’Illuminismo, durante il quale si sviluppò in maniera radicale la distinzione tra politico e religioso, civile ed ecclesiastico, temporale e spirituale.
«Questo, però, non era affatto nuovo», spiega lo storico. «Già nel Medioevo, in Spagna, i re avevano elaborato questo distinguo attraverso la cerimonia dell’autocoronazione».
Si trattava del momento in cui il vescovo poneva la corona sul capo del re, il quale dicevano all’autorità religiosa: «”Tu puoi compiere l’unzione, che è l’atto sacro, ma non tocchi la corona, che è simbolo del potere temporale e spetta a me”. Con questo gesto si distingueva nettamente il politico dal religioso già tra XI e XV secolo».
Quando arrivarono gli illuministi a porre questa separazione, spiega Aurell Cardona, «probabilmente non erano consapevoli che già nella cosiddetta Spagna clericale si era cominciato a distinguere saggiamente il politico dal religioso».
Come anticipato, l’articolo non pretende di essere esaustivo e va letto come un’estrema sintesi di un lungo intervento e, soprattutto, di un lungo libro di ricostruzione storica.
Ma offre comunque una chiara panoramica dei motivi per cui il Medioevo ha plasmato l’Occidente e continua a influenzare profondamente la nostra società.