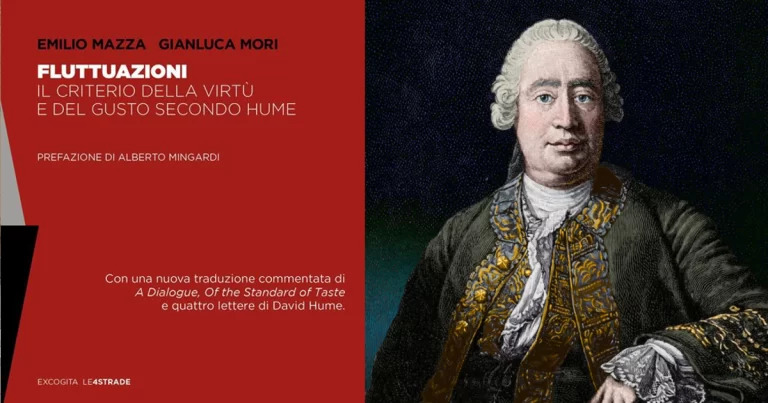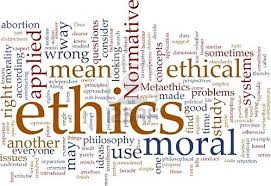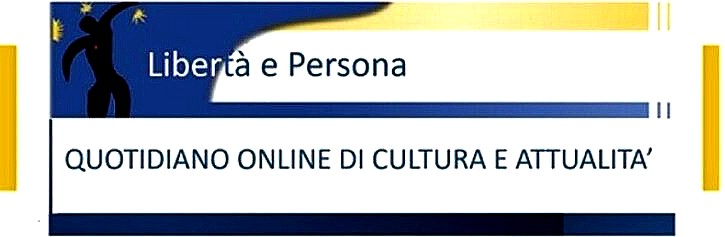Unione Cristiani Cattolici Razionalisti 4 Settembre 2025
Un libro espone l’impasse di David Hume di fronte alla morale senza Dio. Negando la legge naturale e il relativismo totale è costretto all’infelice tentativo di trovare surrogati di stabilità.
Torniamo a parlare di morale laica e del suo fondamento.
Se non esiste alcuna legge naturale inscritta divinamente nell’animo umano (e affidata alla libertà e alla coscienza del singolo), allora come può esistere una morale laica?
Su quali criteri si decide cosa è bene e cosa è male?
Il Foglio presenta una interessante recensione del sociologo Sergio Belardinelli al libro “Fluttuazioni. Il criterio della virtù e del gusto secondo Hume” (ExCogita 2025).
La morale senza Dio per David Hume
Gli autori, Gianluca Mori e Emilio Mazza, evidenziano come per il filosofo David Hume la base della moralità «è frutto di “disposizioni intrinseche alla mente”», ovvero è una reazione soggettiva dove «l’utilità e la gradevolezza» fondano i nostri giudizi sul bene e sul male, il giusto e lo sbagliato.
Quindi è esattamente ciò che scrivevamo in un recente articolo: senza un fondamento metafisico, ogni individuo, ogni cultura, ogni epoca può stabilire da sé la propria morale.
I nazisti scelsero che il bene era l’eliminazione degli ebrei, in una prospettiva atea chi siamo noi per dire che era male? Su quale base affermare sia migliore o più giusta la nostra morale della loro? E più giusta rispetto a quale parametro assoluto?
Lo stesso dicasi per tutte le volte che vorremmo condannare in modo assoluto atti come schiavitù, genocidi e torture: potrebbero essere considerati “giusti” da chi li ritiene “gradevoli e utili” in nome di “disposizioni intrinseche della mente”.
Belardinelli si può sforzare quanto vuole a ripetere che «non c’è più nessun Dio insomma, nessuna provvidenza, nessun criterio oggettivo della morale né del gusto». Ma non si accorge che tagliando l’appiglio metafisico crolla qualunque tentativo di fondamento della morale, condannandosi all’unica posizione coerente: l’amoralità.
Un passaggio che, come dicevamo, è stato compiuto da molti grandi laici, come il filosofo Joel Marks, autore del celebre “An Amoral Manifesto” («Senza Dio, non c’è moralità. Mi sono convinto che l’ateismo implichi l’amoralità»).
La contraddizione di Hume nel “salvare” la morale
D’altra parte, come riporta il libro, lo stesso Hume si accorse dell’impossibilità di una morale a sé stante, laica.
Ecco come Belardinelli riassume il contenuto del volume:
«Aggiungiamo la preoccupazione da parte di Hume e dei nostri autori di “mitigare” in qualche modo lo scetticismo, facendo appello al giudizio di alcuni saggi ai quali per “sentimento universale” viene riconosciuta una certa competenza pratico-estetica, onde evitare di mettere tutti i giudizi di valore sullo stesso piano, assecondando il relativismo di coloro che cantano allegramente “questo o quello per me pari sono”».
Come riconosce Belardinelli, Hume tradisce così il suo impasse, il suo fluttuare (ecco il titolo del libro) tra la negazione di qualunque fondamento oggettivo e trascendente alla morale (pur di negare Dio) al riconoscimento dell’insostenibilità di tale posizione, rifugiandosi nel tentativo di trovare fantomatici “saggi” da seguire.
Ma qui l’incoerenza di Hume esplode a un livello superiore.
Se davvero i criteri morali ed estetici sono solo reazioni soggettive, perché un fantomatico “sentimento universale” sarebbe in grado di stabilire che alcuni individui hanno più autorevolezza di altri? Come si passa dal soggettivo all’universale?
E, soprattutto, chi garantisce che sia più giusto ciò che decide una maggioranza rispetto al singolo? Più giusto rispetto a quale criterio di riferimento?
Ecco che il tentativo di Hume di inventare un principio di autorità per non cadere in un cieco e totale relativismo si rivela una toppa peggiore del buco .
Non biasimiamo certo il celebre filosofo scozzese nel trovarsi immerso nel caos.
Da una parte la tensione di negare Dio e dall’altro, coerentemente, il riconoscimento che non tutto può essere relativo.
Il ricorso a surrogati quali i “saggi” e il “sentimento universale” sono infelici tentativi di ricostruire una stabilità che solo il riconoscimento di un ordine oggettivo (la legge naturale) può realmente garantire.