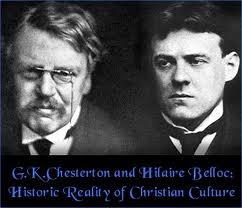Ricognizioni 7 Aprile 2021
di Matteo Mazariol
Parlare di “strutture di peccato” presuppone alcuni chiarimenti concettuali di fondo, senza i quali l’espressione rischia di non essere compresa o, peggio, travisata.
Innanzitutto va esplicitato cosa si intende con “peccato”: secondo il plurisecolare insegnamento del Magistero della Chiesa, il peccato è un libero atto umano (pensiero, azione od omissione) che si oppone consapevolmente ed intenzionalmente alla legge di Dio, così come è percepita dalla nostra coscienza ed appresa attraverso i testi sacri, interpretati alla luce della Tradizione e del Magistero.
Laddove non c’è piena avvertenza e deliberato consenso, per cause interne od esterne, non vi può essere peccato e quindi responsabilità e quindi colpa. Il discorso si fa più complesso quando si parla di peccato sociale. Se il peccato per definizione è un atto individuale, come può essere definito “sociale”? San Giovanni Paolo II nella sua esortazione apostolica Reconciliatio et Paenitentia del 1984 approfondisce l’argomento e ci aiuta a comprendere il senso di tale termine.
Ovviamente il Papa chiarisce che tale aggettivo va inteso in senso analogico e non proprio: non esiste propriamente un peccato sociale in sé ma il peccato individuale può assumere connotazioni “sociali” e questo avviene secondo modalità diverse. Così, per esempio, è possibile riscontrare che un numero consistente di individui, riuniti in determinati aggregati sociali (partiti, sindacati, nazioni) siano accomunati dal condividere collettivamente gli stessi peccati, puntellandosi a vicenda negli stessi, in maniera che tali peccati si presentino sotto una veste sociale e non solo individuale.
Un altro senso in cui può essere utilizzato l’aggettivo “sociale” riferito al peccato è quello secondo cui il peccato dell’individuo in qualche modo ha dei riflessi negativi di vario tipo anche su altre persone, danneggiandone il benessere o la dignità: un esempio classico è il padre di famiglia che commette adulterio e danneggia così non solo se stesso ma anche la moglie e i figli.
Infine, un altro significato del termine “sociale” riferito al peccato consiste nel fatto che questo aggettivo specifichi che gli attori coinvolti nel peccato in oggetto siano appunto “sociali”, si tratta cioè dei peccati che riguardano il comportamento del singolo verso la società, della società verso il singolo od il rapporto tra società, come, ad esempio, nel caso della guerra tra nazioni.
Ovviamente la responsabilità di tali peccati “sociali” anche qui non potrà mai essere attribuita a questi diversi corpi sociali in sè ma alle singole persone che dentro questi corpi sociali agiscono.
Nell’Enciclica Sollicitudo Rei Socialis del 1987, San Giovanni Paolo II riprende e sviluppa questa tematica, precisando che ogni “struttura di peccato” sociale rappresenta il prodotto di due tipologie specifiche di peccato personale: “da una parte, la brama esclusiva del profitto e dall’altra, la sete del potere, col proposito di imporre agli altri la propria volontà”.
La tesi che avanzo in questo breve articolo è che l’istituzione “partito” rientri appieno nella categoria di “struttura di peccato”. Questa tesi può avere un senso nel momento in cui si sia in grado di precisare e spiegare quale sia il tipo di peccato individuale sotteso ed intrinsecamente legato all’organizzazione “partito”.
La risposta a questa domanda a mio parere si trova nelle stesse parole di San Giovanni Paolo II. Che cosa è infatti il partito se non il raggruppamento di tutti coloro che condividono una propria visione del mondo ed hanno la “sete del potere, col proposito di imporre agli altri la propria volontà”?
Non dimentichiamoci infatti che il presupposto di fondo del sistema dei partiti, dal punto di vista della filosofia politica, è una sorta di relativismo contrattualistico, secondo la cui la ragione umana non sarebbe in grado di cogliere universalmente quale sia l’ordine del reale voluto da Dio e pertanto ogni partito avrebbe il diritto di proporne uno, basandosi sul primato implicito della volontà sulla ragione.
Ciò che il partito fa non è proporre singole soluzioni programmatiche a specifici problemi ma indicare contrastanti ed antitetici modelli di società, l’un contro altra armati, destinati a prevalere esclusivamente con l’uso della forza, in questo caso elettorale. I deputati eletti, infatti, non vanno in Parlamento per risolvere i problemi concreti della gente ma per difendere quella visione del mondo che precedentemente avevano proposto ai propri elettori.
In questo modo i partiti finiscono per essere strumenti permanenti di divisione sociale, cristallizzazione della presunta incomunicabilità ed inconciliabilità di prospettive tra loro diverse ed aliene, che vengono ricomposte non con l’utilizzo della ragione ma con il compromesso al ribasso, basato esclusivamente sulle logiche partitiche legate ai rispettivi pesi elettorali.
L’arte della politica, finalizzata allo sforzo condiviso verso il bene comune, si trasforma così nella sua parodia, in un prodotto di laboratorio alchemico, dove ciò che conta sono il peso e la quantità dei diversi elementi di laboratorio. La forma “partito” rappresenta quindi la definitiva vittoria del relativismo contrattualistico tanto caro a Rousseau, negazione di ogni ordine sociale autentico e del diritto naturale che ha la sua origine ultima in Dio.
Il partito, quindi, è la trasposizione politica di quella costante e perenne ribellione a Dio, che sul piano individuale si manifesta con il peccato personale. Questa elaborazione concettuale avviene ovviamente solo in pochi ideologhi, i quali però sono riusciti a conculcare nell’opinione pubblica l’idea che il suo prodotto, appunto l’istituzione partito, sia in assoluto la miglior forma di rappresentanza politica possibile, trasformando così un peccato sociale in una norma universalmente accettata come un bene.
Altro peccato sociale che sta alla base della forma “partito” è quello della inavvertita ma non meno letale sottrazione agli individui ed ai corpi sociali di quelle naturali libertà politiche che li spettano.
Il partito infatti è come se dicesse alle varie componenti dell’organico ed articolato tessuto comunitario: rinunciate ai vostri spazi di partecipazione politica, alla libertà di riunirvi per discutere e decidere tutte le questioni che riguardano concretamente la vostra vita socio-lavorativa, il vostro comparto, ed affidate a me, partito, questo compito così arduo e difficile. Io sarò in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze: non dovrete più occuparvi di nulla, solo di dare a me il vostro consenso attraverso il voto; in questo modo realizzerete il massimo della vostra libertà politica e del vostro benessere economico-sociale.
Ora, una tale pretesa, oltre che essere una palese menzogna, contrasta gravemente con uno dei principi cardine della retta ragione e della Dottrina Sociale della Chiesa, cioè il principio di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà infatti ci insegna che, in un ordine politico rispettoso della legge naturale, ogni realtà sociale intermedia dovrebbe poter godere del massimo di autonomia decisionale ed operativa.
Ovviamente le tesi portate avanti dai sostenitori della ideologia partitica, come sempre accade nel caso del peccato, sono state molto seducenti. La legge Le Chapelier del 14 luglio 1791 rappresentò un pò l’apogeo di un lungo processo che, all’interno di una visione liberale ed illuministica della politica, aveva portato con Locke, padre del liberalismo, all’affermazione della centralità dell’individuo, inteso quale entità sciolta da vincoli organici di natura sociale, economica, lavorativa e politica con la propria comunità.
Tale legge abolì così quello che rimaneva delle secolari gilde o corporazioni di arti e mestieri, quelle istituzioni che, almeno dall’anno 1000, avevano rappresentato il luogo naturale in cui le persone avevano potuto realizzare la dimensione partecipativa della propria esistenza.
Ciò fu fatto ovviamente non dicendo la verità, avviando un processo di massificazione ed atomizzazione della popolazione, di controllo sempre più stringente da parte di quell’oligarchia economico-finanziaria che con la Rivoluzione Francese prese il potere, inalberando i valori supremi e filantropici di libertà, uguaglianza e fraternità.
Chesterton, Belloc e padre McNabb, i fondatori del distributismo, in sintesi, un secolo fa avevano già chiarito che il sistema dei partiti rappresentava lo strumento privilegiato attraverso cui l’oligarchia economico-finanziaria assicurava il pieno controllo. Chesterton ed in particolare Belloc avevano parlato di Stato Servile, cioè di alleanza tra grande Stato e grande capitale, come sviluppo prossimo venturo dell’assetto globale.
Come negare che oggi ci troviamo proprio in questa situazione paventata un secolo fa? Ovviamente non esiste una realtà sussistente “partito” in grado di assumere da sé tale posizione perversa, ma tutti coloro che, consapevolmente o meno, accettano l’istituzione partito – e con essa le premesse che ne sono alla base – di fatto accettano e sono conniventi con questa modalità di pensiero, questo comportamento, questa modalità di porsi verso i vari comparti sociali, questo peccato sociale.
Se non c’è piena avvertenza e deliberato consenso, qualcuno potrebbe obiettare, come fa ad esserci il peccato? Non si tratterebbe quindi di peccato ma di errore sociale. Questa obiezione ha un suo valido fondamento. La Dottrina della Chiesa da sempre ha parlato a questo proposito di “invincibile errore”, cioè della condizione penosa di chi compie atti oggettivamente peccaminosi, senza esserne consapevole, cioè ignorando, totalmente e non per sua responsabilità, di farlo.
Un medico così potrebbe “errare”, somministrando una terapia mortale al proprio paziente senza saperlo, ma se tale errore fosse dipeso, per esempio, da negligenza, imperizia od imprudenza, cioè da fattori legati alla sua libertà e responsabilità, l’ignoranza non sarebbe considerata invincibile ma vincibile e quindi il medico sarebbe ritenuto perseguibile da un punto di vista penale e peccatore dal punto di vista morale.
Allo stesso modo quei politici o quei cittadini che appoggiano la forma partito perché ignorano che essa costituisca una forma di peccato sociale sono scusabili, anche se ciò non li sottrae dalle pene oggettive che derivano dal cadere in questo errore, mentre non sono scusabili quanti, una volta edotti, persistono nel comportamento deviante di appoggiare l’istituzione “partito”.
Sono consapevole di quanto queste considerazioni siano controcorrente rispetto ad un pensiero dominante che ha inculcato nella mentalità comune il dogma della partitocrazia come unica e suprema forma di rappresentanza politica. Chesterton, che sviluppò queste idee all’interno del pensiero distributista, ne era altrettanto consapevole ma diceva che solo un corpo vivo può andare controcorrente mentre uno morto è condannato a seguirla.
Sono convinto che una sana critica dell’istituzione partito, alla luce della visione distributista, profondamente informata dalla filosofia tomista, possa rappresentare oggi una sana ventata d’aria fresca in grado animare il dibattito oggi drammaticamente urgente sulle forme della rappresentanza, a partire da una visione del mondo che non rinunci ai valori fondanti della ragionevolezza e del senso comune e non tema di abbeverarsi alla fonte illuminante della perenne Dottrina Sociale della Chiesa.
Non dimentichiamo infatti che l’opzione corporativa è nata e si è sviluppata per secoli all’interno del mondo cattolico e che la sua eclissi è stata causata non certo dal fallimento delle sue applicazioni o dalla confutazione delle sue basi teoriche ma da un brusco e rapido mutamento delle condizioni geo-politiche a partire dalla fine della II Guerra Mondiale.