di Roberto Pecchioli
Abbiamo bisogno di idee, miti, storie collettive. È un’esigenza permanente della persona umana, ma diventa un’urgenza, l’acqua dell’assetato, al tempo in cui un’unica narrazione ideologica, il liberalismo mercatista nella forma liberista in economia e libertario-libertina sui temi etici e sociali, non soltanto domina il mondo, ma si considera unica, intrascendibile, priva di alternative, addirittura “naturale”.
Chi scrive pensa al comunitarismo come l’idea giusta, la chiave per aprire la serratura del roccioso pensiero unico che sovrasta, inibisce, trasforma tutto in merce, umanità compresa, un prodotto con il cartellino del prezzo e il codice a barre.
 Il comunitarismo condivide con il pensiero della decrescita un nome poco attrattivo. Quando parliamo di decrescita, la colonizzazione dell’immaginario ci fa pensare non all’intelligente autolimitazione, al rispetto per la natura e l’ambiente, al riuso, al riciclo, alla fuoriuscita dal triste paradigma “produci, consuma, crepa”, ma a un mondo primitivo in cui dobbiamo rinunciare alle infinite comodità del sedicente progresso.
Il comunitarismo condivide con il pensiero della decrescita un nome poco attrattivo. Quando parliamo di decrescita, la colonizzazione dell’immaginario ci fa pensare non all’intelligente autolimitazione, al rispetto per la natura e l’ambiente, al riuso, al riciclo, alla fuoriuscita dal triste paradigma “produci, consuma, crepa”, ma a un mondo primitivo in cui dobbiamo rinunciare alle infinite comodità del sedicente progresso.
Il comunitarismo, a sua volta, richiama, nella facile allitterazione, la devastante esperienza comunista. Enormi aspettative, speranze condivise da milioni e milioni di persone deluse da un regime dispotico, violento, incapace di estirpare la povertà materiale, creatore di un deserto spirituale non dissimile da quello del fratello maggiore, il liberalismo.
 Il comunitarismo non è un’ideologia, non si propone l’imposizione di uno specifico modello economico sociale – la cui scelta lascia alla saggezza e alla tradizione di ciascun popolo – è piuttosto una visione generale della condizione umana.
Il comunitarismo non è un’ideologia, non si propone l’imposizione di uno specifico modello economico sociale – la cui scelta lascia alla saggezza e alla tradizione di ciascun popolo – è piuttosto una visione generale della condizione umana.
È una dottrina morale e politica secondo la quale l’individuo può realizzare pienamente le sue capacità morali e le sue qualità politiche solo entro una comunità. Idea antica, introdotta dal maggiore pensatore della tradizione occidentale, Aristotele, nell’Etica Nicomachea e nella Politica, in cui descrive l’uomo come “animale politico”, sociale e comunitario, che si realizza nella convivenza con gli altri, la koinonìa.
Padre moderno del comunitarismo può essere considerato Georg W.F. Hegel, che, nei Lineamenti di filosofia del diritto, enfatizza l’importanza di varie forme di comunità: la famiglia, lo Stato, le corporazioni, i corpi intermedi proibiti dalla rivoluzione francese (legge Le Chapelier).
 Anch’egli, come Aristotele, sottolinea il fatto che le capacità psichiche e le prestazioni etiche non possono manifestarsi compiutamente se non nell’ambito di spazi comuni. La distinzione essenziale è stata individuata da Ferdinand Toennies nella seconda metà del XIX secolo, tra comunità e società.
Anch’egli, come Aristotele, sottolinea il fatto che le capacità psichiche e le prestazioni etiche non possono manifestarsi compiutamente se non nell’ambito di spazi comuni. La distinzione essenziale è stata individuata da Ferdinand Toennies nella seconda metà del XIX secolo, tra comunità e società.
La comunità è caratterizzata dalla volontà naturale (Wesenwille), mentre la società si fonda su legami espressione della volontà razionale (Kurwille). Le due forme di relazioni sociali sono connotate, rispettivamente, dal principi di associazione “organica”, prodotta dalla volontà naturale (comunità) e dall’associazione artificiale-contrattuale (società). La prima sociologia si è chiaramente schierata dal lato della comunità.
L’ esempio è Emile Durkheim, il quale, con una curiosa inversione semantica, parla di solidarietà “meccanica”, allorché la coscienza dei singoli è identificata, immersa nella coscienza comune e di solidarietà “organica”, strumentale, nelle società individualiste.
La solidarietà organica non riesce a opporsi all’antagonismo sociale, produce incertezza e indeterminazione. Ciò conduce all’anomia, l’assenza di norme interiorizzate, obiettivi comuni, carenza di relazioni in cui sussiste impegno reciproco. Poiché l’impegno solidale, organico, è un’esigenza primaria dell’essere umano, bisogna riavvicinare gli esseri umani affinché abbiano il senso di vivere in una società accomunata, ovvero in una comunità.
Per Durkheim l’uomo inserito in una comunità è socialista non in quanto condivide quella dottrina politica, ma perché considera la società un organismo verso il quale ha degli obblighi. Emerge un elemento assai importante: la natura del comunitarismo come tendenza etica interiorizzata.
 Alle comunità si appartiene non per costrizione o norma di legge, ma in quanto ci si riconosce in esse, attraverso un processo di identificazione-appartenenza. Di qui l’incompatibilità con il modello liberale, fondato sulla scelta individuale, l’interesse e la pretesa della neutralità assiologica. Invero, nessuna società è neutrale.
Alle comunità si appartiene non per costrizione o norma di legge, ma in quanto ci si riconosce in esse, attraverso un processo di identificazione-appartenenza. Di qui l’incompatibilità con il modello liberale, fondato sulla scelta individuale, l’interesse e la pretesa della neutralità assiologica. Invero, nessuna società è neutrale.
Nel caso liberale, è semmai indifferente sotto il profilo morale, centrata com’ è sugli interessi economici e strumentali. Il mercato, se elevato a fine, è quanto di più ostile a qualsiasi etica.
Nell’universo liberale non ci sono che individui tesi a scegliere la vita “giusta” per se stessi e solo per se stessi. Il modello è la celebre frase di Adam Smith, secondo cui non è dalla benevolenza del macellaio e del fornaio che otterremo il cibo, ma dalla loro avidità di guadagno.
 A tale criterio contrapponiamo una frase dell’economista Geminello Alvi, per il quale “solo quando la famiglia smette di essere tale si pagano gli alimenti, altrimenti in essa si dona, non si dà alcuna comunità di profitto, che ha il nome diverso di società”.
A tale criterio contrapponiamo una frase dell’economista Geminello Alvi, per il quale “solo quando la famiglia smette di essere tale si pagano gli alimenti, altrimenti in essa si dona, non si dà alcuna comunità di profitto, che ha il nome diverso di società”.
Modello primario di comunità è dunque la famiglia, entro la quale i legami attraversano le generazioni e si fondano sulla collaborazione, la solidarietà e la gratuità. Nulla di più estraneo al modello dominante, il cui metro è lo scambio in denaro. Non esiste morale nel contratto, solo clausole, termini, norne di esecuzione e modalità di rescissione.
Tutt’ al più può sussistere la deontologia, ovvero “come ci si deve comportare”, con riferimento al tornaconto e al ruolo sociale. In una società non si apprezza il senso dell’onore, bensì il “buon nome” commerciale, sino a scendere al culto dell’immagine (ciò che deve trapelare di noi stessi) sino al narcisismo del “look”, ‘aspetto esteriore, cangiante, dettato dalla moda consumista.
 Nella comunità la razionalità è data dall’adesione ai principi, nella società dal calcolo di costi e benefici. La comunità è organica, la società è procedurale, formale. La persona è degradata a soggetto astratto, non inserito in alcun contesto politico e sociale, titolare di diritti codificati e doveri esclusivamente legali.
Nella comunità la razionalità è data dall’adesione ai principi, nella società dal calcolo di costi e benefici. La comunità è organica, la società è procedurale, formale. La persona è degradata a soggetto astratto, non inserito in alcun contesto politico e sociale, titolare di diritti codificati e doveri esclusivamente legali.
Dicevamo della prevalenza nella comunità della dimensione etica, immateriale. Di qui la supremazia dell’idea di Bene su quella di Giusto. Ogni comunità ha un’idea di bene (comune) a cui conforma i suoi comportamenti.
La dottrina sociale della Chiesa inclina a una concezione comunitaria dell’uomo. Così si esprime la costituzione pastorale Gaudium et Spes: “la persona è per costituzione un essere sociale, perché così ha voluto Dio che l’ha creata”.
 Un formidabile siluro contro l’individualismo, che riprende l’enciclica di papa Leone XIII Libertas praestantissimus. “La socialità naturale dell’uomo dimostra altresì che l’origine della società non si trova in un contratto, o in un patto convenzionale, ma nella stessa natura umana; è da questa che discende la possibilità di realizzare liberamente diversi patti di associazione.
Un formidabile siluro contro l’individualismo, che riprende l’enciclica di papa Leone XIII Libertas praestantissimus. “La socialità naturale dell’uomo dimostra altresì che l’origine della società non si trova in un contratto, o in un patto convenzionale, ma nella stessa natura umana; è da questa che discende la possibilità di realizzare liberamente diversi patti di associazione.
Non bisogna dimenticare che le ideologie del patto sociale (il liberalismo e il socialismo N. d. A.) riposano su un’antropologia erronea; di conseguenza, i loro risultati non possono essere – e infatti non lo sono stati – benefici alla comunità, né alle persone.”
Già Edmund Burke, in polemica con la Rivoluzione francese, descrisse la comunità come una convivenza fondatasul “patto non solo tra coloro che sono ancora vivi, ma anche tra i vivi, i morti e quelli che ancora devono nascere”. Comunità è trasmissione, continuità tra le generazioni, proiezione nel futuro. In questo senso, supera tanto le nostalgie del passato quanto la miope concentrazione sul presente.
 Il comunitarismo non pensa che l’uomo sia sempre “homini lupus”, ovvero nemico del suo simile, alla Hobbes. La solidarietà, l’amicizia e la collaborazione devono essere “situate”, sostenersi nel sentimento di appartenenza, radicarsi in un universo in cui si distingue tra “noi” e “loro”.
Il comunitarismo non pensa che l’uomo sia sempre “homini lupus”, ovvero nemico del suo simile, alla Hobbes. La solidarietà, l’amicizia e la collaborazione devono essere “situate”, sostenersi nel sentimento di appartenenza, radicarsi in un universo in cui si distingue tra “noi” e “loro”.
Le comunità assomigliano a cerchi concentrici: si appartiene alla famiglia, alla città, alla nazione, alla professione, alla Patria, alla religione, ai corpi intermedi che oggi vengono confusi con la “società civile”. La comunità mantiene un’origine affettiva, sentimentale, cemento dell’unione.
Non sempre deriva dalla nascita: si può scegliere di appartenere a una comunità. In essa vi sono confini e porte che si chiudono, ma altresì aperture, fenditure allargate al mondo. Soprattutto, una comunità offre un sistema di principi, valori e comportamenti a cui orientare la vita, anche per rifiutarli; il radicamento resta una delle esigenze più profonde dell’animo umano (Simone Weil).
Al comunitarismo si imputano innumerevoli peccati, uno dei quali sarebbe il suo attaccamento ai pregiudizi. Uno dei maggiori pensatori del Novecento, Hans Georg Gadamer, ha rovesciato il concetto. E’ la moderna società a essere prigioniera di un singolare “pregiudizio contro i pregiudizi”.
Gadamer rompe la contrapposizione tra ragione e pregiudizio, ragione e tradizione, ragione e autorità, affermando che la volontà di abbattere i “pregiudizi” è figlia di un pregiudizio sovrastante, quello della ragione, attraverso cui l’uomo si libera dal suo contesto storico-sociale. I pregiudizi sono dunque legittimi giudizi preventivi destinati a facilitare la comprensione del mondo.
Ogni cultura, ogni comunità coltiva e diffonde i propri come griglia interpretativa offerta ai suoi componenti per guidarli. Senza pregiudizi, l’uomo si riduce a una tabula rasa, in preda del potere ed in viaggio verso l’angoscia del nulla. Non vi può essere un’appartenenza “universale”. Si appartiene a una comunità non in contrapposizione, ma rispetto a ciò che è altro da noi.
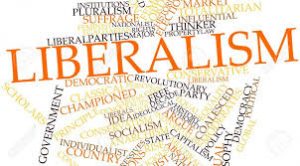 L’individualismo liberale ci lascia soli e nudi, senza bussole, se non quella dell’interesse e di una ragione astratta. Due liberali del passato sono, paradossalmente, i migliori propagandisti della comunità. Josè Ortega y Gasset scrisse: io sono io più la mia circostanza, ovvero tutto ciò che esiste intorno a me, la lingua che parlo, la cultura in cui vivo, il bene e il male che giudico in base a criteri condivisi, cioè “comunitari”.
L’individualismo liberale ci lascia soli e nudi, senza bussole, se non quella dell’interesse e di una ragione astratta. Due liberali del passato sono, paradossalmente, i migliori propagandisti della comunità. Josè Ortega y Gasset scrisse: io sono io più la mia circostanza, ovvero tutto ciò che esiste intorno a me, la lingua che parlo, la cultura in cui vivo, il bene e il male che giudico in base a criteri condivisi, cioè “comunitari”.
Rilevanti sono le osservazioni di Tocqueville nella Democrazia in America, in cui mette in luce che“individualismo è un’espressione recente nata da un’idea nuova. I nostri padri conoscevano soltanto l’egoismo. L’egoismo è un amore appassionato ed esagerato di sé. L’individualismo invece è un sentimento riflessivo e tranquillo, che dispone ogni cittadino a isolarsi dalla massa dei suoi simili”.
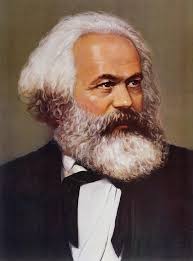 In L’antico regime e la rivoluzione aggiunge: “I nostri padri non conoscevano la parola individualismo,che noi abbiamo foggiata per nostro uso, perché ai loro tempi non v’era in realtà un individuo che non appartenesse ad un gruppo, e che potesse considerarsi assolutamente solo”.
In L’antico regime e la rivoluzione aggiunge: “I nostri padri non conoscevano la parola individualismo,che noi abbiamo foggiata per nostro uso, perché ai loro tempi non v’era in realtà un individuo che non appartenesse ad un gruppo, e che potesse considerarsi assolutamente solo”.
Lo stesso Marx, a cui dobbiamo il termine gemeinwesen, collettività, si esprime così nella Critica del diritto statuale hegeliano: “L’attuale società civile è il compiuto principio dell’individualismo; l’esistenza individuale è lo scopo ultimo: attività, lavoro, contenuto sono solo mezzi”.
Anche per lui la “società” si fonda su individui privati, solitari. Dicevamo che il comunitarismo non prescrive alcuna particolare forma di organizzazione economica. Tuttavia, è indubbiamente estraneo al mercatismo liberale, in cui l’interesse privato e la proprietà privata (quella grande, monopolistica) sono assolutizzati.
Nella comunità esistono beni indisponibili al mercato, i beni comuni. Sono le risorse su cui una comunità vanta un diritto naturale, l’acqua, la terra, i minerali, la conoscenza, la ricerca, alcuni software essenziali. Caratteristica di questi beni è di essere inalienabili, patrimonio indisponibile della comunità che li usa, gestisce, difende e vi si identifica.
 Oggi vi devono essere ricompresi il patrimonio genetico – è immorale la privatizzazione in corso del genoma umano; il DNA non si compravende – taluni contenuti delle piattaforme tecnologiche, i brevetti essenziali per la salute umana ed animale, la fertilità dei terreni.
Oggi vi devono essere ricompresi il patrimonio genetico – è immorale la privatizzazione in corso del genoma umano; il DNA non si compravende – taluni contenuti delle piattaforme tecnologiche, i brevetti essenziali per la salute umana ed animale, la fertilità dei terreni.
La comunità, inoltre, è il luogo in cui si riconosce nell’altro il volto di se stessi: non vi è “politeismo dei valori”, secondo la definizione della modernità di Max Weber. In termini weberiani, è l’unica possibilità di reincanto del mondo, ovvero di una convivenza non fondata esclusivamente sul primato dell’asciutta ragione strumentale.
Nella comunità si diventa ciò che si è, è l’acqua in cui si nuota come pesci, in cui tutto è familiare. Vi si realizza la convivialità, ovvero il con-vivere nel quale i rapporti non hanno bisogno di codici legali o termini contrattuali.
 È altresì il territorio della gratuità, di ciò che viene fatto senza attendersi un corrispettivo. È insieme polis e agorà, piazza, ambito naturale di incontro e dibattito, diverso dai nonluoghi in cui ci si dirige o si transita per convenienza. La comunità non è uno svincolo, un incrocio o un centro commerciale.
È altresì il territorio della gratuità, di ciò che viene fatto senza attendersi un corrispettivo. È insieme polis e agorà, piazza, ambito naturale di incontro e dibattito, diverso dai nonluoghi in cui ci si dirige o si transita per convenienza. La comunità non è uno svincolo, un incrocio o un centro commerciale.
La libertà comunitaria è partecipazione attiva, appartenenza, mentre quella “moderna”, della società anonima (un nome, un programma) è “libertà di andarsene” (Baudelaire), rinchiudersi nel recinto privato, astensione dalla sfera pubblica. Il comunitarismo non è un’ideologia, ma richiede la scelta di ripoliticizzare l’esistenza.
 Nel presente assistiamo a uno svuotamento della più grande delle comunità: lo Stato nazionale. Lo Stato è l’istituzione concreta di un popolo che si riconosce nazione e si costituisce in entità sovrana secondo leggi e principi propri, insindacabili.
Nel presente assistiamo a uno svuotamento della più grande delle comunità: lo Stato nazionale. Lo Stato è l’istituzione concreta di un popolo che si riconosce nazione e si costituisce in entità sovrana secondo leggi e principi propri, insindacabili.
Il liberalismo trasformato in liberismo globalizzato e privatizzazione del mondo odia i limiti. Per questo salmodia la litania dell’abbattere muri e costruire ponti. Tutto serve esclusivamente all’espansione illimitata, alla dismisura eretta a criterio universale. La comunità è innanzitutto metron, misura, limite, come avvertì Costanzo Preve.
In una comunità c’è sempre un nucleo centrale, un’idea forza, qualcosa che non si può mettere ai voti perché è il principio comune dal significato essenzialmente morale. Di questo ha bisogno l’uomo per dare un senso al suo essere nel mondo. Non può essere il consumo, il tornaconto e nemmeno la cosmopoli dell’Identico.
 Per stare in piedi, serve una bandiera, un’idea, un progetto di vita forte e definitivo da consegnare in eredità. Nessuno può vivere e morire per il mercato, il consumo, il contratto. Si vive, si trasmette ai figli e ci si sacrifica per un’idea, una visione, un principio, una comunità.
Per stare in piedi, serve una bandiera, un’idea, un progetto di vita forte e definitivo da consegnare in eredità. Nessuno può vivere e morire per il mercato, il consumo, il contratto. Si vive, si trasmette ai figli e ci si sacrifica per un’idea, una visione, un principio, una comunità.
Nel calderone dell’Unico globale, si è passanti senza meta, capi di bestiame, mens momentanea. Amo la mia patria perché è mia, scrisse uno storico armeno, Stepanos Orbelian. È così: comunitarismo è amore di ciò che è nostro: la mia gente, il panorama visto fin da bambino, la comunità che mi protegge, le parole che designano le cose, le persone, i sentimenti, pronunciate in una certa lingua, le case, i monti, i fiumi, che sono lì da sempre, gli stessi che hanno accompagnato la vita di altri come me.
 Chi si identifica, dà un senso alla vita, possiede un sistema di valori, non confonde fini e mezzi. Per questo siamo convinti che il comunitarismo sia l’idea giusta per uscire dalla mancanza di senso, dal mercato misura di tutte le cose, dall’utile e dal guadagno come criterio unico, dal culto del denaro, dall’atomizzazione sociale.
Chi si identifica, dà un senso alla vita, possiede un sistema di valori, non confonde fini e mezzi. Per questo siamo convinti che il comunitarismo sia l’idea giusta per uscire dalla mancanza di senso, dal mercato misura di tutte le cose, dall’utile e dal guadagno come criterio unico, dal culto del denaro, dall’atomizzazione sociale.
Amo la mia patria, la mia gente, i miei principi perché sono miei e di quelli che mi somigliano. Non compilo graduatorie, non formulo giudizi di superiorità. Il comunitarismo è riconoscersi, non mettersi sul trono. L’idea giusta: noi, ovvero “io e la mia circostanza”.








